“Succession” – HBO torna ai fasti dell’epoca d’oro
A partire dal 13 marzo, su RSI LA1, le prime due stagioni di una serie imperdibile, ispirata alla storia della famiglia Murdoch e al suo impero mediatico
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

A partire dal 13 marzo, su RSI LA1, le prime due stagioni di una serie imperdibile, ispirata alla storia della famiglia Murdoch e al suo impero mediatico
• – Redazione

L'autore spagnolo pubblica in Italia la sua raccolta di saggi, Colpi alla cieca, cronache a tutto campo sul nostro presente
• – Redazione

Dal Ticino mezzo miliardo di franchi all’anno va in acquisti fatti oltreconfine: perché il franco è forte
• – Enrico Lombardi

Nel paese con cui Lugano ha siglato un accordo sui bitcoin, alla radicata e diffusa criminalità organizzata l’autarca Nayib Bukele risponde con la creazione del più grande carcere delle Americhe (e forse del mondo)
• – Gianni Beretta

Potenziare la mobilità collettiva contrastando al contempo il precariato si può - Di Rocco Vitale
• – Redazione

La difficoltà di affrontare il tema della guerra senza finire in uno scontro fra schieramenti, senza poter provare ad immaginare, ragionevolmente, che si debba arrivare alla pace
• – Redazione

A Cutro la squallida sceneggiata del tetro governo Meloni
• – Franco Cavani

Navigando fra egoismo, indifferenza, solipsismo, astensionismo, ovvero la "democrazia del narcisismo"
• – Silvano Toppi

Dopo l’“affaire Berset” alla Ringier si passa alla resa dei conti. Non un bel segnale per il secondo gruppo editoriale svizzero
• – Rocco Bianchi

Negare l’evidenza dei dati statistici e che la crisi salariale sia alla base della crisi sociale del nostro cantone significa garantire che questa continui ad approfondirsi - Di Matteo Poretti
• – Redazione
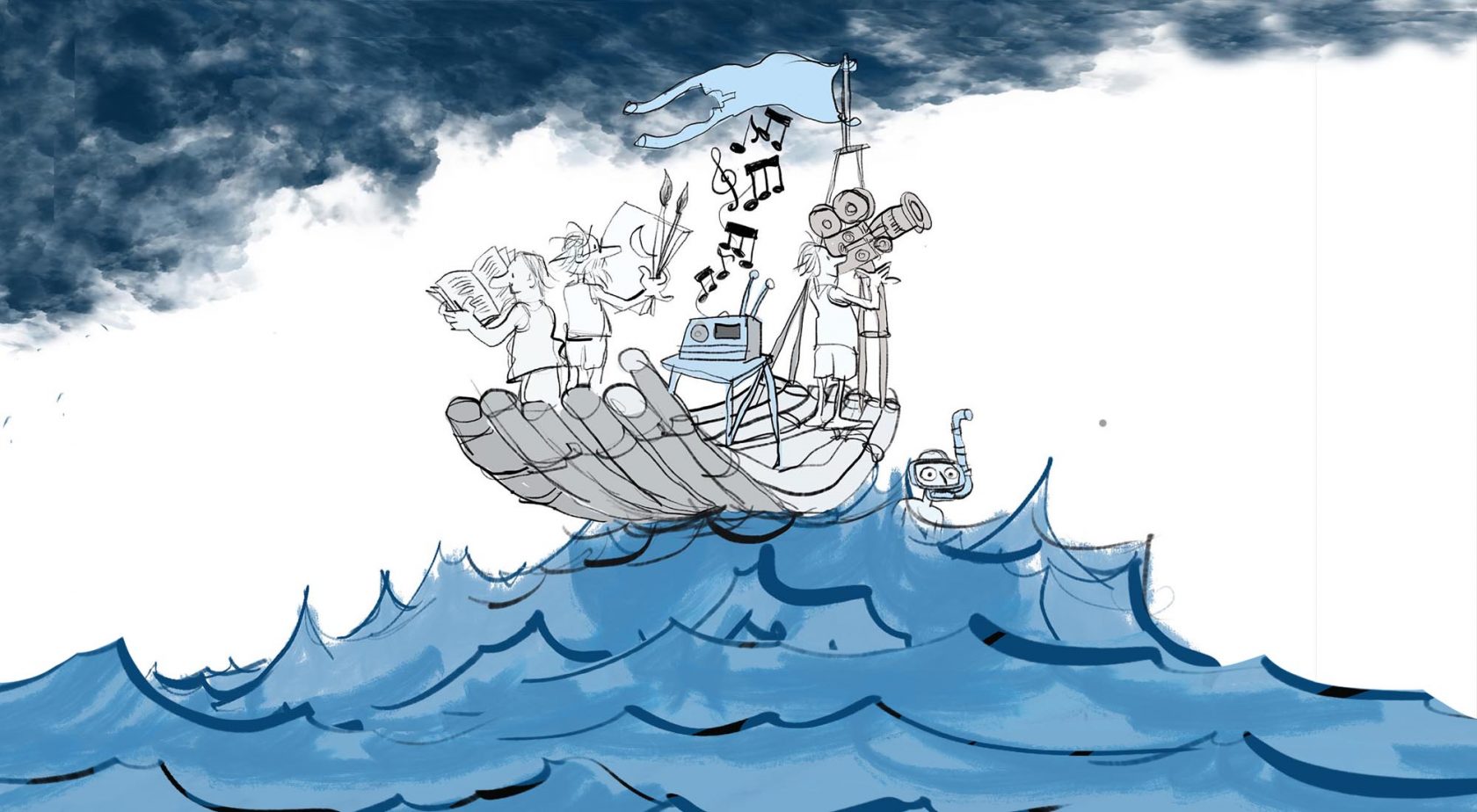
A partire dal 13 marzo, su RSI LA1, le prime due stagioni di una serie imperdibile, ispirata alla storia della famiglia Murdoch e al suo impero mediatico

L’anno scorso HBO ha spento 50 candeline. Un acronimo che per ogni appassionato di serie tv è da almeno un quarto di secolo sinonimo d’incontrastata qualità, rifugio ideale per sottrarsi al piattume di certo intrattenimento di massa, quando non vero e proprio vivaio sperimentale, luogo deputato dove assistere in diretta all’evoluzione del prodotto seriale.
L’emittente via cavo americana è infatti stata la prima a scommettere con continuità su un tipo di serialità adulta, capace di affrontare a viso aperto temi ritenuti scomodi, di sfidare i limiti del rappresentabile e spalancare gli orizzonti del piccolo schermo con una libertà espressiva altrove impensabile. Tra gli alfieri della narrazione orizzontale, la rete ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del medium televisivo, stabilendo un nuovo standard ed elevando il mezzo al livello del fratello maggiore, quel grande schermo storicamente ritenuto più nobile, con cui arriverà a contendersi il ruolo di cartina tornasole della contemporaneità (fino a sconfessare, anche tra gli addetti ai lavori, il vecchio assioma secondo cui il coinvolgimento in un serial segnerebbe la fine di un’altrimenti rispettabile carriera cinematografica).
Tutto ha inizio nel 1997, quando “Oz”, primo one-hour drama della rete, cambia per sempre la percezione di ciò che una volta era chiamato “telefilm”. Benché ancora acerbo dal punto di vista formale, “Oz” rimane uno spartiacque fondamentale: un dramma carcerario crudo e senza sconti, che segnerà un autentico punto di rottura rispetto alla tradizione. Al felice debutto faranno seguito, in rapida successione, titoli entrati ormai di diritto nell’olimpo del piccolo schermo: da “Sex & the City” (1998) ai “Soprano” (1999), da “Six Feet Under” (2001) fino a quella che – a ragione – è tutt’ora considerata da molti il “Quarto potere” delle serie tv, ovvero quel capolavoro irripetibile di “The Wire” (2002).
All’avanguardia sotto tutti i punti di vista (compresa la tanto decantata diversità, che HBO ha praticato con spontanea disinvoltura sin dal principio, ben prima che il termine diventasse un imperativo morale), tra alti e un po’ meno alti, senza mai scivolare davvero in basso, quelle tre lettere maiuscole hanno traghettando il gusto dello spettatore nel terzo millennio, facendo da apripista all’intero ecosistema dei canali a pagamento, che prontamente ne hanno seguito l’esempio con risultati spesso e volentieri eccellenti: FX con “The Shield” (2002), “Nip/Tuck” (2003) e l’ancora troppo sottovalutata “Rescue Me” (2004); AMC con “Mad Men” (2007) e “Breaking Bad” (2008); Showtime con “The L Word” (2004) e “Dexter” (2006).
Complici le leggi della concorrenza, nella prima decade del nuovo millennio si è assistito a un rinascimento della serialità televisiva. Poi nel 2013 è arrivato Netflix con “House of Cards” ed è cambiato tutto un’altra volta. Il panorama è stato stravolto (in termini distributivi, produttivi e di fruizione) e l’epoca d’oro delle emittenti via cavo ha imboccato lentamente il viale del tramonto (tanto che oggi si parla di cord-cutting). Il mondo si è adeguato al nuovo trend e nel giro di qualche anno sono spuntati come funghi i servizi streaming: CBS All Access (poi diventato Paramount+), Apple TV+, Disney+, Peacock e via accumulando (Amazon Prime Video fa discorso a sé).
La stessa HBO ha subito una radicale riorganizzazione in seno al neonato colosso Warner Bros. Discovery (frutto della fusione tra WarnerMedia e il gruppo Discovery) e ha generato una propria costola digitale – HBO Max – che oltre all’ampio catalogo, offre oggi un ventaglio di prodotti originali. Il marchio HBO, un tempo boutique di eccellenza, si è piegato alle leggi del mercato e a sua volta ha cominciato a privilegiare la quantità a scapito della qualità. Nel moltiplicarsi dell’offerta, non sono mancate le perle (“Game of Thrones” colpo di coda dell’era pre-streaming, “True Detective”, le miniserie “Mare of Easttown” e “Chernobyl”, o il recente “White Lotus”), accompagnate però da promesse non mantenute (“Westworld”, “Tokyo Vice”) e qualche raro obbrobrio indegno del marchio che porta (“Rap Shit”).
In un contesto bulimico come quello attuale, dove la battaglia per accaparrarsi abbonati obbliga a sfornare prodotti a getto continuo, è ancora possibile trovare la serie premium che spicca di una spanna sopra alla massa? La risposta è sì, naturalmente. A differenza del recente passato però, occorre andarla a pescare in un mare esageratamente vasto, in cui è fin troppo facile perdere l’orientamento; perché appunto, un’etichetta sulla quale fare affidamento a colpo sicuro, non esiste più. Tra i casi eclatanti degli ultimi anni, c’è senza dubbio “Succession”: il gioiello di cui tutti – HBO, critica e telespettatori – sentivano la mancanza.
Ispirata alla famiglia Murdoch (oltre ad aver lavorato a “The Thick of It”, il creatore Jesse Armstrong ha firmato la sceneggiatura di un film sul celebre tycoon mai andato in porto) la serie racconta le vicissitudini di una famiglia di multimiliardari a capo di un impero mediatico e le lotte di successione scatenate nel momento in cui il patriarca, vecchio squalo del business, inizia a dare segni di cedimento. Le più classiche premesse da soap opera, verrebbe da dire – lusso sfrenato e shakespeariane faide dinastiche – e invece no, perché la qualità della scrittura trascende ogni aspettativa.
Mai prima di “Succession” si era visto un branco di personaggi così triste e meschino, così drammaticamente egoista e nel medesimo tempo specchio verosimile di un mondo in cui potere e denaro sono gli unici metri di misura. Caratterizzazione psicologica e performance attoriale vanno a braccetto con una precisione e una raffinatezza tali che nel giro di poche puntate ci si ritrova intrappolati nel vortice dei Roy, famiglia tanto abbiente quanto disfunzionale, composta da individui spregevoli senza eccezione, al punto che fare il tifo per qualcuno in particolare risulta impossibile.
La rosa d’interpreti non sfugge a una certa tipizzazione, in grado tuttavia di riservare sorprese. C’è il Re – temuto, rispettato ma prossimo al capolinea (un irresistibile Brian Cox) – e ci sono gli eredi al trono: il predestinato debole di carattere, l’astuta calcolatrice, il primogenito inetto e la pecora nera (Kieran Culkin, fratello del più noto Macaulay). Attorno alla corte, gravita poi un serraglio di personaggi altrettanto corrotto e ambizioso; uno stuolo di leccapiedi e avvoltoi, pronti ad azzuffarsi per raccattare le briciole del potere (menzione d’onore al genero idiota, interpretato con sublime efficacia da Matthew Macfadyen). Il tutto per comporre un impietoso affresco di miseria morale intriso di humour nero, che ha sì i feroci tratti della satira, ma affonda salde radici nella realtà del panorama mediatico odierno (oltre ai Murdoch, l’autore si è ispirato ai Redstone di Paramount e ai Sulzberger del New York Times).
Costituisce infine valore aggiunto il fatto che “Succession” sia un prodotto originale al cento per cento, non basato su IP preesistenti. Niente nomi celebri su cui costruire una campagna marketing, niente franchise, cicli di romanzi o videogiochi per beneficiare di popolarità riflessa. “Solo” un sano e solido lavoro di scrittura: quel dramma audace e character driven un tempo tratto distintivo del listino HBO e oggi merce in via di estinzione. Con tre stagioni all’attivo e una quarta ai blocchi di partenza, con una collezione di riconoscimenti tra i più prestigiosi del settore, “Succession” è la prova che in casa HBO non hanno perso il tocco. Come spesso accade in questi casi, allo spettatore non resta che far fronte a un’unica controindicazione: la visione crea dipendenza.

A sette anni dal tragico evento, un notevole film spagnolo mostra come è stato, per gente comune, sopravvivere all'attentato al Bataclan

La storia tragicomica di un comunista svizzero nel nuovo libro di Marco Fantuzzi che completa il suo precedente “Diario d’aldilà” con il recentissimo “Diario d’aldiquà”. Due libri...