Godard e Tanner, la lunga rincorsa
Due figli del '68 tra entusiasmi, dubbi e illusioni
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
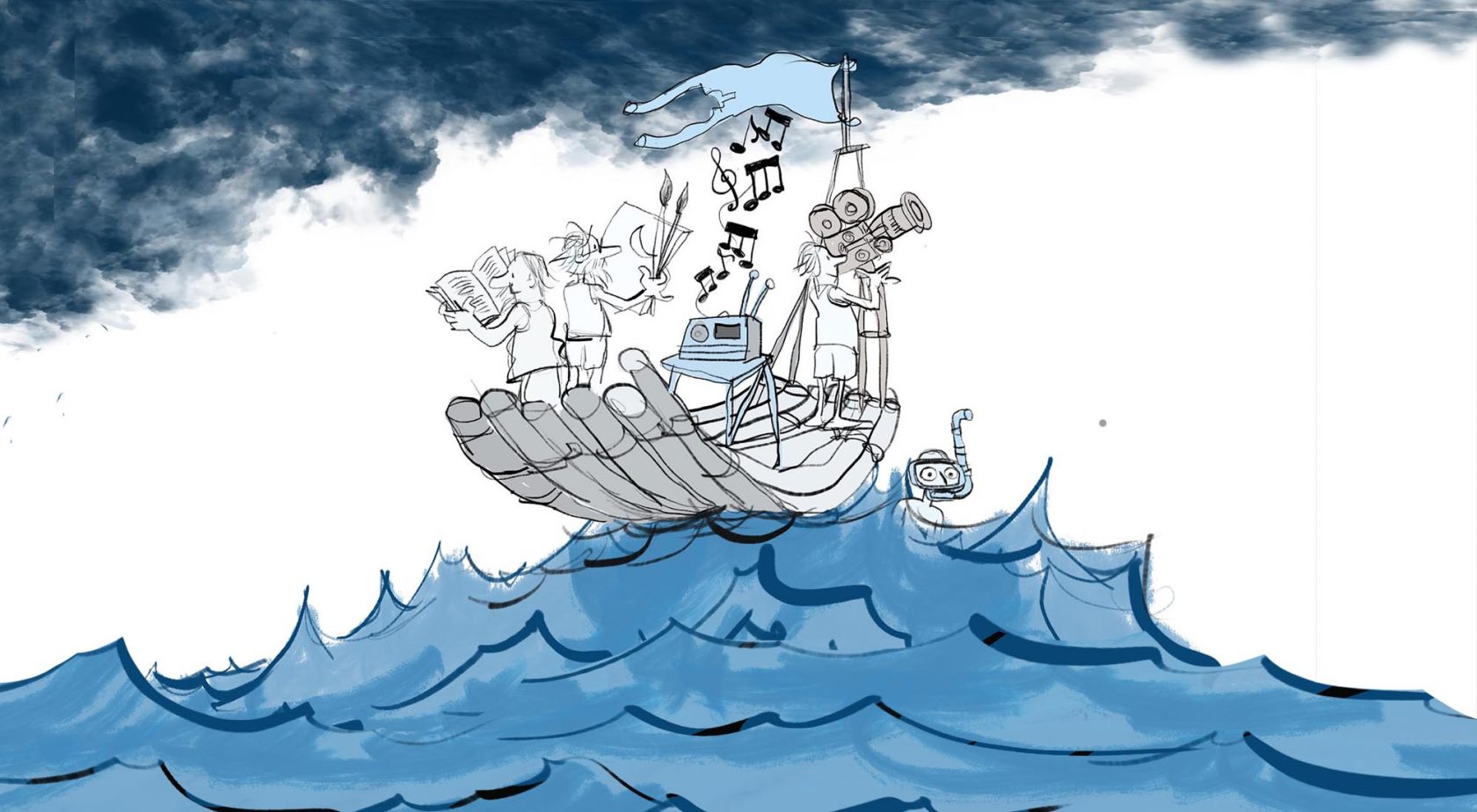
Due figli del '68 tra entusiasmi, dubbi e illusioni

Tanner e Godard a confronto negli studi di Spécial Cinéma (TSR, 1987)
Nati ad un anno di distanza, scomparsi ambedue ultranovantenni a due giorni uno dall’altro, Jean-Luc Godard e Alain Tanner lasciano, oltre alla commozione, un’infinità di riflessioni. Hanno segnato ambedue la loro epoca, non solo il cammino del cinema. La profondità del solco che hanno tracciato non è stata ovviamente identica, ma parallela e altrettanto significativa. Il primo, ha impresso una svolta indelebile e soprattutto universale a quel linguaggio artistico così popolare, ma che era andato incrostandosi negli Anni Sessanta degli straordinari fermenti in atto. Il secondo, ha accolto lo stesso spirito, ma con maggior diffidenza, dapprima in una più contenuta dimensione nazionale. Presto, però, crea a Ginevra con Claude Goretta, Michel Soutter o Jean-Louis Roy l’associazione del “Groupe 5” abbattendo i confini di un paese cinematograficamente inesistente. Cosi tutto finirà per condurlo dapprima al Premio del Festival di Locarno, quindi a Cannes, a Venezia, alle milioni di copie diffuse nel mondo grazie al successo enorme del suo secondo lungometraggio La salamandre (1971). Segnerà allora la nascita di un Nuovo Cinema Svizzero, di un seguito finalmente anche di matrice svizzero tedesca, con i suoi Daniel Schmid, Fredi Murer, Thomas Koerfer…
È l’inizio di un viaggio parallelo che coinvolgerà i due, acquisendo un significato sempre più duraturo. Jean-Luc Godard, che nasce a Parigi nel 1930 finirà per vivere a Rolle acquisendo la nazionalità svizzera; e Alain Tanner, cresciuto nella borghesia ginevrina, scopre il jazz e il neorealismo italiano e s’imbarca a Genova sui cargo mercantili attorno all’Africa. Esisteranno molte similitudini fra i due. Permetteranno di accostarli (non senza le puntualizzazioni velenose fra i due), oltre la dimensione che viene a crearsi tra la parigina Nouvelle Vague con la sua irradiazione nel mondo e la più modesta realtà della trilingue cinematografia elvetica.
Per ambedue i cineasti il film d’avvio sarà già esemplare. Nel 1969 finalmente Tanner firma Charles mort ou vif. È la storia di una rottura. Quella di un industriale ginevrino al culmine della carriera che pianta tutto e tutti, rompendo con il “sistema”. Con la miseria di 120.000 franchi il regista, reduce dalla preziosissima esperienza londinese nel Free Cinema, firma cosi il primo film svizzero maturo, sensibile e significativo. Come notarono subito in Francia, il primo vero film sulla contestazione. E il valore del film nasce proprio da questa contestazione. Il cineasta evita la presa di posizione concitata, l’urgenza risaputa; lo slogan mandato a memoria, meccanico e imbecille. Il suo film, girato in sedici millimetri ma privo, anche nello stile, di certi eccessi anche figurativi che molti sedici millimetri comportano, è una meditazione sorprendentemente matura sulla condizione dell’uomo. E sulla Svizzera di quegli anni. Un film che non è soltanto, come capita di solito in questi casi, un manifesto ma poesia. Tanner dimostra così di sapersi esprimere in modo equilibrato e sensibile, con estrema naturalezza, ai confini dello humour. Con una efficacia per nulla inferiore alle celebri didascalie che Godard aveva nel frattempo introdotte nei suoi film. In perfetta simbiosi, grazie anche all’innegabile fascino donato dal personaggio interpretato dal figlio di Michel Simon, François. Una straordinaria carica emotiva, in un film genialmente equilibrato. Visto il soggetto, considerato il contesto del nostro cinema di allora, un evento che aveva del miracoloso.
Ben nove anni prima, nel 1960, non dimentichiamo che con A bout de souffle Jean-Luc Godard aveva già esplosa la sua personalità prepotente. Cinepresa liberata dalla staticità, dialoghi improvvisati e vissuti sul momento, immediatezza nell’ispirazione ai confini dell’incoscienza, freschezza, anch’essa inimmaginabile, nella direzione divenuta coabitazione degli attori. Pure a prezzo di qualche leggerezza, di non poche ricadute intellettualistiche per taluni gratuite. Questo, però, in un cinema che rappresentava lo sforzo più concreto per liberarlo da tutto l’apparato industriale – finanziario e meccanico che ne soffocava l’ispirazione e la libertà di espressione. Quando Belmondo si volta verso lo spettatore per strizzargli l’occhio, quando ammicca alle espressioni di Humphrey Bogart esposto nelle locandine delle sale sui Champs Elysées è tutta una generazione, una tradizione e di regole stereotipate che improvvisamente crolla. È certamente il primo passo verso una nuova libertà. Quella dell’autore, che diverrà irrefrenabile in un film come ad esempio Pierrot le fou già cinque anni dopo. Ma poi quella, volente o nolente, verso un cinema tutto in divenire, che apparterrà a generazioni di cineasti. Pochi fra loro sfuggiranno alla lezione ed al richiamo della pellicola.
A pochi anni da Charles mort ou vif, siamo ora nel 1971, Alain Tanner ha già consolidato forse per sempre il proprio statuto, affrontando la strada, difficile e delicata come nessun’altra, della semplicità. Cosi, poggiando su un inconfondibile talento, riesce con La salamandre a riproporre la fragile freschezza del film d’esordio. Mescolando la critica dell’indifferenza consumistica svizzera al ritratto di una giovane, ancora libera e umanamente disponibile (una creazione d’indimenticabile facilità da parte di Bulle Ogier), passando dallo humour delicato al sarcasmo corrosivo, all’analisi di costume. I film di Tanner iniziano allora a vivere sulla giustezza del loro tono: facendo propria a questo punto la lezione di Godard. Ma arricchendola inoltre di annotazioni poetiche, liberandola da molti e velleitari cascami intellettualistici. Critica sociale, ma coinvolgendo la poesia. L’esigenza immaginifica, il ritmo del montaggio, i dialoghi, la direzione degli attori conducono tutti ad una delicatezza di tocco, una sensibilità dell’osservazione che, in un senso, contrastano singolarmente con certe rigide strutture della realtà svizzera osservata. Ma in un altro, conducono al contrario ad una poetizzazione delle stesse. È in questa direzione che il cinema di Alain Tanner appare allora come il primo, vero esempio d’espressione cinematografica autenticamente svizzera.
Quanti film ha girato Jean-Luc Godard? Sui centocinquanta, ma il numero nasce in una contabilità stravolta, priva di significato. Dopo la sua comparsa, nessuno al mondo ha più fatto del cinema come prima. I suoi film, sembra un paradosso, sono spesso meno grandi del loro autore. Sono come frammenti di uno specchio prezioso, facile ad andare in mille pezzi. Sono da guardarsi, allora, frammento dopo frammento. Senza che sia necessario (anche perché sarebbe difficile riuscirci) ricomporre il tutto. Fate la prova con una videocassetta: prendetela a caso, partendo da metà piuttosto che dall’inizio, il godimento sarà identico.
A più di sessant’anni da A bout de souffle non è soltanto il pubblico a trovare l’immagine godardiana geniale o insopportabile. Ma la critica stessa, i cosiddetti specialisti, che spaziano dal delirio alla negazione. Perché il cinema di Godard fa apparire non-cinema tutto il resto che ambisce a questa definizione. Oppure, è quello di Godard che dovrebbe essere chiamato differentemente. Altri autori creano personaggi, situazioni, e le abbelliscono cercando di raggiungere dimensioni diverse. Godard continua a filmare un unico soggetto, il cinema. Ed è il suo modo di sfuggire alla solitudine: in questo consiste probabilmente la sua sincerità. La salvezza, da quell’intellettualismo del quale così sovente ne abbiamo fatto il campione, il “Mal vu, mal dit” in quattro segni rappresenta la chiave di tutto il suo cinema. Significarsi attraverso uno sguardo. Riappropriarsi dell’essenza più vera, primitiva, delle cose attraverso uno sguardo reinventato. Basta una mano, messa sullo schermo di un televisore acceso, che prende forma e significato soltanto quando la cinepresa si allontana in carrellata. O una rimessa in questione iperrealista del quotidiano: in una tragicommedia burlesca che trova il suo momento magico, indimenticabile. È possibile che nella carriera di un mostruoso innovatore come Godard ci siano dei momenti discutibili. Ma quando un regista fa passare in pochi minuti i propri personaggi dalla violenza alla sensualità, dalla morte all’amore, è difficile negargli la facoltà di riuscire ciò che è impossibile ai comuni mortali.
Godard ha dapprima contestato le forme tradizionali del racconto cinematografico, il poliziesco, il film di guerra, il melodramma, la commedia. Poi ha fatto del cinema sociologico. E, nel momento della sua piena maturità artistica, da Le Mépris a Pierrot le fou, del cinema semplicemente poetico. Dal quello politico alla sperimentazione in video ha trasformato il linguaggio: piano-sequenza, collage audiovisivo, uso del colore, dialettica della citazione.
Incurante delle finalità consumistiche, dallo spreco forsennato di immagini, dalle telenovelas, teleserials e TV movies varie, il suo cinema (quello con la maiuscola, inteso come uso ragionato, sofferto, talvolta poetico) si rifiuta di morire persistendo nella modernità.
Alain Tanner segue, come abbiamo visto, di una decina d’anni. Godard avrà voltato nel frattempo pagina, si sarà già rifugiato nel suo irruente periodo dei collettivi di un cinema quasi sfacciatamente militante, convinto che i mutamenti politici e sociali introdotti dal Sessantotto debbano fondersi sempre più intimamente con la propria forma cinematografica. E Tanner evolve, ma all’interno di un gruppo che va formandosi in modo meno radicale, influenzato dalle ambizioni della Nouvelle Vague ma adeguato alla modestia dei condizionamenti innanzitutto budgetari. Ma alimentato da uno slancio politico che permetta di sfuggire dallo stagno. Ambedue, nelle loro diversità, evolvono sulle tracce indelebili del Maggio 68. Ambedue sono pervasi dagli entusiasmi, ma anche razionalmente dai dubbi e da certi fallimenti che seguiranno le esaltazioni.
Nel 1976 Alain Tanner gira uno dei suoi film più maturi, Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000. È la storia di otto personaggi che si ritrovano in una grande casa della campagna attorno a Ginevra. Gli ideali sono quelli, ci mancherebbe, invocati dal ’68; ma Jonas, che nascerà nel corso del film, avrà più di vent’anni nel Duemila. I personaggi di Tanner come quelli di Godard si sono allora fatti provvisori, sognano ormai di evadere ma si rendono conto (e con loro gli spettatori, facili indovini) di come l’Utopia (quella di Le milieu du monde o di Jonas) sia svanita con altrettanta evidenza delle illusioni del 68.

L’opera del grande commediografo va in scena ininterrottamente da quasi mezzo secolo nello stesso teatro parigino, è tradotta e rappresentata in tutto il mondo; eppure, del...

Lettere tra Guido e Margherita Tedaldi (1937-1947) in un volume curato da Renato Simoni e pubblicato dalla Fondazione Pellegrini-Canevascini che sarà presentato domani alle 17.00...