Ultraortodossi in rivolta. Ma il vero problema è il militarismo di Israele
L’opposizione e le proteste pubbliche sono diventate una questione di principio anche tra i sefarditi di Shas, storicamente più moderati
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

L’opposizione e le proteste pubbliche sono diventate una questione di principio anche tra i sefarditi di Shas, storicamente più moderati
• – Sarah Parenzo

La recente sentenza che obbliga i giovani ultraortodossi a prestare servizio militare è segno di profonde crepe nella società israeliana
• – Sarah Parenzo

Pensando al grande scrittore nel secondo anniversario della morte: in un momento così tragico, è il caso di riaffidarsi al suo pensiero complessivo capace di traghettare il paese fuori dalla crisi
• – Sarah Parenzo

Dietro e accanto alla rivoluzione di Franco Basaglia in campo psichiatrico sta la figura della moglie Franca Ongaro, una personalità che merita assolutamente di essere considerata nella sua importanza per l’ampiezza degli orizzonti che ha saputo toccare
• – Sarah Parenzo

L’obiezione diffusa della difficoltà di provare empatia e solidarietà per la tragedia del popolo ebraico mentre gli attacchi israeliani si abbattono con ferocia sui palestinesi dimostra anche il fallimento dell’Europa. Le possibili vie d’uscita
• – Sarah Parenzo

Dopo un mese di guerra e di stragi nei due campi, di stanchezza e di dilemmi, la società israeliana si interroga sul ritorno dell’antisemitismo. La lezione di Abraham Yehoshua
• – Sarah Parenzo

Equilibrismo e comprensione dei traumi: l’equipaggiamento dell’osservatore del conflitto israelo-palestinese.
• – Sarah Parenzo

I fallimenti del sistema di sicurezza e la sfiducia degli israeliani. Nulla funziona secondo le aspettative se non grazie all’impegno dei civili
• – Sarah Parenzo

Io Shamur ‘Imadi, sopravvissuta del kibbutz di Be'eri: «Chiedo una pace giusta, che i beduini del Negev ricevano aiuto come la mia comunità»
• – Sarah Parenzo

ORRORISMO. Da opposizioni e sostenitori condanna senza appello. Per mesi l’esercito lo ha avvertito delle criticità: lui ha tutelato soltanto l’ultradestra
• – Sarah Parenzo

L’opposizione e le proteste pubbliche sono diventate una questione di principio anche tra i sefarditi di Shas, storicamente più moderati
Di Sarah Parenzo, il manifesto
«L’esercito ha bisogno di 10mila soldati subito» e l’esercito può «reclutare 4.800 ebrei ortodossi immediatamente», ha detto qualche giorno fa il ministro della Difesa Yoav Gallant dando seguito concreto al passo mosso dalla Corte suprema il mese scorso. I massimi giudici di Israele hanno deciso all’unanimità che non esiste più alcun quadro giuridico che consenta al governo di «concedere esenzioni totali dal servizio militare agli studenti ortodossi delle scuole religiose».
LA QUESTIONE non è solo un problema per la stabilità del governo di Netanyahu sorretto da un’alleanza tra il Likud, i partiti di estrema destra e quelli religiosi ortodossi. Riguarda la società israeliana nel suo insieme e le relazioni tra la maggioranza della popolazione e la comunità ultraortodossa (haredi), con effetti potenzialmente dirompenti per il futuro di quest’ultima.
L’esonero degli ultraortodossi dal servizio militare, insieme ai finanziamenti statali delle yeshivòt, le accademie talmudiche, sono sempre stati temi oggetto di accesi dibattiti all’interno dell’opinione pubblica israeliana da quando, all’indomani della fondazione dello stato, David Ben Gurion accettò di esonerare gli allora circa 400 charedìm in età di leva. Per anni si è parlato di preparativi in corso per il loro arruolamento nelle modalità più svariate, ma, come spiega il giornalista e ricercatore Avishay Ben Haim, si trattava sostanzialmente di un bluff mentre, tra proroghe di legge e compiacenza delle autorità, il privilegio si passava da una generazione all’altra.
Dopo un ping pong di alcuni mesi con il governo, tuttavia, lo scorso giugno l’Alta Corte di Giustizia ha emesso all’unanimità una sentenza in base alla quale non sussisterebbe più alcun quadro giuridico tale da giustificare la decennale pratica di esenzione. Contestualmente la Corte ha vietato al governo di proseguire il finanziamento a favore delle yeshivòt i cui studenti abbiano ricevuto l’esenzione, intimando anche all’esercito di attivarsi immediatamente. Il provvedimento ha mandato in escandescenze l’intero mondo ultraortodosso, i cui leader da settimane radunano folle di manifestanti inferociti che si dichiarano pronti a morire o a lasciare il paese, piuttosto che cedere al ricatto. Inoltre, sulla scia della pressione esercitata dai giudici, questo martedì il ministro della difesa Yoav Gallant ha approvato un piano per dare inizio all’arruolamento degli ultraortodossi, aggiungendo ulteriore benzina al fuoco.
PER FORNIRE un’interpretazione degli avvenimenti in corso è necessario operare considerazioni di ordine diverso. Per quanto riguarda il punto di vista laico, verosimilmente Ben Gurion aveva sottovalutando la crescita demografica che oggi fa degli ultraortodossi il 12% circa della popolazione del paese, ma soprattutto il settore più prolifico, con una media di circa sette figli a famiglia.
SE SI RIVOLGE lo sguardo ai sionisti, religiosi compresi, è inoltre comprensibile che il peso di oltre nove mesi di combattimenti su diversi fronti, sulle spalle di soldati e riservisti, abbia avuto tra le conseguenze quella di evidenziare drammaticamente l’eccezione di cui godono gli ultraortodossi nella società, riportando urgentemente all’ordine del giorno la necessità che anche loro si facciano carica dell’onere militare sia per ragioni morali, che per motivi pratici. Un’inversione di tendenza si registra invece nella società ultraortodossa che, seppure in sordina, con l’apertura a internet e al mondo del lavoro aveva fatto dei passi avanti anche verso l’esercito anche grazie a plotoni speciali di combattenti o al programma “KodKod” che forma i giovani per prestare servizio nelle unità di elite dell’intelligence, regalando loro un prezioso futuro lavorativo nell’industria dell’hi-tech.
LA PROSPETTIVA di raggiungere alti stipendi per mantenere le loro numerosissime famiglie può fungere da incentivo non indifferente a superare la riprovazione della loro società che formalmente mette ancora lo studio della Torah al primo posto. Resta il fatto che, sino a poco tempo fa, solo i membri del Peleg Yerushalmi, frangia estremista dell’ebraismo ultraortodosso lituano, rifiutavano di presentarsi all’ufficio di leva anche solo per ricevere il rinvio ufficiale. Ora, invece, l’opposizione e le proteste pubbliche sembrano diventate una questione di principio persino tra i sefarditi di Shas, storicamente più moderati e, seppure in modo ambiguo, vicini al sionismo. Questo cambio di rotta potrebbe essere da attribuire anche al fatto che gli ultraortodossi si sentono presi di mira dal resto della popolazione che li conosce molto poco, e che la questione della leva sembra diventata la posta di un gioco di scacchi tra Netanyahu e i suoi rivali, tanto i giudici della Corte suprema, quanto il ministro Gallant il quale, pur provenendo dal Likud, non perde occasione per segnare punti contro il primo ministro.
SENZ’ALTRO, come diceva il saggio professor Leibowitz già negli anni Sessanta, il connubio governo-religione, che conduce i politici laici a finanziare le accademie rabbiniche per comprarne i voti, è una piaga da sanare e che ormai scontenta tutti. Bene dunque cominciare dal taglio dei finanziamenti, ma non ci sono altre forme per responsabilizzare la società charedì senza snaturarla, demonizzarla o peggio sfruttarla? In uno scenario ideale sarebbe auspicabile invertire la tendenza militaristica del paese, optando per una soluzione politica pacifica che garantisca la reale sicurezza di tutti i cittadini nel lungo periodo, se non altro affinché l’unico denominatore comune tra i diversi settori della popolazione ebraica non si riduca alla comunque indifferenza verso il destino dei palestinesi. Ma la partita sembra essere ancora lunga ed è troppo presto per prevederne l’esito.
Nell’immagine: Israele, una protesta di ultraortodossi a Bnei Brak
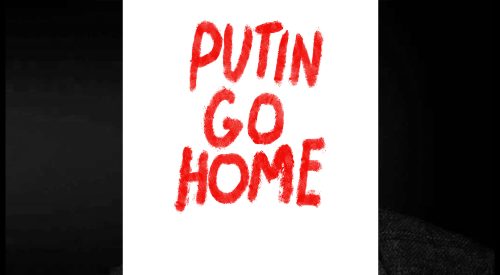
Quelli che organizzano le manifestazioni per la pace quando il Cremlino è in difficoltà e ancora non hanno invocato “Putin go home”

Aspettare la fine del 2026? No, il Consiglio federale dovrebbe solo approvare al più presto un regolamento che anticipa il pagamento senza conseguenze insostenibili