La parola “patria”
Un discorso del Primo agosto a Brusino Arsizio
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
Per prima cosa vi ringrazio molto dell’invito che, non lo nego, in un primo tempo mi ha spiazzato: proprio io, che ho vissuto più o meno sempre da „straniera“ in Italia come in Svizzera, dovrei parlare di patria il primo d’agosto?
Poi mi sono detta: Perché no, anche questa è la mia casa, anche la Svizzera, anche Brusino, dove ho molti ricordi d’infanzia, dove mio nonno, che passava l’estate qui, usciva in barca e poi portava a mia nonna il pesce comprato in paese fingendo di averlo pescato lui. Ho deciso però, visto che sono stata invitata a tenere l’allocuzione nel giorno dell’anniversario della patria, di parlare proprio della parola “patria”.
Patria è per me una delle parole più problematiche dell’intero vocabolario. Lo è sul piano professionale (e anche personale). Sono traduttrice dal tedesco e per mestiere ragiono continuamente sul peso delle parole. Quando traduco la parola tedesca “Heimat”, nel cui contesto confluiscono, oltre alla tradizione politica della parola “Vaterland” (letteralmente “Patria”), anche le connotazioni emotive legate alla tradizione romantica della casa come focolare domestico, se ho la possibilità di scegliere e il contesto di riferimento non è quello del nazifascismo, cerco di non usare “Patria”.
La parola “Heimat” infatti, pur essendo passata (come patria) attraverso il tritacarne del nazionalsocialismo – le parole cambiano significato, durezza e sostenibilità, a seconda delle epoche storiche e questo vale anche per la Svizzera “neutrale” –, ha riconquistato con il passare degli anni quel significato più largo, non politico, non ideologico, quell’idea di radici, che aveva in origine e che la parola italiana “patria” non ha.
“Se dico patria (Heimat) mi viene subito in mente una bandiera” diceva Max Frisch nel 1974, nel discorso tenuto in occasione dell’assegnazione del premio Schiller. La bandiera, che unisce chi appartiene a una stessa Patria ma esclude chi non si riconosce nella bandiera, lo straniero. Così vedeva le cose Frisch in quegli anni, quando di stranieri in svizzera cominciavano ad essercene molti, troppi per qualcuno.
Anche Mariella Mehr, scrittrice svizzera di origine Jenisch (che ho tradotto e di cui sono stata amica), ex vittima della sciagurata opera assistenziale della Pro Juventute «Kinder der Landstrasse» e morta un anno fa, apparteneva alla Svizzera anche se questa l’aveva considerata una figlia degenere. Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Basilea, Mariella disse che si sarebbe trasferita in Italia e che avrebbe voluto diventare apolide per sottrarsi alla nazione matrigna che l’aveva perseguitata e umiliata. Non l’ha fatto.
Anni dopo è rientrata a Zurigo, che era la sua Heimat, la sua casa, ma non la sua patria. Eppure Patria è anche “il territorio al quale ciascuno sente di appartenere”, si legge sul vocabolario Treccani. Forse la questione è davvero, come diceva Frisch nel discorso citato sopra: “Abbiamo una patria solo quando l’amiamo? E se lei non ci ama, allora non abbiamo più una patria?”
No l’appartenenza a una nazione oggi, a dispetto delle correnti sovraniste che attraversano l’Europa, è più che mai qualcosa di fluido e soggetto a contaminazioni. Ma il fatto di essere nati e/o cresciuti in un determinato paese ci rende parte di una comunità (o di più comunità), di un territorio (o di più territori) ai quali siamo sentimentalmente legati e nei confronti dei quali abbiamo delle responsabilità.
L’appassionato, ironico, a volte dissacrante esercizio della critica è il modo in cui gli scrittori (quelli svizzeri in particolare), si prendono cura e si assumono le proprie responsabilità nei confronti del proprio paese. Questo è quanto rivendica Max Frisch nel suo discorso Die Schweiz als Heimat? ma è anche quello che fa Dürrenmat nel discorso del 1991 Die Schweiz als Gfängnis o Mariella Mehr nel discorso del 1998 Von Mäusen und Menschen. Tutti loro sono legati al proprio paese anche se non si riconoscono nella parola patria.
Dicevo all’inizio che c’è anche una ragione personale per la mia difficoltà con la parola Patria. Sono nata a Zurigo nel dicembre del 1959 ma già quando avevo 8 mesi i miei genitori si sono trasferiti a Lugano da dove saremmo dovuti partire per la Costa d’Avorio, ex colonia francese che aveva ottenuto l’indipendenza nell’agosto 1960. Mio padre, che aveva vissuto in Africa da ragazzino, aveva già una promessa di lavoro.
Con la morte di mio padre in un incidente aereo dell’esercito svizzero nell’ottobre del 1960, il progetto naufragò e mia madre rimase, come diceva lei, “inchiodata” alla Svizzera, un paese al quale attribuiva, proprio in quanto “patria”, la colpa della morte del suo giovane marito. Mia madre e io vivevamo dunque contro l’idea di patria che in quegli anni per la Svizzera era più che mai incarnata nell’esercito.
Ricordo di aver dovuto pronunciare la parola patria in seconda elementare quando, per l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico di Pregassona, abbiamo cantato il “salmo svizzero”. Ricordo bene il disagio che non era dovuto solo in quel caso alla posizione straziata e un po’ ideologica di mia madre, ma anche alla mia personale difficoltà con la radice della parola patria che mi ricordava evidentemente l’innominabile parola “padre”.
Oggi qui mi sento a casa, qui sono le mie radici, (anche a Brusino, a poche centinaia di metri da qui dove c’è la darsena di mio nonno), ma avendo vissuto per più di trent’anni a Pavia, anche quella è la mia casa e tutt’oggi non riesco a decidere di stare in un posto solo. Non sono né solo svizzera né solo italiana e la parola “patria” mi chiude dentro un’identità o mi mette fuori dall’altra, questa è la mia sensazione.
Ho scoperto però recentemente, nel mio studio intermittente e disordinato della bibbia e dell’ebraico una parola che mi piacerebbe lasciare qui, a Brusino, sull’acqua, accanto alla parola patria, una parola-rifugio per quando uno si sente chiuso dentro o fuori: si tratta di Tevà che significa “Arca”, un “mero strumento di galleggiamento”, dicono i commentatori, per affrontare il diluvio, e più in generale i momenti di crisi.
Tevà è una barca senza timone.
Ma Tevà significa anche “parola”.
Anna Ruchat è scrittrice e traduttrice
Nell’immagine: il lago davanti a Brusino
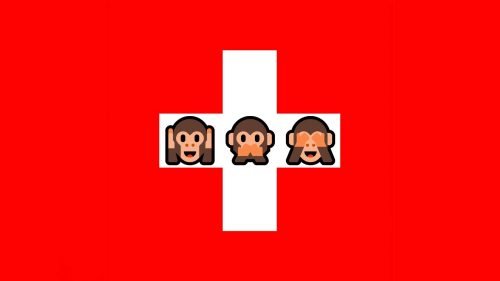
I Verdi chiedono al ministro Cassis una misura urgente - Di Samantha Bourgoin e Marco Noi

+170 convogli al giorno fra Genova e il Nord Europa. Da dove passeranno? - Di Bruno Storni