Seychelles: un paradiso terrestre con un lato oscuro
Secondo recenti dati le Seychelles sono il paese con il più alto consumo pro capite di eroina al mondo
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Secondo recenti dati le Seychelles sono il paese con il più alto consumo pro capite di eroina al mondo
• – Roberta Bernasconi

Centinaia di minori provenienti da Marocco e Algeria, vittime del traffico di esseri umani, sono costretti a vendere droga nelle principali piazze europee. A rivelarlo un’inchiesta del Guardian
• – Roberta Bernasconi

Il Madagascar è oggi il principale fornitore di zaffiri per le marche svizzere di gioielli e orologi, come Cartier o Gübelin. Ma lo Stato malgascio e le decine di migliaia di piccoli minatori che li estraggono difficilmente beneficiano di questa preziosa risorsa
• – Roberta Bernasconi
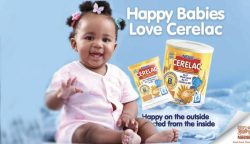
Un’inchiesta svela il doppio standard di due marchi di alimenti per bambini: in Europa niente zuccheri aggiunti; nel Sud del mondo, la dolce addizione servita contro tutte le indicazioni dell’OMS
• – Roberta Bernasconi

I rifiuti elettronici aumentano, e così le loro implicazioni. Redditizio il business dei rifiuti illegali: il Ghana tra le prime destinazioni
• – Roberta Bernasconi

Un paradosso, e una vergogna, segnalati anche nell’ultimo report delle Nazioni Unite: bisogna sfamare le persone, non le discariche
• – Roberta Bernasconi

Si arricchiscono sempre di più gli sfruttatori del lavoro forzato: i guadagni maggiori vengono dallo sfruttamento sessuale
• – Roberta Bernasconi

Nel mondo muore alla nascita circa il 10% dei bambini. Una situazione terribile che colpisce in particolare diversi Paesi del continente africano. Ma recenti nuovi programmi di ricerca paiono dare segnali di speranza
• – Roberta Bernasconi

L’incontro con una donna di Nairobi, in Kenya, con una storia di vita e di resistenza che nel silenzio è capace di segnare una possibile via di cambiamento in tutto il continente
• – Roberta Bernasconi

L’emblematica e tristemente esemplare testimonianza di Fatimah, donna keniana che racconta della sua presunta “colpa” di avere una figlia disabile
• – Roberta Bernasconi

Secondo recenti dati le Seychelles sono il paese con il più alto consumo pro capite di eroina al mondo
Le Seychelles, un arcipelago situato nell’Oceano Indiano, sono spesso celebrate come un modello di successo tra gli stati africani, per sicurezza sociale, partecipazione democratica e sviluppo umano. Tuttavia, dietro questa facciata idilliaca si nasconde una realtà preoccupante: il Paese registra il più alto consumo pro capite di eroina al mondo.
Secondo un recente sondaggio di Afrobarometer, il numero di consumatori di eroina nelle Seychelles è più che quadruplicato negli ultimi anni, passando da 1.200 nel 2011 a circa 5.000-6.000 nel 2019. In altre parole, quasi il 10% della popolazione in età lavorativa è dipendente dalla droga. Oltre all’eroina, anche altre sostanze stupefacenti stanno diventando sempre più comuni. La cannabis è ampiamente consumata e l’uso di droghe come crack, cocaina e metanfetamine è in costante aumento.
Il contrasto al consumo di droghe è considerato il secondo problema più urgente del Paese, secondo solo alla gestione dell’economia. Le Seychelles hanno effettivamente implementato leggi severe e programmi di riabilitazione. In particolare, la Divisione per la Prevenzione, il Trattamento e la Riabilitazione dell’Abuso di Sostanze (DSAPTR) sta affrontando la situazione con una serie di programmi specifici. L’impegno dello Stato in questa lotta è noto ed emerge chiaramente dalle risposte dei cittadini al primo sondaggio di Afrobarometer condotto nel paese.
Molti cittadini ritengono che il governo stia facendo un lavoro dignitoso nel contrastare l’abuso di droga, sebbene le opinioni su come procedere siano divise. Alcuni citano l’intensificazione degli sforzi per ridurre il traffico di droga e l’applicazione di severe sanzioni per i consumatori come le strategie più efficaci. Altri hanno sollevato preoccupazioni per il comportamento della polizia nei confronti dei consumatori di droga all’interno della società civile. C’è il timore che le Seychelles possano adottare un approccio di “tolleranza zero”, penalizzando i consumatori anziché fornire loro assistenza.
Tuttavia, la questione delle droghe nelle Seychelles non è solo una responsabilità nazionale. La posizione geografica dell’arcipelago lo rende estremamente vulnerabile al traffico di droga. E la corruzione legata al narcotraffico rappresenta un ulteriore ostacolo. Nondimeno, il problema delle droghe non riguarda solo le Seychelles, ma tutto il continente africano. L’ultimo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine (UNODC), il World Drug Report 2024, recentemente pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro la droga, evidenzia come negli ultimi anni l’Africa stia registrando una crescita costante dei traffici e del consumo di sostanze stupefacenti. I Paesi africani, non tradizionalmente situati lungo le principali rotte del traffico di droga, stanno diventando sempre più bersagli per il transito di cocaina, eroina e metanfetamine.
Non è tanto l’aumento rapido del consumo di cannabis a sorprendere (e preoccupare), bensì quello di cocaina ed eroina. Queste droghe, prima considerate solo di transito, sono ora sempre più consumate localmente. L’eroina continua a portare un numero considerevole di persone a sottoporsi a cure nell’Africa settentrionale e orientale, e in alcune parti dell’Africa meridionale. L’uso di miscele conosciute con nomi come “kush”, “karkoubi” o “nyaope” è un fenomeno crescente e preoccupante, contenendo diverse sostanze nocive, droghe illecite e solventi. L’UNODC esorta i governi africani a investire di più nella ricerca e nella prevenzione, per affrontare quello che viene identificato come un crescente problema di salute pubblica nel continente.
Nell’immagine: un consumatore abituale di eroina riceve una dose di metadone (da un documentario della BBC)

Sembra non volersi spegnere il “dibattito” intorno ai presunti indottrinamenti dell’agenda scolastica da oggi nelle aule (ma non tutte): e se prima di parlarne la si leggesse?

Fra interessi privati e pubbliche virtù, una proiezione virtuale ci prefigura un futuro virtuoso. Ma porsi qualche domanda resta lecito?