Ci sono poesie in cui l’io lirico o narrante, per quanto sia grammaticalmente presente, sembra nascere immediatamente come un «noi». È una specie di miracolo che in Vittorio Sereni si realizza sempre, con estrema naturalezza, anche quando ci si trova di fronte a occasioni personalissime: un ambiente domestico, un incontro conviviale, l’evocazione di una persona morta, una vacanza estiva, la partecipazione da spettatore a un evento sportivo, un ricordo amoroso, un viaggio.
Questo significa che l’esperienza del soggetto — i suoi luoghi, i suoi affetti — è talmente elaborata e sofferta da sbocciare subito, nell’incontro con la parola poetica, in una dimensione altra, universale. Ci vuole tempo, perché questo accada. E Sereni il tempo se l’è dato, se è vero che i suoi libri di poesia, in quarant’anni, sono non più di quattro: Frontiera (1941), Diario d’Algeria (1947), Gli strumenti umani (1965), Stella variabile (1981). Una produzione molto compatta e coerente, ma insieme piena di variazioni e movimenti interni, specialmente nel passaggio dalle prime due alle ultime due raccolte.
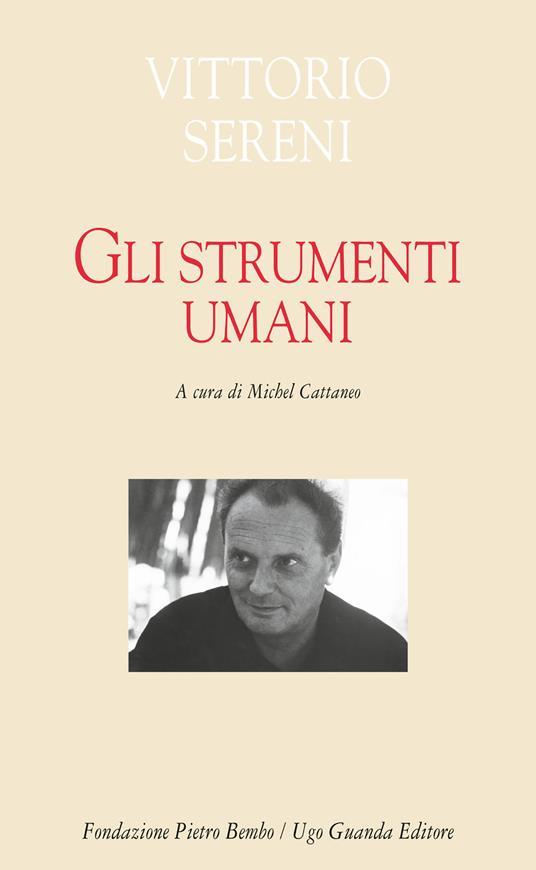 La svolta più netta si verifica con Gli strumenti umani, come mostra, nel solco di studi fondamentali come quelli di Pier Vicenzo Mengaldo e di Dante Isella, l’edizione commentata a cura di Michel Cattaneo appena apparsa nella prestigiosa collana della Fondazione Pietro Bembo (Guanda). L’importanza e la bellezza della raccolta einaudiana (prima edizione 1965 nella collana dei «Supercoralli», seconda edizione 1975 nella «Bianca») sono tali che la svolta riguarda sì l’itinerario individuale di Sereni, ma finisce per interessare più in generale l’intera storia della poesia italiana novecentesca. Ed è una svolta lenta, che si sviluppa a partire dal 1945, anno a cui risale la prima composizione in vista del libro, fino all’epoca della ricostruzione, del boom economico, della nascita dell’industria culturale e della crescita neocapitalistica.
La svolta più netta si verifica con Gli strumenti umani, come mostra, nel solco di studi fondamentali come quelli di Pier Vicenzo Mengaldo e di Dante Isella, l’edizione commentata a cura di Michel Cattaneo appena apparsa nella prestigiosa collana della Fondazione Pietro Bembo (Guanda). L’importanza e la bellezza della raccolta einaudiana (prima edizione 1965 nella collana dei «Supercoralli», seconda edizione 1975 nella «Bianca») sono tali che la svolta riguarda sì l’itinerario individuale di Sereni, ma finisce per interessare più in generale l’intera storia della poesia italiana novecentesca. Ed è una svolta lenta, che si sviluppa a partire dal 1945, anno a cui risale la prima composizione in vista del libro, fino all’epoca della ricostruzione, del boom economico, della nascita dell’industria culturale e della crescita neocapitalistica.
Il tutto in parallelo con una vicenda biografica che, dopo il sodalizio giovanile con il gruppo del filosofo Antonio Banfi e il giro di «Corrente» (la poetessa Antonia Pozzi, il filosofo Enzo Paci, il critico Luciano Anceschi), registra il ritorno dalla guerra (Sereni visse i due anni di prigionia in Algeria e in Marocco con il senso di mortificazione e di rabbia di chi era rimasto tagliato fuori dalla storia), l’insegnamento a Milano, l’impiego nell’ufficio pubblicità della Pirelli e l’entrata in Mondadori come direttore letterario. Senza dimenticare l’esperimento di «Questo e altro», la rivista non solo letteraria che tra il 1962 e il 1964 aveva tenuto insieme amici intellettuali, scrittori, poeti e artisti di varia provenienza e ispirazione, dal giovane Raboni al poeta-ideologo Fortini, dal filologo Isella al critico Pampaloni. Lo sfondo in cui nascono, per varie tappe e intrecci, le 52 poesie che confluiranno ne Gli strumenti è questo, vivacissimo di rapporti e relazioni, ancora animato di illusioni e speranze legate alla memoria della Liberazione, cui peraltro Sereni non poté partecipare sentendosene il rimorso.
In realtà, la personalità di Sereni dovette fare i conti con quel «complesso di sterilità» emerso a più riprese nel ventennio che porta dal 1945, cui risale il componimento più antico del volume, Via Scarlatti, fino all’ultimo testo entrato in extremis nella silloge, e cioè Pantomima celeste, dell’agosto 1965. Una specie di paralisi cui il poeta accenna più volte, scrivendo all’amico Umberto Saba già nel 1946 e al compagno d’università Anceschi nel 1952, quando allude a ragioni psicologiche ma anche materiali e collettive evocando lo spaesamento, vissuto al ritorno dalla guerra, in un mondo mutato e incomprensibile. Eccolo là il «poeta dell’insicurezza, dell’identità minacciata», sempre in bilico sul silenzio se non sull’afasia: «Oggi come oggi, — scrive a Betocchi sempre nel 1952 — ho quattro poesie appena passabili: le altre le ho in mente, ma mi mancano versi, parole, tutto». Non a caso, con questa consapevolezza, Sereni sceglierà di intitolare Un lungo sonno la serie poetica con cui nell’agosto 1956 parteciperà al Premio «Libera Stampa» di Lugano (che vincerà), primo nucleo di ciò che sarà quasi un decennio dopo Gli strumenti umani.
«Sembra — scriverà a Bertolucci nel maggio 1960 —, ma tremo nel dirlo, che io abbia ripreso ormai stabilmente a scrivere. Mi basterebbe finire sei o sette cose e avrei il libro pronto». È uno slancio di ottimismo coincidente con un progetto, testimoniato da un documento siglato Piano generale…, per un libro futuro in quattro sezioni che riunisca i testi già editi in sedi varie, compresi quelli delle prime due raccolte. Le novità che Sereni va rimuginando, particolarmente a partire dal 1961 una volta uscito dal «punto più fondo dell’abbattimento», si inseriscono solo parzialmente in quella che Anceschi ha definito «linea lombarda», di cui peraltro lo stesso Sereni è stato individuato come capostipite e maestro. Lo scrive con grande chiarezza Mengaldo, quando segnala, nella sostanziale «pariniana volontà di dialogo e presenza morale», l’estraneità del poeta luinese alla tradizione di realismo estremo e fortemente espressionistico della poesia lombarda, sottolineando piuttosto la naturale ritrosia dell’uomo e dello scrittore, la tendenza al riserbo e all’attenuazione, insieme con il rifiuto di ogni forma di attivismo diretto.
È dunque nel segno di un personalissimo equilibrio tra partecipazione ed estraneità alle cose che si forma la nuova poesia di Sereni, una volta dismesse le primitive implicazioni ermetiche maturate con gli amici fiorentini. La «rottura con il passato» ha riverberi soprattutto stilistici che sono stati evidenziati in studi importanti: la spinta verso il parlato, una nuova e inedita solidarietà con la prosa e con la dimensione narrativa, la sintassi nominale, l’iterazione, cioè la ripetizione e la ripresa come modulo ricorrente, la tendenza al dialogo con un interlocutore immaginario che sembra la voce sdoppiata del poeta in conflitto con sé stesso. Ma anche l’inserimento di voci altre, come avviene nel famoso poemetto Una visita in fabbrica, tipica «scrittura nell’esperienza» suggerita, come da titolo, da una visita all’impianto milanese della Pirelli, in cui si registrano brani di discorso diretto che sembrano raccolti dalla bocca degli operai. In questa prospettiva nascono poesie indimenticabili, veri e proprio pilastri della poesia del dopoguerra (su Ancora sulla strada di Zenna è annunciata per Carocci una lettura di Christian Genetelli), dove la discrezione, le incertezze e le crisi individuali diventano parte di una storia molto ampia e collettiva fotografata (filmata quasi) nel passaggio da una cultura preindustriale a una civiltà di massa in cui il poeta fa fatica a riconoscersi («Non lo amo il mio tempo, non lo amo»).
Il commento di Cattaneo è utilissimo nel dar conto della fitta rete intertestuale: non solo i riferimenti a Dante, Petrarca, d’Annunzio, Pascoli, Carducci, Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale, ma le relazioni intime con i quasi coetanei Fortini, Giudici, Zanzotto. Utilissimo anche nell’avvicinare il lettore al contesto che muove l’urgenza del poeta: nel ricostruire le occasioni e i rapporti con le altre poesie, illustra bene secondo quali percorsi dell’invenzione e della trasfigurazione si esprime lo stile peculiare di Sereni, dove spesso a una lingua quotidiana corrisponde, senza darlo a vedere, il massimo di riflessione morale o persino teologica (Le ceneri o la splendida Le sei del mattino); e dove nell’estrema sobrietà del lessico ritroviamo l’inquietudine e il presentimento della morte, il colloquio perenne con i defunti, tema ricorrente e quasi ossessivo, fino all’ultima poesia, La spiaggia, che celebra la speranza di una possibile vitalità dei morti: «Segnali / di loro che partiti non erano affatto?».
Articolo pubblicato dal “Corriere della Sera”
Nell’immagine: Vittorio Sereni nel 1958






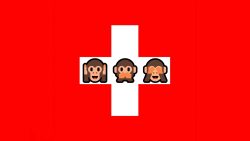






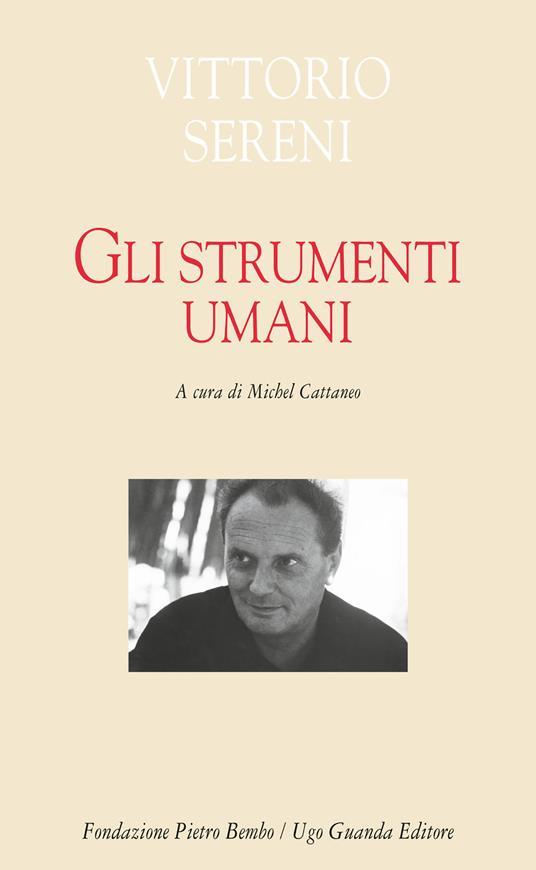 La svolta più netta si verifica con
La svolta più netta si verifica con 
