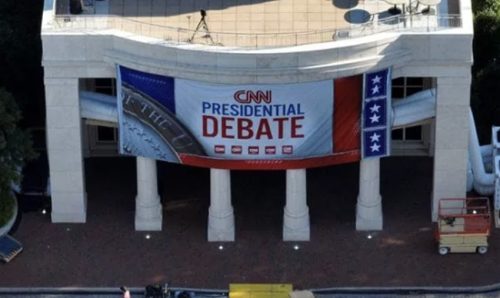Di Boas Erez, Bon pour la tête
Narrazioni mitologiche
È difficile credere che al giorno d’oggi gran parte degli economisti si accontenti di basare la propria disciplina su miti. Eppure questo è ciò che ha dimostrato il lavoro degli antropologi. David Graeber, ad esempio, sottolinea l’assenza di basi scientifiche per il racconto standard secondo cui il denaro sarebbe apparso per migliorare un’economia basata sul baratto (si veda il suo importante libro Debito. I primi 5000 anni). Allo stesso modo, non ci sono basi per attribuire al moralista scozzese Adam Smith l’idea che l’economia debba avere la precedenza sulla politica. Se è vero che Smith immaginava che gli attori economici potessero operare seguendo solo i propri interessi, perché una mano invisibile sarebbe intervenuta per difendere l’interesse generale, non avrebbe, ad esempio, spinto la sua idea fino a difendere la schiavitù o l’accumulo esagerato di ricchezza in poche mani. Possiamo quindi constatare che queste narrazioni mitologiche sono al servizio di interessi politici.
Il ruolo centrale del debito
La crescita è fondamentale per il nostro sistema economico e il fatto che sia possibile prendere in prestito somme di denaro alla sola condizione di restituirle con gli interessi è un meccanismo cruciale. Ci si può chiedere perché tante persone si privino della loro libertà indebitandosi, ma è ancora più misterioso che siano i governi stessi a indebitarsi. Il funzionamento dell’economia odierna spiega in parte questo comportamento, proprio perché deve esserci crescita. Ma i governi contraggono prestiti anche per estendere il loro dominio. Ad esempio, per finanziare le missioni dei conquistadores, le teste coronate europee chiedevano prestiti ai banchieri. I banchieri furono gli unici a trarre veramente profitto dalla scoperta e dallo sfruttamento del Nuovo Mondo.
Lo psicodramma del tetto del debito USA
I media hanno recentemente seguito le tribolazioni del presidente americano Biden per evitare che la sua amministrazione finisca in default sul debito. Ripercorriamo rapidamente i punti essenziali. Negli Stati Uniti, il Congresso fissa il tetto del debito nazionale. È stato innalzato 79 volte in un secolo, ed è stato raggiunto per l’ennesima volta nel gennaio 2023. In altre parole, il governo ha dovuto prendere in prestito più del tetto di 31 mila miliardi di dollari per garantire il suo funzionamento quotidiano. Questa enorme somma rappresenta il 125% del PIL statunitense. I repubblicani hanno cercato di approfittare di questa situazione, e della loro maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, per strappare concessioni a Biden. I giornalisti hanno dato ampio spazio alla spiegazione del processo, ai negoziati tra le parti, ma soprattutto alla valutazione dell’entità del disastro che si sarebbe verificato se non si fosse raggiunto un accordo prima della data di cessazione dei pagamenti – fissata intorno al 5 giugno.
Alla fine l’accordo è stato raggiunto appena in tempo, ma alcuni hanno pensato che fosse il frutto di una messa in scena. Le Monde ha intitolato un editoriale “Pour en finir avec le psychodrame du plafond de la dette américaine” (“Per porre fine allo psicodramma del tetto del debito statunitense”). Il Financial Times ha persino usato l’espressione “game of chicken” per descrivere l’accaduto. In questo gioco, i partecipanti si trovano in rotta di collisione e chi devia per evitare un incidente è considerato un codardo. L’assurdità della situazione si può intuire dal fatto che Biden avrebbe potuto uscirne comunque utilizzando un espediente già previsto da Obama quando si trovò in una situazione simile nel 2011: il Presidente avrebbe potuto coniare una moneta di platino del valore di 1.000 miliardi e continuare a spendere. Ma rimanevano aperte anche altre strade, meno spettacolari.
Il debito e gli armamenti
Con l’accordo bipartisan approvato dal Congresso, il tetto del debito potrà essere innalzato fino al 1° gennaio 2025, in modo da non essere oggetto di dibattito nelle elezioni legislative che si terranno nel novembre 2024. I repubblicani sono riusciti a garantire che la spesa militare non sarà toccata, che il sostegno ai veterani sarà mantenuto e che non ci saranno tasse aggiuntive. Il Presidente democratico è soddisfatto per non dover imporre troppi vincoli alla spesa sociale e di poter mantenere il suo impegno per le energie rinnovabili e la cancellazione del debito studentesco. Questo compromesso politico è in gran parte insoddisfacente, perché evita accuratamente di andare alla radice del problema. Inoltre, i partiti si sono privati della possibilità di scovare efficacemente le frodi fiscali, limitando l’assunzione di personale competente! Ma qual è la radice del problema? La risposta è di una semplicità sconcertante: la spesa militare.
In effetti, la variazione della curva del debito statunitense segue molto da vicino quella della spesa militare e molti ritengono che questa spesa spieghi da sola il deficit degli Stati Uniti (si veda, ad esempio, il capitolo 12 del libro di Graeber citato in precedenza). Gli Stati Uniti non sono l’unico Paese indebitato: il Fondo Monetario Internazionale (FMI) elenca 41 Paesi gravemente indebitati. Per la maggior parte di questi Paesi, ciò significa una perdita di autonomia. Per gli Stati Uniti, invece, il debito offre una forma paradossale di controllo. I suoi creditori sono essenzialmente investitori istituzionali di Paesi come la Germania, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, la Thailandia e gli Stati del Golfo, tutti dipendenti dalla sua protezione militare. Questa protezione è in gran parte finanziata dai loro prestiti! Anche la quota di debito detenuta dalla Cina la lega agli interessi americani. Per comprendere la portata di questo paradossale dominio, basta notare che le obbligazioni emesse dagli Stati Uniti, detenute dai suoi creditori, corrispondono a un terzo del totale delle obbligazioni emesse da tutti i Paesi del mondo.
Difficile immaginare alternative
Sebbene alcuni analisti suggeriscano che un taglio del 5% della spesa e un aumento delle tasse del 2% in 30 anni sarebbero sufficienti a far scendere il debito statunitense al 70% del PIL, è facile capire quali interessi dovrebbero essere spostati per uscire dalla situazione attuale. L’atteggiamento da falco dei Paesi occidentali nei confronti della guerra in Ucraina è solo un’indicazione del fatto che dovremo aspettare a lungo perché le cose cambino radicalmente.
La spesa militare è in aumento ovunque: nel 2022 è aumentata del 4% a livello mondiale; il bilancio della difesa della Cina è cresciuto di circa il 75% negli ultimi dieci anni; quello del Giappone è destinato ad aumentare di due terzi entro il 2027, facendolo diventare il terzo paese per spesa; su impulso della NATO, i Paesi europei si sforzano di spendere il 2% del rispettivo PIL in armamenti (la Polonia punta addirittura al 4%); e la Svizzera, pur non essendo membro della NATO, ha deciso di aumentare gradualmente la spesa fino all’1% del PIL entro il 2030, per raggiungere gli 8 miliardi di franchi all’anno. La fine della Guerra Fredda aveva aperto la possibilità di riorientare la spesa pubblica per rispondere alle esigenze della società civile. Le macchine da guerra sono state rilanciate e hanno bisogno di essere alimentate. Oppure è l’economia stessa che ha bisogno di questo impulso, dato che i margini di crescita si stanno riducendo altrove?
Nell’immagine: Joe Biden durante il discorso sullo stato dell’Unione di quest’anno