L’importanza di essere elvetici
Caparbietà e coraggio, ecco cosa pensiamo di aver «ereditato» dagli Elvezi. In realtà non è così.
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Caparbietà e coraggio, ecco cosa pensiamo di aver «ereditato» dagli Elvezi. In realtà non è così.
• – Simona Sala

Perché i morti civili palestinesi non sono il costo necessario del diritto di Israele e a difendersi
• – Redazione

L’alba di un narco-stato in Europa: ecco la città da dove passano i traffici di droga
• – Redazione
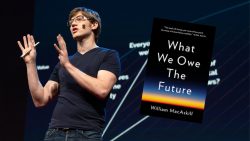
Un’altra storia del “mago delle criptovalute”
• – Silvano Toppi

Si nega che vi sia relazione fra il vuoto diplomatico e la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre; ma intanto nel mondo è un coro di richieste per un ritorno all’accordo che trent’anni fa sottoscrissero Rabin e Arafat per la soluzione dei “due Stati”
• – Aldo Sofia

Un ebreo e un palestinese di Gaza: a Zurigo due interventi e lo stesso appello per la fine della guerra e il reciproco riconoscimento
• – Redazione

Da Princeton a Yale, da Harvard a Stanford divampa l’odio contro gli israeliani
• – Redazione

In Svizzera crescita dell' inflazione vicina a quanto auspicato dalla Banca Nazionale. Allora perché sentiamo che il rincaro pesa ancora parecchio sul bilancio famigliare?
• – Aldo Sofia

Nella quinta guerra in 15 anni, sono morti già 3.600 bimbi palestinesi. Chi resta, cresce tra il piangere i morti e il culto del martirio: ci vuole il permesso per uscire e andarsi a curare. La cattività è il terreno fertile per la radicalizzazione
• – Redazione

Il discorso del vicecancelliere tedesco Robert Habeck, copresidente dei Verdi
• – Redazione

Caparbietà e coraggio, ecco cosa pensiamo di aver «ereditato» dagli Elvezi. In realtà non è così.
Se dovessimo ragionare in questi termini, noi svizzeri potremmo rifarci (e certamente vi è chi lo fa) ai nostri presunti antenati, ossia a quegli Elvezi che non mancarono di impressionare perfino Giulio Cesare, tanto erano valorosi e coraggiosi. Un popolo, secondo la tradizione giunta fino a noi, insediato in quella che oggi è la Svizzera, sin dalla remota Età del Ferro, dunque capace di superare le ere, le generazioni e il tempo, affermandosi per la propria caparbietà. Queste ottime caratteristiche dovrebbero, per eredità genetica, essere giunte fino a noi, permettendoci di risplendere anche nell’hic et nunc.
A farci cambiare idea, o perlomeno a darci una prospettiva diversa, più misurata e con tutta probabilità più aderente alla storia, ci ha pensato in tempi recentissimi Lionel Pernet, Direttore del Museo cantonale di archeologia di Losanna, nonché presidente di Archeologia Svizzera, che pubblica anche la rivista «ArCHaeo». L’ultimo numero della rivista (3/2023), infatti, è dedicato interamente agli Elvezi, cui, prima ancora delle nostre presunte caratteristiche positive, dobbiamo anche il nome, tassello fondante di ogni identità che si rispetti. Ebbene, laddove, come afferma Pernet, «l’archeologia ha spesso (…) servito la narrazione nazionale rafforzando i miti», è ora di fare chiarezza: non esistono prove del fatto che gli Elvezi (considerati Celti) nell’Età del Ferro già vivessero in Svizzera, più esattamente negli insediamenti di palafitte di La Tène. La prima traccia che abbiamo della loro esistenza risalirebbe solamente al 300 a.C., anno in cui si situa la produzione di un bicchiere con la scritta «Eluveiti» in caratteri etruschi, rinvenuto nell’odierna Italia del Nord.
Per saperne di più sugli Elvezi – se si esclude un passaggio del filosofo greco Posidonio di Apamea, che ne registra l’esistenza in un periodo intorno al 113 a.C. – occorre rifarsi di nuovo a Giulio Cesare, e più precisamente al suo De bello Gallico, là dove si racconta come fossero giunti in «Svizzera» dall’estero (dunque, erano degli immigrati!) insediandosi da qualche parte «fra il Giura (…), il Reno (…) e il Lago Lemano e il Rodano» solamente nell’80 a.C., per poi però decidere di andarsene, e mai più ritornare (a questo proposito si lasciarono alle spalle distruzione e fuoco) già nel 58 a.C.
Giulio Cesare non accettò l’intraprendenza degli Elvezi, che affrontò nella Battaglia di Bibracte, cui sopravvisse solo la comunità dei Tigurini.
Da dove veniamo dunque noi svizzeri, ora che dopo Guglielmo Tell, la storia ci ha messo in dubbio anche la discendenza dagli Elvezi? A giungerci in soccorso con una risposta dettata da buon senso e lungimiranza, è ancora una volta Lionel Pernet, quando dice che «siamo il prodotto di una successione di popolazioni diverse, come gli strati di un sito archeologico che si depositano l’uno sull’altro nel corso dei secoli». Come a dire che se vogliamo fregiarci di certi meriti, o valori, non dobbiamo cercarli nel DNA, ma crearceli noi, qui e ora, giorno dopo giorno.
Nell’immagine: Elvezi del Duemila. Il gruppo svizzero di folk metal “Eluveitie”


I padroni del mondo della tecnologia - fra elettronica, social media e intelligenza artificiale - hanno in Elon Musk il campione della privatizzazione dello spazio e l’artefice di...
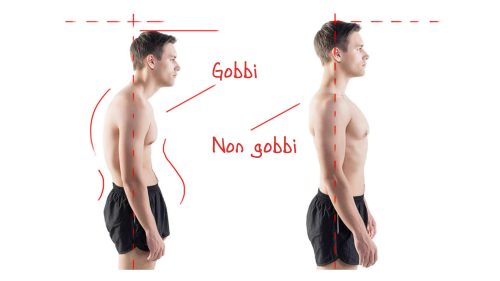
Fine dell’inchiesta sull’incidente stradale, dichiarazioni fuori luogo, e cosa rimane ancora aperto