I 100 anni di Kissinger: Metternich, realpolitik e pagine nere
Il bilancio in chiaroscuro del (fin troppo) celebrato protagonista della politica estera americana
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Il bilancio in chiaroscuro del (fin troppo) celebrato protagonista della politica estera americana
• – Aldo Sofia

Di algoritmi e IA che ci “aiutano” a non pensare, in nome di un presunto beneficio che diventa invece totale alienazione
• – Lelio Demichelis

La parzialità dei verdetti raggiunti con il compromesso, l’abuso del sistema e la totale «scemata responsabilità» dello Stato - Di Manuela Mazzi
• – Redazione

Come accomodanti e interessati esponenti del nostro mondo politico-finanziario hanno sostenuto la guerra del neo-zar in Ucraina
• – Redazione

Da Berna una piccola buona notizia. Cosa non scontata, visto quanto produce il nostro Parlamento
• – Fabio Dozio

A proposito di scelte progettuali ed elettorali del PS, e di un problema di comunicazione - Di Aurelio Sargenti
• – Redazione

Uno dei manifesti della campagna UDC Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Lo tengono in vita, alimentando la disinformazione, gruppi d’interesse che si avvalgono di pseudoesperti
• – Redazione
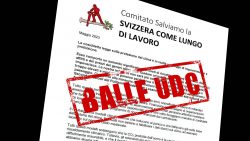
Un comitato anonimo fa campagna contro la legge sul clima. Le argomentazioni non solo sono populiste ma anche false. E la fonte pare essere vicina ad ambienti Udc
• – Redazione

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
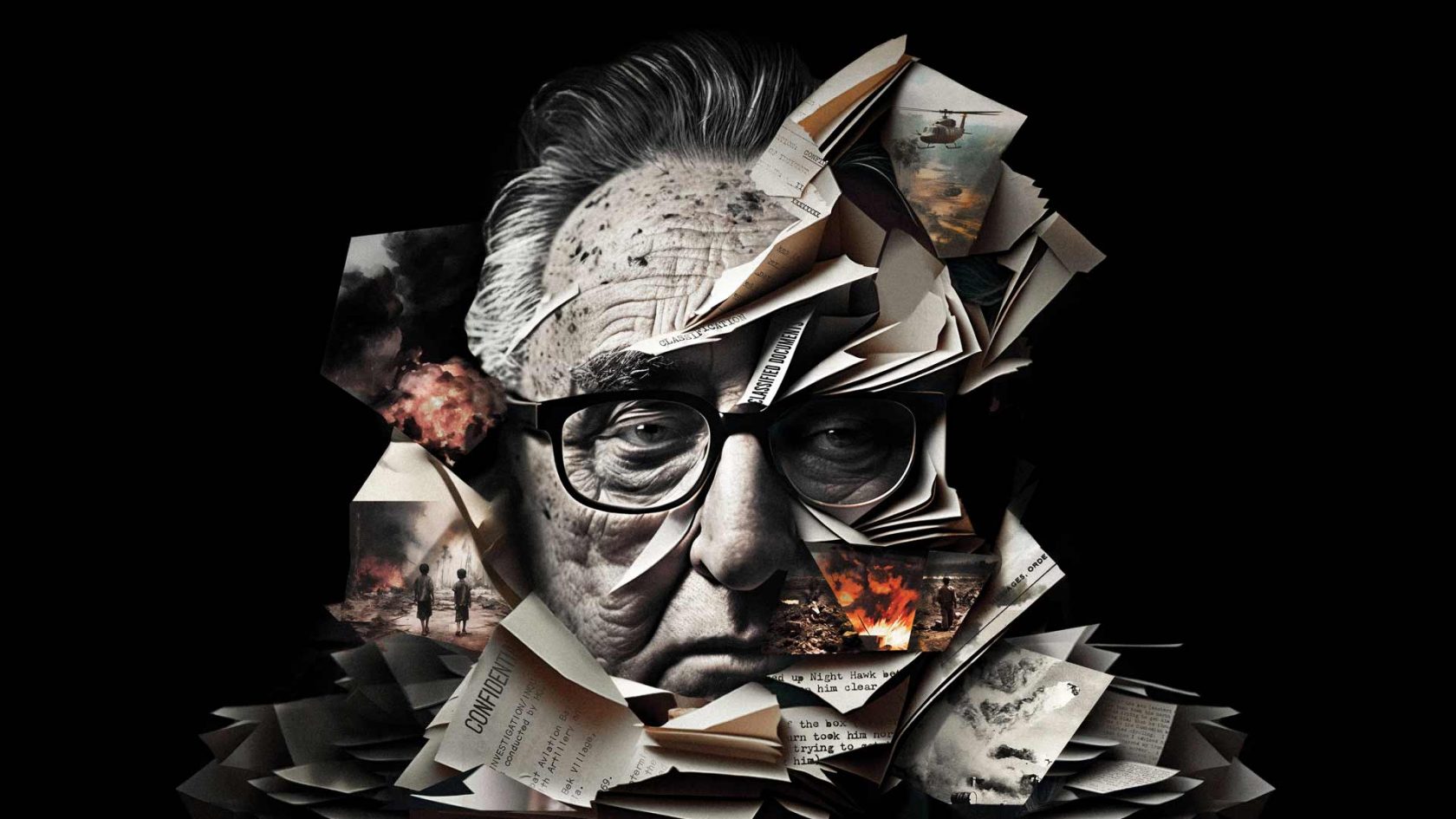
Il bilancio in chiaroscuro del (fin troppo) celebrato protagonista della politica estera americana
Taglio netto, anche nel nome, da quel passato europeo. Eppure, le tragedie e le pacifiche tregue nella storia del vecchio continente sono state la sua passione di studioso e in seguito la sua bussola diplomatica. In cima a tutto, il Congresso di Vienna del 1815. La tesi di dottorato a Harvard, poi diventata celebre libro, era infatti intitolata “Diplomazia della restaurazione”, dedicata soprattutto a figura e opera di Klemens Lothar principe di Metternich; mentre la “restaurazione” era quella che, dopo la vittoria nelle guerre anti-napoleoniche, ma con il coinvolgimento della Francia sconfitta, il Congresso nella capitale austro-ungarica riportava il vecchio ordine di imperi e monarchie, che avrebbero garantito il “loro concetto imperiale” di stabilità e pace in Europa.
Obiettivo raggiunto attraverso il grimaldello della “diplomazia triangolare”, premessa a quella Realpolitik che Kissinger praticò e ha così definito: “Non si sceglie fra bene e male, ma tra male sopportabile e tragedia epocale”. Tutto il resto è dettaglio o quasi, comunque trascurabile. Del resto ammetteva che “Napoleone mi appariva come l’incarnazione della Rivoluzione, mentre nella potenza che io dovevo rappresentare vedevo la più sicura custode della pace sociale e dell’equilibrio politico”. Tradotta nella realtà del 21esimo secolo, il “suo” secolo, l’affermazione riassume perfettamente sia la visione kissingeriana dell’America nel mondo sia una spregiudicatezza spesso scivolata in prepotenza e cinismo sulle periferie, visto che l’equilibrio fra potenze doveva affermarsi qualunque fosse la sostanza del loro regime.
In tutto questo si incrociano i suoi successi, i suoi fallimenti, le sue “pagine nere”. Il principale e citatissimo capolavoro: l’apertura alla Cina (con tanto di preventivi viaggi segreti per incontrare Zou Enlai), la diplomazia del ping-pong, la stretta di mano Mao-Nixon a Pechino, così da disinnescare la miccia vietnamita, la guerra lontana sempre più insopportabile (marines morti, proteste in patria, frattura interna, contestazioni internazionali) per gli Stati Uniti finiti nel pantano indocinese. Senza però mortificare troppo la concorrente Urss, a cui la strategia di Kissinger garantì tra l’altro un piano di aiuti alimentari, tonnellate e tonnellate di grano destinate alla potenza nucleare nemica: “per la felicità sia dei coltivatori del Midwest sia dei bolscevichi del Cremlino”. Perfetto e riuscito esempio di “diplomazia triangolare”. Basato su accordi tra potenze (Usa, Urss, Cina) che effettivamente erano o si consideravano o aspiravano a diventare imperiali. Pazienza (nel “Kissinger-pensiero”) per i boat people, o per le immagini della potenza americana che dovette comunque pagare pegno con la disastrosa fuga dall’ambasciata statunitense di Saigon; oppure se un alto prezzo lo pagò la Cambogia con bombardamenti pesantissimi e letali, che spalancarono la strada ai feroci Khmer Rossi di Pol Pot (“contro di loro non entreremo certo in guerra”, assicurò il dominus della politica estera yankee).
C’è un’altra pagina che può viene annoverata fra quelle considerate positive, il lavorio che portò alla convocazione della “Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa”: considerata un modello di distensione fra i blocchi (l’Ovest otteneva solo la promessa sovietica di maggiore considerazione per i diritti umani nel Patto di Varsavia), in realtà conferma in scala minore degli accordi di Yalta e della cortina di ferro. È dunque del tutto logico e comprensibile che per Vladimir Putin (che definirà “una tragedia” la fine dell’Urss) Kissinger sia stato il miglior politico espresso dalla superpotenza rivale.
Riequilibrare conservando, dunque. Per preservare la pace (per quella in Vietnam “meritò” il Nobel), attivandosi quando questa “pace della conservazione” veniva o sembrava minacciata. Con tragedie conseguenti. Quella del Cile su tutte. Kissinger si adoperò per abbattere violentemente (in un “altro” spesso dimenticato 11 settembre, quello del 1973) il governo della sinistra democraticamente eletto di Salvador Allende), sostenendo quindi la dittatura di Pinochet; aprendo la strada a quella successiva dei generali argentini, altrettanto sanguinaria e a sua volta sottoposta, come in Cile, a una disastrosa cura economico-liberista. Anche per Kissinger, Il “cortile di casa” centro-sudamericano era semplicemente “un cortile americano”. Diritti umani? Secondari, per il cantore dell’equilibrio mondiale mutuato dal lontano “Congresso di Vienna”, che durerà un trentennio, fino ai moti popolari e insurrezionali del 1848.
Non sorprende dunque, in questo incrocio fra citatissimi successi e ingloriose pagine, che Henry Kissinger sia amato quanto odiato. Le biografie a lui dedicate ne sono fedele testimonianza. Feroci quelle degli americani Seymour Hersh e Christopher Hitchens; quest’ultimo con la pubblicazione di “Processo”, contenente la richiesta di portare sul banco degli imputati il decano della diplomazia americana per le diverse stragi (conseguenti alla sua politica estera) che gli vengono attribuite.
Eppure è lo stesso Kissinger che il pacifismo anti-atlantista e anti-americano ha indicato come saggia voce contro la guerra odierna e la conseguente consegna di armi NATO a Kiev. Infatti, così fu all’inizio del conflitto, quando affermò che alla Russia bisognava pur concedere dei territori data la sua storia, le sue dimensioni, i suoi arsenali anche atomici. Ma poi, costatata la realtà di una Russia “potenza non così… potente”, ha corretto il suo schema. Fino ad affermare che, per evitare un conflitto nucleare-tattico, e considerato come si sono messe le cose sul terreno di guerra, non solo è legittimo consegnare armi all’esercito di Zelensky ma addirittura portare l’Ucraino nella Nato. Sperando poi e soprattutto nella mediazione della Cina di Xi Jinping. È così certo che oggi Kissinger risulti assai meno popolare e apprezzato nelle stanze del Cremlino.
Nell’immagine: illustrazione di Matthieu Bourel per un articolo di The Intercept sui crimini americani in Cambogia (riassunto in italiano da Altreconomia)


“Non avevamo di fronte il Brasile”: la critica italiana distrugge gli Azzurri e dimentica che la figuraccia è causata da una Svizzera fortissima sotto tutti i punti di vista; a...

Il paese cerca una coalizione dopo le elezioni che hanno sanzionato pesantemente l’ANC che fu di Mandela, diviso fra tradizionalisti e pragmatici