Ilario Lodi: I fatti della Foce parlano delle scelte e della vita di tutti noi
Non è violenza gratuita, è smarrimento, perdita di senso. E riguarda anche chi sabato notte dormiva
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
Non è violenza gratuita, è smarrimento, perdita di senso. E riguarda anche chi sabato notte dormiva
• – Redazione

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
Intervista al dott. Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale
• – Aldo Sofia

Riconoscere il valore del capitale naturale è alla base dei vincoli morali che abbiamo verso le future generazioni
• – Giulia Petralli
I metodi dell’ala più dura dell’Udc nazionale
• – Daniele Piazza

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Il Municipio fa la voce grossa ma la legge è dalla parte degli autonomi
• – Marco Züblin

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
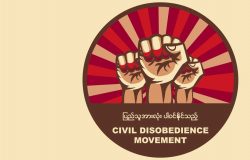
Il coraggio dei birmani e l’inerzia della comunità internazionale
• – Loretta Dalpozzo
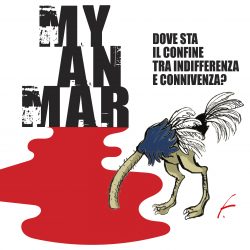
Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
Non è violenza gratuita, è smarrimento, perdita di senso. E riguarda anche chi sabato notte dormiva
Genitori, un mestiere sempre più difficile
Lo spirito che ha animato coloro che hanno pensato e redatto la Costituzione elvetica o che su di essa sono ritornati per aggiornarla è chiaro e facilmente comprensibile: l’iniziativa individuale è al centro di tutto; il cittadino deve sbrigarsela da sé e nel caso in cui non ce la faccia (e solo allora) lo Stato può intervenire sussidiariamente per fare in modo che la situazione non peggiori e per ripristinare quell’equilibrio (prima di tutto: finanziario) che gli consenta di ritornare a potersela sbrigare da solo con rinnovato vigore.
Questo modo di interpretare la relazione tra autorità e cittadino ha generato degli effetti anche in campo educativo: l’educazione dei bambini e dei giovani è fondamentalmente una questione privata che riguarda le famiglie e non lo Stato che, in queste come in altre, non deve intervenire. Se da una parte camminiamo quindi su un terreno che ha a che fare con l’educazione formale (diciamo: la scuola e la formazione professionale), dall’altra abbiamo l’immenso territorio (infinitamente vasto) sul quale si gioca la partita dell’educazione informale (diciamo: tutto ciò che va oltre la scuola e la formazione professionale).
Da tutto ciò consegue, tra le altre cose, che le sollecitazioni alle quali, prima ancora che i giovani, le famiglie stesse vengono sottoposte sono notevolissime. Là dove non sono o non possono essere raccolte e serenamente elaborate, queste si trasformano in fonte di preoccupazione o forse di problemi di non facile soluzione. Oggi sappiamo che le decisioni sull’educazione dei bambini e dei giovani sono sempre meno alla portata delle famiglie che li hanno accolti nelle loro vite, accuditi e cresciuti. È sempre più difficile, infatti, districarsi nella miriade di offerte formative e di aggiornamento; i settori economici appoggiano – investendovi massicciamente – alcuni ambiti più che altri, la conoscenza delle lingue e la digitalizzazione dettano l’agenda, il mercato del lavoro è in continua evoluzione al punto tale che non è sempre facile stare al passo con quello che succede, e altro ancora (tutto ciò senza considerare i fortissimi interessi che stanno dietro ai settori della formazione continua).
Non sorprende, quindi, che ci sia, e sia molto presente, una forma di disorientamento da parte delle famiglie riguardo al cosa fare con i propri figli nel momento in cui bisogna scegliere che direzione intraprendere. Questa, a mio parere, è una delle motivazioni che stanno alla base della scelta che molti formulano di iniziare un percorso scolastico medio superiore, il che altro non è che un rinviare le scelte da effettuare a – ipotetici – momenti successivi dove le cose potrebbero essersi fatte più chiare.
La situazione di incertezza, comunque, non scompare automaticamente con l’inizio della prima liceo. Assai frequentemente essa permane e si traduce in forme molto differenti: risultati scolastici insoddisfacenti, sensazione di inadeguatezza, peso di responsabilità non ancora chiare tanto per citarne solo alcuni.
Dire “disagio” non basta
Ai giovani abbiamo chiesto e stiamo chiedendo molto. Su di loro si sono effettuati negli ultimi anni degli investimenti davvero notevoli, misure che hanno innescato una corsa al rialzo mettendo in competizione i giovani tra di loro e con il mercato in generale: sul piano della formazione, certamente; ma anche sul piano dello sviluppo delle relazioni individuali che, per potersi sviluppare, sono tenute a far riferimento al settore dei consumi, e via di questo passo. Queste pratiche generano risultati più o meno prevedibili.
Per alcuni la questione si risolve, malgrado tutto, nell’imboccare una via e, più o meno coerentemente, mantenerla per un certo numero di anni, fino ad ottenere una sorta di indipendenza sia materiale che spirituale nei confronti di quanto ci sta attorno. Per altri, invece, questo modello di crescita genera più problemi di quanti si proponga di risolverne. Per descrivere queste situazioni (che probabilmente abbiamo sottovalutato nella loro importanza) abbiamo adottato il termine disagio. Questo concetto, però, sta mostrando i suoi limiti e, oggi, non sembra più adatto per descrivere quello che effettivamente sta succedendo. Si può parlare di disagio giovanile davanti a quanto accaduto alla Foce qualche giorno fa? Non credo.
Credo invece che, a fronte delle migliaia di giovani che – a fatica, con molto impegno e dedizione e con i mezzi a loro disposizione – dimostrano di essere all’altezza delle proprie aspettative, mettendo in campo tutto quanto è necessario per coronare i propri sogni e le proprie ambizioni; a fronte di questi, dicevo, ce ne sono altri che hanno invece sviluppato un modus operandi differente, giovani che percepiscono la realtà in maniera diversa da quanto ci si potrebbe attendere e con i quali, proprio perché soggetti di un percorso di crescita individuale probabilmente non ancora definito nelle sue essenzialità, diventa complesso poter interloquire. Non c’è da sorprendersi davanti a quanto accaduto; forse a sorprendere è il fatto che sia accaduto solo ora.
Forse non è giusto chiedere ai giovani ciò che neanche gli adulti sanno fare
In gioco – e non mi riferisco solo ai fatti della Foce – c’è il nostro modo di educare, le nostre pratiche educative e formative, familiari e di società. Scopriamo di aver accumulato dei ritardi: mezzo mondo, quello colpito dalla pandemia, non era preparato alla didattica a distanza, anche se di digitalizzazione si parla da almeno vent’anni; apprendiamo di aver privilegiato la formazione in alcuni settori della conoscenza con un coefficiente di produzione di ricchezza monetaria molto alto rispetto ad altri contraddistinti da un valore più basso ma di maggiore impatto sul piano etico e morale; intuiamo che le parole che abbiamo per narrare quanto sta succedendo si rivelano insufficienti per descrivere la complessità dei fenomeni (relazionali) con cui siamo confrontati (il celebre mi mancano i nomi di Husserl).
Siamo quindi confrontati con una realtà che, pur sembrando qualcosa di nuovo (almeno alle nostre latitudini) trova origine in un passato più o meno recente a partire dal quale si è chiesto ai giovani di essere tutto ciò che noi adulti (con i nostri modelli e le nostre ambizioni, le nostre proposte e i nostri vincoli – scolastici piuttosto che formativi, estetici, performativi, di duttilità piuttosto che di remissività), in un modo o nell’altro, abbiamo deciso sia importante per loro essere.
Se le cose stanno in questo modo (ed ho buoni motivi per crederlo) abbiamo un problema non da poco da affrontare e da risolvere con chi vi è direttamente implicato. Bisogna innanzitutto scoprire se esistono presupposti comuni su cui ipotizzare uno spettro di soluzioni ai problemi emergenti. Esse potrebbero essere identificate, ad esempio, in un insieme di valori comuni, di comuni pratiche relazionali, o in un linguaggio (nomi, grammatiche, logiche interlocutorie) condiviso. Oppure attraverso una mediazione rintracciabile in alcuni ideali, forse oggi non ancora sufficientemente elaborati e letti a fondo attraverso la lente degli interessi in gioco. Cosa non facile per chi, chiamato ad esercitare delle responsabilità istituzionali, si trova oggi forse sprovvisto (come molti di noi) degli strumenti (vale a dire: di un ordine di discorso) necessari per imbastire un insieme di relazioni che, in quanto di natura educativa, necessitano di tempi lunghi per potersi imbastire e adeguatamente sviluppare (il mantra che recita che i tempi dell’educazione non sono i tempi dell’economia ci viene qui in aiuto).
È troppo tardi?
Verrebbe da dire che i buoi sono ampiamente fuori dalla stalla. E, probabilmente, sotto molti aspetti, le cose stanno così. Ma per provare a fare qualcosa, in che direzione si potrebbe andare? Forse si potrebbe provare ad inviare sul terreno animatori di strada sperimentati (non sicuramente giovani formati all’ingegneria delle relazioni, gravidi di processi ma poveri di polso, alle prime armi), soggetti con un solido mestiere alle spalle, capaci di costringere al dialogo (nel senso dello stringersi insieme, raccogliersi, riunirsi), di interloquire in maniera concreta con coloro che, esperienze alla mano, si rifiutano di entrare in relazione con tutto quanto ha dell’istituzionale. Ma non parlo di uno o due giovani neodiplomati; parlo di sette, otto, dieci professionisti (insomma: quanti ce ne vogliono, a dipendenza della stima sul numero di giovani con cui interloquire). Nella speranza di averne a disposizione, cioè di aver investito in passato su questo tipo di iniziative.
Approfitterei però della situazione venutasi a creare per aprire, a livello sia istituzionale che privato, un’ampissima (non certamente locale, nemmeno cantonale) discussione su quello che è successo: sui perché, sulle sue origini, sulle ipotesi al vaglio per superare le difficoltà incontrate (la soluzione manu militari, che esiste, non può essere la prima e può essere invocata solo per difesa). Lo farei anche per ribadire l’importanza di investimenti (massicci, decisi, coraggiosi) nelle politiche giovanili e nelle politiche familiari, a partire dai nidi d’infanzia, ai centri extrascolastici, ai centri giovanili, alle colonie estive di vacanza residenziali (che tutt’altro sono di quelle legate alla giornata di attività), dove si esercita la cittadinanza, la partecipatività, il senso del benessere. Lo farei quindi per proporre modelli di educazione alla cittadinanza che non passino dall’insegnamento della civica come fine ma che della civica facciano un mezzo, come tanti altri, per fare educazione.
Se quanto successo alla Foce si origina nelle scelte educative e formative (ma anche di società) formulate nel passato è giusto fermarsi a riconsiderarle nella loro sostanza in termini collettivi. Ciò perché l’educazione dei nostri ragazzi non può più essere più reputata come una questione privata, ma deve essere intesa come un impegno della collettività nella sua interezza.
Ilario Lodi è Responsabile della Fondazione Pro Juventute, Regione Svizzera italiana


Il proposto contenimento della spesa pubblica ridurrà servizi e prestazioni, e verrà dunque pagato dalle famiglie e dalle persone più fragili - Di Ivo Durisch

Incontro pubblico a Lugano con Pietro Supino. Interrogativi e preoccupazioni sulla crisi dei media ticinesi e nazionali, con i relativi rischi per la democrazia - Di Alessandro...