E Marx era forse un ecologista?
Già un secolo e mezzo fa Marx si interrogava sul rapporto fra capitale e natura, fra crescita e sviluppo; una questione centrale per un’alleanza rossoverde
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
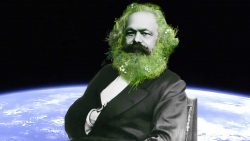
Già un secolo e mezzo fa Marx si interrogava sul rapporto fra capitale e natura, fra crescita e sviluppo; una questione centrale per un’alleanza rossoverde
• – Lelio Demichelis

L'organizzazione umanitaria ha annunciato di dover adottare misure drastiche per riequilibrare le proprie finanze. E all’interno salgono forti e chiare le voci di dissenso
• – Redazione

Il governo Meloni inventa un nuovo reato per punire severamente gli ambientalisti
• – Redazione

L’ex presidente in tribunale è solo teoricamente ‘agli arresti’; e la giustizia americana troppo politicizzata non è un modello virtuoso
• – Aldo Sofia

Non è la destra che è avanzata. È la sinistra che è arretrata per conto suo
• – Virginio Pedroni

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

I rapporti con gli Stati Uniti, in questi anni difficili, tornano ad imporre scelte decisive anche nell’identità e nel funzionamento di una vera Unità Europea
• – Redazione

La Mirante sostenuta al 70 per cento dagli elettori di destra e centro destra, e altre scoperte nell'analisi del panachage fatta dal politologo dell'Università di Losanna
• – Aldo Sofia

Politica e intellettuali, una lezione e un invito dopo il voto ticinese di domenica
• – Orazio Martinetti

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
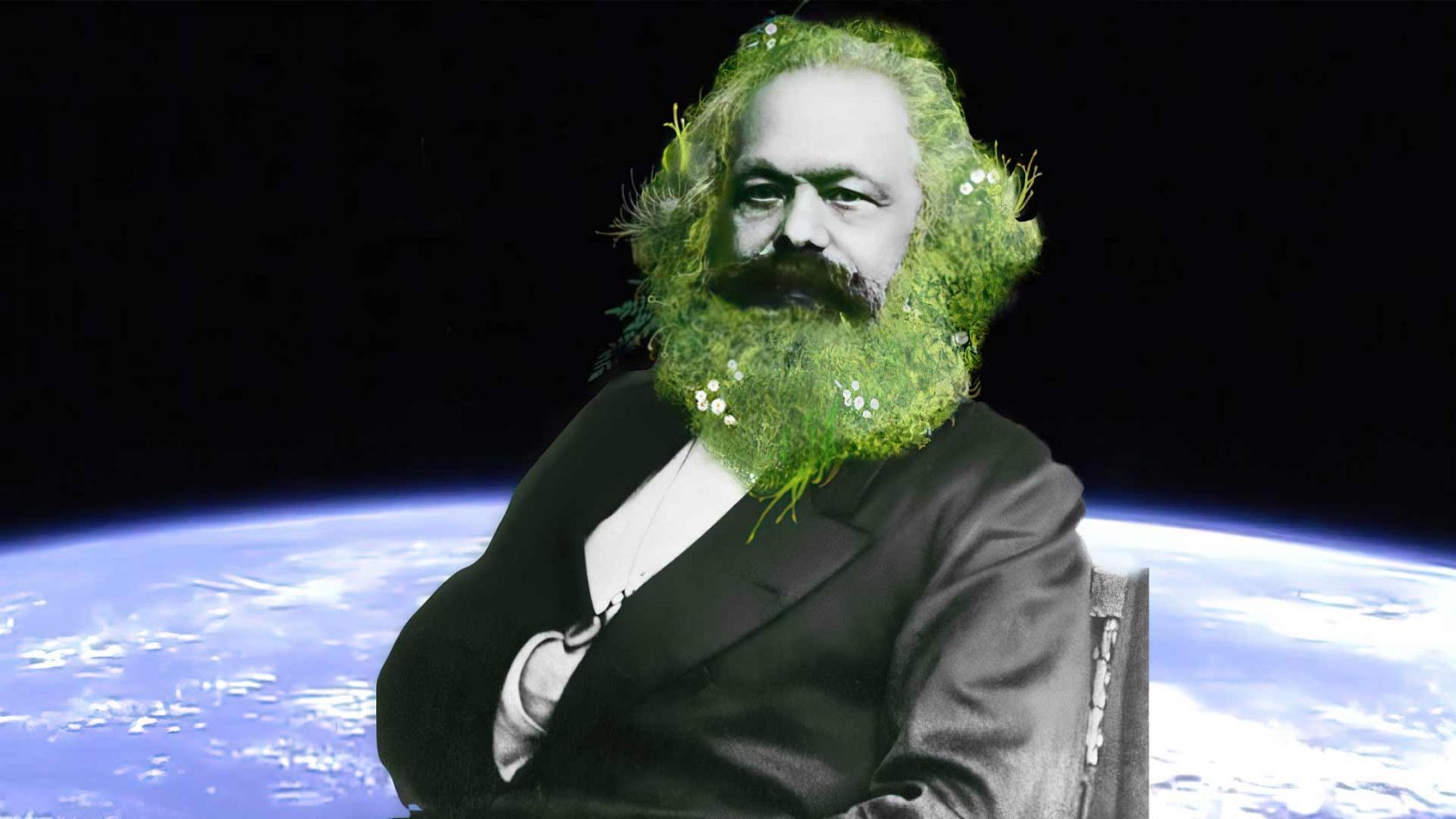
Già un secolo e mezzo fa Marx si interrogava sul rapporto fra capitale e natura, fra crescita e sviluppo; una questione centrale per un’alleanza rossoverde
Secondo Saito, Marx, negli ultimi vent’anni della sua vita si sarebbe avvicinato progressivamente al tema ambientale, analizzando in particolare la riduzione della fertilità dei terreni agricoli seguita all’avvento dell’agricoltura capitalistica. L’interpretazione di Saito si baserebbe sugli appunti di scienze naturali di Marx degli anni Sessanta e Settanta dell’800 (ricordiamo che Marx muore il 14 marzo 1883 e quest’anno sono passati giusto 140 anni), nei quali Marx sarebbe giunto a considerare le crisi ecologiche “come la contraddizione fondamentale del modo di produzione capitalistico, abbandonando la sua precedente valutazione ottimistica del potenziale emancipatorio del capitalismo” – criticata da molti “per i suoi ingenui presupposti tecnocratici”.
Una lettura attenta dei suoi quaderni, secondo Saito rivelerebbe infatti che Marx “in realtà non concepisse una visione utopica del futuro socialista basata sull’aumento infinito delle forze produttive e sulla libera manipolazione della natura. Al contrario, riconobbe seriamente i limiti naturali, trattando il complesso e intenso rapporto tra capitale e natura come una contraddizione [appunto] centrale del capitalismo. […] Arrivando anzi a prevedere [la necessità di] una regolazione consapevole e sostenibile del metabolismo fra uomo e natura come compito essenziale del socialismo”. E sarebbe dunque qui, per Saito, “il punto d’intersezione tra il progetto ‘rosso’ e quello ‘verde’ nel XXI secolo, sul quale la teoria di Marx ha ancora molto da offrire”.
Se la tesi di Saito fosse corretta, la cosa sarebbe decisamente interessante e foriera di nuovi sviluppi – pensiamo a un dopo dell’alleanza elettorale tra socialisti e verdi. Ma aspettiamo di leggere meglio i quaderni di Marx, perché – al di là di Saito – il marxismo post-Marx è sempre stato storicamente, politicamente e filosoficamente industrialista, positivista e prometeico e quindi scoprire un Marx ecologista (senza dimenticare gli accenni di Engels al tema) comporta una conseguente ma non facile rielaborazione profondissima (un quasi totale rovesciamento) del pensiero socialista. Perché Marx era figlio appunto di quel positivismo che diventa egemone dalla prima metà dell’Ottocento (e che permane ancora più egemone oggi), soprattutto con Saint-Simon e Comte. E Saint-Simon divideva il mondo e la società in industriali e oziosi, immaginando poi una società virtuosa governata da scienziati e da industriali (e sembra – anzi è – la realtà di oggi, con la sua capitale istituzionale nella Silicon Valley), cioè con scienza e tecnica come motori e insieme organizzatori dell’intera società. Mentre Comte scriveva che società, società industriale e industria sono sinonimi.
Industria e cioè: fabbrica. Arrivando all’idea (per noi perversa, se non sadomasochistica e disumana) di una società socialista costruita appunto come una sola immensa fabbrica secondo Antonio Gramsci, una società-fabbrica “organizzata con la stessa precisione, lo stesso metodo, lo stesso ordine che egli [il proletario] verifica essere vitale nella fabbrica dove lavora”; senza dimenticare che già Marx aveva definito il socialismo come la fabbrica meno il capitalismo.
Ma la fabbrica è in realtà la sublimazione del tecno-capitalismo e del suo positivismo; è l’applicazione concreta di quella (ir)razionalità strumentale/calcolante-industriale che è la causa prima della crisi ambientale e climatica (oltre che sociale) di oggi. Per cui, appunto, se davvero può e deve essere pensato e costruito un ecosocialismo, prima occorre che la sinistra esca da questa irrazionalità compulsiva positivista, industrialista e capitalista, che guarda alla crescita e non allo sviluppo. Perché – come sosteneva quella grandissima filosofa che è stata Simone Weil (1909-1943) – non è la proprietà privata dei mezzi di produzione ad essere la causa dell’oppressione sociale e dello sfruttamento dell’uomo (e della natura, aggiungiamo), ma la fabbrica e la religione delle forze produttive (produrre e consumare sempre di più), “di cui Marx ha subìto, suo malgrado, l’influsso”.
A sua volta lo storico Bruno Settis ricorda che “nei suoi racconti, Ilya Ehrenburg aveva dipinto ritratti impietosi di manager sovietici così americanizzati da mettere in dubbio la loro dedizione al comunismo. Esaltavano Ford, guidavano le sue auto, ma si giustificavano: naturalmente, noi dobbiamo dargli tutt’altro contenuto, ma dovremmo acquisirne la tecnica”. Ovvero e appunto, come aveva ben visto Simone Weil, la fabbrica – come organizzazione, comando e sorveglianza, come forma e norma dell’essenza della (ir)razionalità strumentale/calcolante-industriale diventata oggi la nostra unica way of life – prescinde dal sistema politico, producendo un taylorismo comunista, come oggi cinese, come oggi nel capitalismo della sorveglianza.
E quindi, sembra del tutto insufficiente concentrarsi solo nella critica del capitalismo (ammesso che qualcuno ancora lo faccia), ma occorre farlo soprattutto sulla tecnica, sul tecno-capitalismo, altro nome della (ir)razionalità strumentale/calcolante-industriale. Il marxismo si è sempre invece concentrato sul capitalismo, immaginandone appunto il superamento grazie anche allo sviluppo tecnologico, cadendo così in una evidente contraddizione in termini. Perché invece – come scriveva un socialista atipico come l’italiano Raniero Panzieri (1921-1964) – “lo sviluppo capitalistico della tecnologia comporta, attraverso le diverse fasi della razionalizzazione, forme sempre più raffinate di integrazione [di uomini e macchine] e un aumento crescente del controllo capitalistico […] Ma invece di vedere e capire questi processi di razionalizzazione crescente del capitalismo attraverso le macchine [e oggi siamo a una nuova fase di razionalizzazione capitalistica, detta digitale] essi vengono completamente ignorati a vantaggio – anche da parte della sinistra e del sindacato – di una rappresentazione tecnologico-idilliaca del processo tecnico”. Dove Panzieri sbagliava era però nel credere che un uso socialista della tecnica potesse cambiare le cose. Perché la tecnica è sì la stessa razionalità irrazionale del capitalismo, ma ha una sua essenza specifica (funzionale al capitale, ma non solo) e per sua essenza mai libererà davvero l’uomo dalla fatica e sempre più trasformerà (ma per il capitalismo!) la società in una immensa fabbrica. E per avere invece un ecosocialismo, ma anche un tecnosocialismo, bisognerebbe prima rottamare l’irrazionalità della ragione strumentale/calcolante-industriale che pre-domina su capitalismo e marxismo da due secoli ad oggi.
Perché è il modello della fabbrica ad essere in conflitto strutturale e sovrastrutturale con la biosfera – e le sinistre dovrebbero rileggere un grande intellettuale di sinistra come è stato Claudio Napoleoni o ripensare all’austerità di Enrico Berlinguer, tutta diversa da quella neoliberale – e con la democrazia e con la libertà. E oggi arriviamo al paradosso per cui sono dei capitalisti come Elon Musk a lanciare un appello per chiedere una pausa nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sempre più pericolosi – e non le sinistre del mondo, come invece dovrebbe essere. Sinistre ancora purtroppo catturate da una visione tecnologico-idilliaca del processo tecnico – con alcune eccezioni interessanti, come la Cgil italiana e la sua ricerca, oggi, di un diverso modello di sviluppo – ingenuamente credendo che le macchine di oggi siano come le macchine del tempo di Marx; o che il progresso tecnico non si possa e non si debba fermare – e che invece si deve fermare se minaccia, come sta accadendo da tempo ma a nostra insaputa, biosfera, democrazia e libertà. Perché non si tratta di fermare il progresso, ma di costruirne uno diverso.


Una storia esemplare, il licenziamento di oltre 400 operai attraverso un email notturno. Ma chi è il proprietario?

Stampa / Pdf Se ti piace quello che facciamo dacci una mano a continuare anche nel 2024 – Clicca qui per sapere come Stampa / Pdf