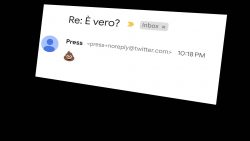Di Andrea Braschayko, Valigia blu
Lo scorso 26 aprile l’inviato di Repubblica Corrado Zunino è stato ferito sul ponte Antonivka di Kherson, un luogo classificato dal governo ucraino come zona rossa – nella quale, cioè, è vietato l’accesso ai media accreditati, a meno di non essere in possesso di un permesso speciale individuale. Durante lo stesso attacco, è morto il collaboratore di Zunino, l’ucraino Bohdan Bityk. La notizia ha riportato al centro del dibattito l’alta dose di rischio del mestiere giornalistico in zone di guerra. Secondo la International Federation of Journalists sono almeno dodici i giornalisti uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su larga scala, diciotto quelli feriti. Si tratta, in maggioranza, di cittadini ucraini.
Le circostanze della morte di Bohdan Bityk rimangono ancora da chiarire. Secondo la ricostruzione dello stesso Zunino e dell’esercito ucraino sarebbe stato colpito da un cecchino russo, mentre la sua uccisione è stata accompagnata da un intensificarsi degli attacchi russi a Kherson.
Entrambi i giornalisti indossavano la pettorina PRESS, ma ciò non ha salvato Bityk. Il Centro Comunicazioni Strategiche ucraino ha accusato Zunino di non essersi assicurato che l’ucraino vestisse un giubbotto antiproiettile (violando le regole del giornalismo di guerra), come confermato poi dallo stesso giornalista. Secondo la versione ucraina, l’inviato di Repubblica non ha comunicato all’esercito la volontà di muoversi in quella zona. Avrebbe poi ignorato ripetuti segnali di pericolo lanciati dai soldati di Kyiv.
Anche Repubblica ha parlato di un «agguato dei cecchini russi». La genericità della formulazione ha tuttavia generato diverse critiche, fra cui quella del reporter di guerra Cristiano Tinazzi, rientrato da Kherson proprio pochi giorni prima. Tinazzi ha espresso le sue perplessità in un thread su Twitter.
Repubblica ha poi pubblicato un comunicato nel quale, al rientro di Zunino in Italia (già avvenuto), condivide «con le autorità ucraine l’interesse a chiarire ogni aspetto di quanto accaduto sul ponte Antonovsky nella giornata del 26 aprile».
Un mestiere cruciale ma invisibile
A prescindere dalle responsabilità da chiarire, la morte di Bityk mette in risalto la precarietà del lavoro dei fixer, una parola pressoché sconosciuta ai non addetti ai lavori.
«Si può dire che io abbia iniziato a fare il fixer senza nemmeno conoscere cosa fosse» ci racconta Vadim Timoshevskyi, un ex consulente finanziario e informatico che durante i primi mesi dell’invasione ha accompagnato giornalisti di mezzo mondo a scoprire gli orrori di Bucha, Irpin’ e Borodyanka.
Bohdan Bityk aiutava Zunino, e altri colleghi occidentali, in tutti quegli aspetti essenziali sul campo senza i quali il lavoro dei giornalisti esteri sarebbe pressoché impraticabile. In italiano fixer si traduce, infatti, in “risolutore”. Questi giornalisti locali (ma non è una regola esserlo) contattano i personaggi chiave, conoscono gli usi locali, fanno da mediatori e traduttori per i loro colleghi stranieri. Questi ultimi li definiscono indispensabili per qualsiasi lavoro di reportage sul campo.
Un ruolo altamente sottovalutato il cui stesso termine, “fixer”, è secondo alcuni peggiorativo e generato da una retorica coloniale che contribuisce ad aumentare le asimmetrie fra giornalisti locali ed esteri, scrive su Al Jazeera Media Institute la giornalista Ana P. Santos. Alcuni hanno infatti proposto l’uso della parola gatekeepers (nel significato inglese di “sorveglianza all’ingresso”), più incisiva nell’evidenziare il lavoro di supporto di questi collaboratori, senza i quali sarebbe difficile produrre una storia, della quale raramente ricevono i crediti. Anche quando diventano, motivati dall’esperienza di collaborazione, dei giornalisti professionisti.
Peraltro, i rischi sopportati dai fixer sono più grandi quanto più autocratico e pericoloso è il luogo in cui fanno da guida, e non si esauriscono certo alla fine del reportage. In alcuni contesti, infatti, i fixer sono percepiti come collaboratori del nemico proprio perché cooperano con giornalisti stranieri. Spesso, però, si creano dei rapporti umani reciproci e i fixer diventano veri e propri amici degli inviati esteri, come Zunino ha voluto chiamare Bohdan nel confermare la notizia della sua morte.
La giornalista ucraina Veronika Mironova, che in patria lavora con Kanal 24 e ha collaborato sul campo con la televisione tedesca Welt, l’agenzia francese AFP e vari giornalisti freelance spiega a Valigia Blu come «i lavoratori dei media morti in Ucraina siano meno rispetto ad altre guerre, non ultimo grazie alle regole stringenti del Ministero della Difesa».
Mironova ritiene che la maggioranza dei giornalisti esteri capisca queste restrizioni, ma dei casi eccezionali non sono mancati. «Dopo una lunga discussione, sono riuscita a convincere un giornalista a non entrare in un’area pericolosa. Con ogni probabilità, il nostro eroismo sarebbe stato mortale» racconta Mironova, anche se «in un’altra occasione sono stato costretta ad accettare il contrario, ma l’ho accompagnato perché abbiamo trovato dei soldati ucraini disposti a scortarci».
In un articolo di qualche mese fa della reporter di Deutsche Welle Jennifer Pahlke, molti fixer ucraini avevano sottolineato la generale mancanza di sicurezza e garanzie economiche di questo rischioso, e altrettanto imprescindibile, mestiere. Una buona dose di rischio potrebbe essere contenuta attraverso la professionalizzazione del lavoro di fixer.
I fixer ucraini con cui siamo entrati in contatto hanno espresso preoccupazioni simili. La professione di fixer fa correre dei rischi fisici e mentali, mentre non tutte le testate si assumono le responsabilità necessarie per rendere il lavoro più sicuro, e viene da chiedersi se queste ultime siano coscienti dei pericoli di questi operatori a chiamata. «È una domanda complessa. Personalmente, ritengo che il rispetto per il mio lavoro sia proporzionale alla paga che mi viene corrisposta, e dal punto di vista monetario non ho di che lamentarmi» racconta Maksym Horobets, che nel 2014 ha combattuto in Donbas e che dall’anno scorso lavora come fixer. «Sarebbe un lavoro sostenibile se le collaborazioni fossero continuative e non a cottimo. Veniamo pagati a giornata ed è difficile costruire qualcosa in questo modo. Horobets afferma che solo in un’occasione, con una testata americana, è riuscito a ottenere un contratto regolare.
Secondo Veronika i fixer locali dovrebbero far parte dell’equipe a livello ufficiale. Innanzitutto, spiega a Valigia Blu, dal punto di vista economico «dovrebbero essere messi in condizione di pagare le tasse, così necessarie all’Ucraina in questo momento» e sul lato professionale «potrebbero inserire queste esperienze nel proprio curriculum». «D’altronde, non sono pochi i casi – ne conosco di diversi in altre guerre – in cui i giornalisti locali diventano dei professionisti grazie all’esperienza acquisita nella collaborazione con gli inviati stranieri» dice Mironova, che adesso collabora con un media finlandese.
Attualmente sono pochi i media internazionali che offrono le garanzie desiderate dai fixer, che evitano di insistere nelle richieste per paura di perdere una collaborazione, racconta Veronika. Secondo Natalie Gryvnyak, fondatrice di una production agency e in procinto di creare un’associazione per la protezione sindacale dei fixer in Ucraina, in alcuni casi gli editori stranieri si affidano a fixer inesperti, perché meno inclini a imporre condizioni e a rifiutare un incarico pericoloso.
Anche fra i fixer con una visione d’insieme più positiva sulla propria condizione di lavoro, riecheggia la stessa richiesta: protezioni giuridiche e inquadramenti contrattuali. Bobby Ghosh, editorialista per CNN e MSBC e primo immigrato a ricoprire la carica di World editor del Time Magazine, aveva sollevato il tema a livello globale già nel 2018, in occasione del Festival internazionale del giornalismo a Perugia.
«Cosa suona meglio? Principi o protocolli? Perché certe tutele valgono per i giornalisti, e non per i fixer?» raccontava Ghosh nel 2018, parlando di un possibile “manifesto di Perugia” a proposito di proposte e idee per migliorare le condizioni di questi personaggi invisibili e indispensabili del giornalismo internazionale. «Le risposte ai problemi dei fixer iniziano tutte con la lettera “r”: rights, responsibilities, rules, rewards» sostiene il giornalista americano.
Sopra ogni altra cosa, i fixer chiedono assicurazioni sugli infortuni e sulla vita, quasi sempre a carico dei singoli collaboratori, come racconta Gryvnyak. «Sono quasi certa che Bohdan Bityk non fosse coperto da un’assicurazione rispetto al suo collega italiano, perché è questa la situazione più comune. Le sembra giusto che la sua famiglia non riceva nulla dopo una tragedia del genere?» rincara la dose Veronika.
In generale, secondo Maksym, la stragrande maggioranza dei giornalisti stranieri in Ucraina si comporta in maniera cordiale ed empatica con i propri collaboratori sul campo. Le situazioni di rischio immotivate sono state minimali, ma le singole tragedie avvenute sono coperte da un cono d’ombra giuridico.
La curiosità di un giornalista inviato di guerra spesso può portare a trasgredire alcune regole allo scopo di raggiungere una notizia importante, eppure per Veronika «un grande giornalista non è colui disposto a fare un sacrificio eroico, ma quello che è grado di leggere il destino umano, la conseguenza delle proprie azioni per sé e per gli altri».
Nell’immagine: corrispondenti di guerra in Ucraina