L’Apocalisse e il Leviatano: la guerra, la sinistra e la storia
Riflessioni per un progetto di risoluzione del conflitto che parta da chiari tratti antimilitaristi, antinazionalisti e ambientalisti
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Riflessioni per un progetto di risoluzione del conflitto che parta da chiari tratti antimilitaristi, antinazionalisti e ambientalisti
• – Redazione
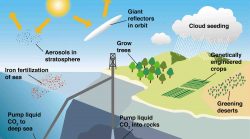
Istituita una Commissione mondiale chiamata ad immaginare strumenti che possano contrastare quel che non sappiamo prevenire
• – Redazione

È quasi un paradosso, ma oggi è cruciale: la sinistra europea deve recuperare un proprio ruolo di alternativa al potere e nello stesso tempo ridefinire un rapporto con le proprie radici storiche fondate su valori “occidentali”
• – Virginio Pedroni

Le parole di Ilya Yashin, il politico dell’opposizione a Putin che vive ancora a Mosca e denuncia il regime
• – Redazione

E invece siamo tutti schiavi del lavoro. O non ce l’abbiamo
• – Redazione

Sul mercato globale, a volte, è più redditizio pagare le sanzioni che abbandonare pratiche illegali
• – Federico Franchini

La Banca nazionale decide prima del previsto di alzare di mezzo punto il tasso guida - Intervista al Prof. Sergio Rossi
• – Redazione

Giugno è il mese decisivo per il futuro dell’Ucraina, che chiede sostegno incondizionato all’UE
• – Redazione
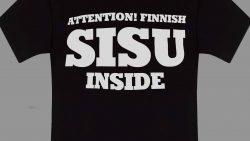
La capacità finlandese di soffrire e superare le avversità
• – Redazione

Non c’è pace nel confronto fra pubblico e privato a Lugano: torna a galla anche l’annosa questione della passeggiata a lago di Castagnola
• – Benedetto Antonini

Riflessioni per un progetto di risoluzione del conflitto che parta da chiari tratti antimilitaristi, antinazionalisti e ambientalisti
Nel giro di tre anni si sono spalancati tre portali, che pongono l’umanità di fronte a scelte epocali, e potenzialmente apocalittiche. L’irruzione sulla scena, nel 2019, del movimento per il clima ha messo all’ordine del giorno l’urgenza di un cambiamento radicale del modo di produzione, distribuzione e consumo, pena lo sprofondare di ampie zone del pianeta in una condizione di irreversibile invivibilità. La pressione dei giovani attivisti sulle istituzioni politiche perché si facciano garanti della transizione ecologica si è accentuata quando si è aperto il secondo portale, quello della pandemia, che avrebbe dimostrato di quale determinazione e tempestività sono capaci gli Stati nazionali, quando la situazione lo richiede.
All’ottimismo del movimento per il clima si è aggiunto quello di larga parte della sinistra radicale (o sedicente tale), che nell’emergenza sanitaria ha visto l’alba di un rinnovato statalismo, unico antidoto al ritorno a una “normalità” aberrante e per giunta ora incrudelita dalle ripercussioni sociali, economiche e antropologiche della pandemia. Tuttavia il terzo portale – quello dischiuso dall’invasione russa dell’Ucraina – ci sbatte in faccia uno scenario assai diverso: lo Stato non come soluzione, bensì come vero e proprio flagello; il monopolio della violenza che si esprime nella forma più arcaica, quella della guerra. Dall’incubo di un futuro distopico, popolato da individui atomizzati, che conducono una vita per lo più virtuale, siamo stati trasportati alla cruda realtà di un esercito che sgancia bombe e spara razzi sulla popolazione civile di un altro paese.
La storia costituisce, come sempre in guerra, strumento di propaganda da entrambe le parti. Se lasciano basiti i disinvolti accostamenti tra la resistenza ucraina e la lotta di liberazione dei partigiani italiani (Luigi Manconi su la Repubblica dell’8 marzo) o l’invio di armi al MIR cileno promosso da Lotta continua nel 1973 (Adriano Sofri su Il Foglio del 9 marzo), perché totalmente destituiti di fondamento storiografico, spiace che anche a sinistra il passato sia piegato a una narrazione che si pretende alternativa rispetto a quella dominante, ma in realtà ne condivide due tratti distintivi: l’indiscutibilità dello Stato come soggetto della storia e l’eurocentrismo. Luciano Canfora (La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 marzo), rammaricandosi sarcasticamente che Salvini, invece di farsi sbeffeggiare da un sindaco polacco più reazionario di lui, non abbia preso, in quello che è un “conflitto tra potenze”, le difese di Putin, addossa la responsabilità dell’accaduto all’“Ucraina che, in spregio agli accordi del 1991 sui rapporti tra le ex-repubbliche sovietiche, nel 2014 ha detronizzato con un colpo di stato il governo (filorusso) in carica, avvicinandosi sempre più alla NATO”. È a questo che molti compagni (il maschile è voluto) fanno riferimento quando insistono sulla necessità di inquadrare le responsabilità dell’invasione nel “contesto storico”: la costante espansione a est della NATO, l’ingerenza degli Stati Uniti nella politica ucraina, la repressione del separatismo filorusso nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Tuttavia, per chi studia la storia, un arco temporale di otto anni è un pulviscolo. Davvero pensiamo di poter partire da lì o, più magnanimamente, dal 1991, senza sporcarci le mani con ciò che accadde prima? En passant, facendo un salto indietro di pochi anni (al 1986) ci si dovrebbe magari chiedere come abbia segnato i rapporti tra le due repubbliche l’incidente di Chernobyl, causato da una gestione a dir poco raffazzonata dell’impianto e gestito in modo raccapricciante dalle autorità centrali (cioè russe). Andando ancora a ritroso, non si possono non ricordare le nefandezze del collaborazionista nazifascista Stepan Bandera, il cui Esercito insurrezionale ucraino (UPA) si distinse per ferocia nello sterminio degli ebrei e dei polacchi e che è stato riabilitato, anzi, consacrato come eroe dalle autorità del paese nei primi anni del nuovo millennio; un segnale inequivocabile del nuovo corso ultranazionalista. Ma come tacere sulla carestia che, tra il 1932 e il 1933, fece circa tre milioni e mezzo di morti nella sola Ucraina e che non solo fu provocata dalle politiche staliniane ma addirittura sfruttata per risolvere una volta per tutte la questione contadina e insieme la questione nazionale, in un paese in cui la resistenza alla collettivizzazione era particolarmente agguerrita? A Stalin, infatti, non a Lenin (che anzi è stato sconfessato) si è richiamato Putin, e da ben prima del discorso in cui ha annunciato l’“operazione militare”; dunque, chi voglia ricostruire il contesto storico dovrebbe spingere lo sguardo ben più indietro del 2014. Certo, non stupisce che non lo faccia chi a sinistra da quella storia non ha mai preso criticamente congedo.
Il risultato è che, mentre ogni persona dotata di onestà intellettuale dovrebbe dolorosamente avvertire tutta l’impotenza in cui versa il movimento per la pace (non perché l’antimilitarismo sia sinonimo di passività, ma perché siamo pochi, confusi, e divisi), ci si trastulla con il derby tra nazionalismi, opponendo agli stolti paladini nostrani della superiorità occidentale, esaltatori dei processi di democratizzazione esportati con le bombe, i carri armati e l’inganno elevato a sistema, l’argomento che la “Russia” ha il diritto di salvaguardare le sue condizioni di sicurezza dalla prepotenza della NATO. Tralascia, chi si fa risucchiare in questo gioco sterile, che è della Russia di Putin che parliamo, ossia del punto di congiunzione tra il lascito più crudele dello stalinismo e la componente più aggressiva del neoliberalismo.
Scrive Volodymyr Artiukh, ricercatore ucraino, militante della sinistra, rivolgendosi ai compagni e alle compagne in Occidente: «Dopo il collasso dell’Unione Sovietica, abbiamo fatto affidamento sulle vostre analisi dell’egemonia statunitense, dell’accumulazione capitalistica nella sua forma neoliberale e del neo-imperialismo occidentale. […] Non posso fare a meno di notare come la sinistra occidentale stia facendo ciò che ha sempre fatto al meglio: analizzare il neo-imperialismo statunitense e l’espansione della NATO. Ebbene non è più abbastanza, perché non spiega il mondo che emerge dalle rovine del Donbass e della piazza centrale di Kharkiv. La descrizione di un mondo modellato dalle – o in reazione alle – azioni degli Stati Uniti non è più esaustiva. Bensì ha acquisito delle dinamiche autonome, e sono proprio Europa e Stati Uniti a porsi in modalità reattiva in molte aree. Vi affannate a illustrare le cause remote, anziché notare le tendenze emergenti»
Non è più abbastanza, appunto. Pierre Dardot e Christian Laval chiudono il loro recente, monumentale Dominer: Enquête sur la souveraineté de l’État en Occident con l’invito a riformulare radicalmente il lessico politico, a partire proprio dal concetto di sovranità. Di fronte a uno Stato ormai divenuto “attore economico globale”, categorie come colonialismo o neoimperialismo al giorno d’oggi non restituiscono la complessità di un apparato istituzionale che, lungi dall’essere esautorato, ingloba nelle politiche nazionali le norme imposte dal capitale globalizzato. Senza esclusione di colpi, come ben vediamo oggi, nella lotta tra i diversi poli geopolitici per il predominio sul mercato mondiale, a scapito delle classi subalterne, di popoli disprezzati o squalificati perché “senza storia”, di intere comunità culturali.
Non nel “ritorno dello Stato”, nella restaurazione della sua autorità può dunque essere cercata la chiave di volta di una ripresa del conflitto sociale, bensì nel ripensare l’obbligazione reciproca tra gli esseri umani, e tra questi e il mondo non umano. Ridicolizzare la ricerca e la sperimentazione di istituzioni politiche alternative allo Stato sovrano come vezzo anarcoide da anime belle è funzionale al mantenimento dell’attuale sistema di sfruttamento e oppressione. E che non sia solo un passatempo è testimoniato dall’esperienza del confederalismo democratico del Rojava, in Siria, che rappresenta non già un modello universale, ma l’esperimento sociale e politico forse più interessante del XXI secolo, con il suo tentativo di affrontare in termini inediti – cioè articolando tra loro i piani apparentemente distanti dell’utopia o del modello di società cui tendere e le pratiche sociali concrete, il qui e ora – i problemi lasciati sul campo dalla crisi del socialismo classico: quello del progresso e dello sviluppo; quello delle soggettività rivoluzionarie; e infine proprio quello della politica statale e della sovranità nei processi di trasformazione sociale. Tutto ciò nel complicato contesto di una guerra efferata, che sui media europei non ha meritato le prime pagine.
Dal conflitto tra potenze, ovvero dalla guerra guerreggiata o da quella più subdola e sotterranea degli Stati, possono scaturire soltanto distruzione, miseria e disperazione per i popoli. Dalla Russia agli Stati Uniti, è evidente che siamo nelle mani di gente pericolosa. Oggi, soltanto un movimento per la pace immediata senza annessioni territoriali, autonomo dai governi nazionali e dai chiari tratti antimilitaristi, antinazionalisti e ambientalisti (contro il nucleare civile e militare), può nutrire la speranza di fermare questo conflitto, frenare la catastrofe imminente… e forse riaprire una nuova fase per le politiche di emancipazione.
Nell’immagine: combattenti Rojava


Nelle Alpi svizzere il meeting della élite planetaria: i capo-economisti vedono lo spettro della recessione globale

L’intervista con l’Alto commissario Onu per i rifugiati. "Occorre un’azione unitaria dell’Europa, che ha le risorse ma continua a usarle in modo dispersivo"