Pandemia e parodia della morte
Accettare la fragilità, rinunciare all'idolatria dell'identità - La filosofia al tempo del virus
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
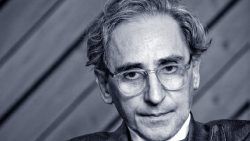
Accettare la fragilità, rinunciare all'idolatria dell'identità - La filosofia al tempo del virus
• – Redazione

Qualche possibile candidatura per un premio all’irragionevole approssimazione, fra presunte responsabilità e tesi discutibili
• – Enrico Lombardi

I fantasmi che in passato hanno rovinato vite intere non sono ancora scomparsi
• – Pepita Vera Conforti

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani
26 settembre, si vota per l'iniziativa "99%": in Svizzera l'1% dei più ricchi possiede oltre il 40% del capitale complessivo. Tassare maggiormente i redditi da capitale più elevati per aiutare la stragrande maggioranza della popolazione
• – Aldo Sofia
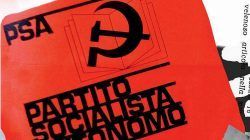
Intervista di Lorenzo Erroi all'ex consigliere di Stato, in occasione della pubblicazione della sua biografia
• – Redazione

Secondo l’attivista Andri Snær Magnason (sabato a ChiassoLetteraria) non basta più dire che occorre agire. Occorre agire.
• – Simona Sala

L’escalation no vax è il conto che paghiamo ad anni di ambiguità e irresponsabilità politica
• – Redazione

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi comunica al mondo via social che si è fatto vaccinare
• – Enrico Lombardi

Per la prima volta dopo ben sette anni incontro fra i vertici israeliani e palestinesi. Non una vera svolta, solo il tentativo di togliere dai guai il leader dell’ANP nei confronti di Hamas
• – Aldo Sofia
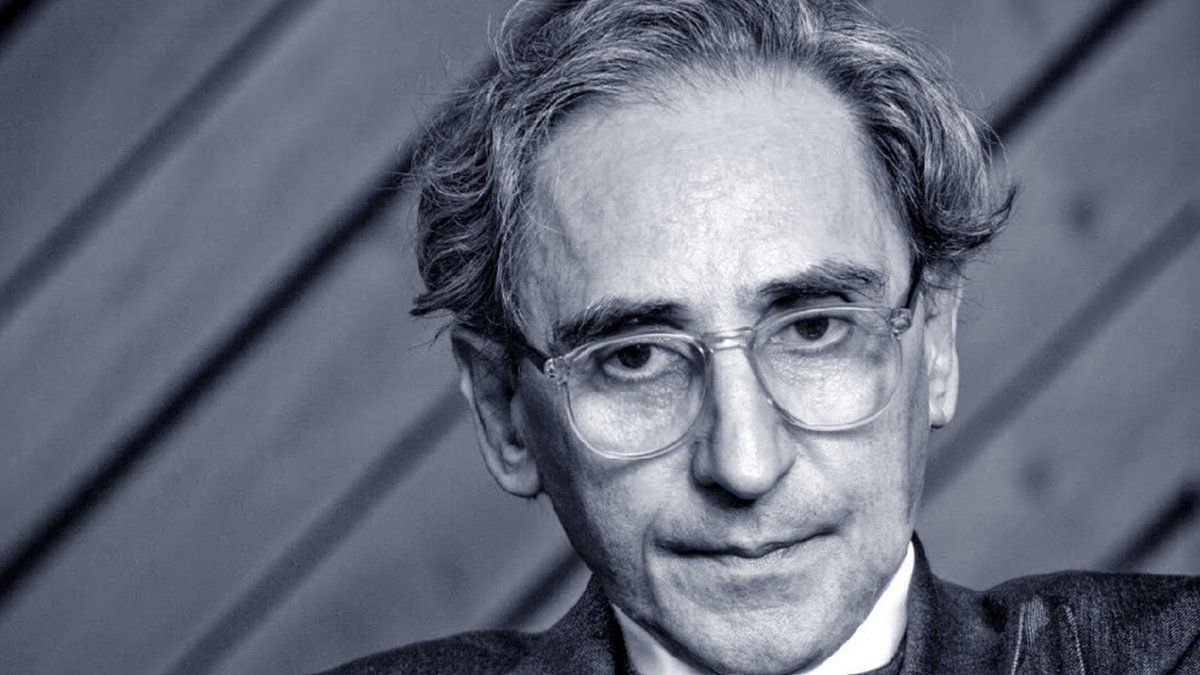
Accettare la fragilità, rinunciare all'idolatria dell'identità - La filosofia al tempo del virus
Tempo fa, ascoltando la sequela di dati quotidianamente somministrati per informare sull’andamento della pandemia, mi è tornato in mente un verso di una meravigliosa canzone di Franco Battiato. La canzone – “Clamori” – composta nel 1982, fa parte di “L’Arca di Noè”, disco non adeguatamente considerato perché successivo a “La voce del padrone”, quello di maggior successo del grande artista siciliano appena scomparso. Un disco più meditativo e intimista, più struggente e lucidamente disperato. Ebbene, a un certo punto di “Clamori”, dopo aver cantato di “neutroni” e “minuscoli computer”, Battiato osserva che «nel fango delle cifre tutto se ne va».
Ascoltavo l’ennesimo bollettino della pandemia e dagli abissi della memoria emotiva sono risalite quelle parole: «nel fango delle cifre tutto se ne va». Niente meglio di quella frase di Battiato esprimeva il mio stato d’animo: una sorta d’incredulo sgomento per il modo in cui nel nostro Paese – ma suppongo in tutto il cosiddetto Occidente “avanzato” – si racconta la morte progressiva e incombente della pandemia.
Sì, perché essendo la morte l’indicibile e l’interdetto dell’Occidente, il rimosso e l’osceno (il fuori-dalla-scena) l’Altro irriducibile al sapere e al controllo tecnologico, la sua riduzione a cifra è il solo modo per addomesticarlo e renderlo presentabile, permettergli di entrare in scena senza recare disturbo.
Cosa significa, infatti, una “cifra”? Una cifra non significa nulla perché non è un segno. Una cifra rimanda solo a sé stessa in un’eterna e vacua tautologia. Una cifra è un nulla di senso laddove il senso non è declinazione ma domanda, è interrogarsi su cosa significhi “questo” e non semplice constatare che questo “è”. Senso è scarto irriducibile alla parola e alla definizione, laddove la cifra è sempre solo ciò che dice di essere, senza scarti né resti. Ma cosa accade se la logica quantitativa viene applicata a una catastrofe inedita per estensione e rapidità? Cosa accade se i resti umani – cioè i cadaveri – vengono ridotti a cifra? Accade che si risponde all’ecatombe con la più grande opera di rimozione e occultamento forse mai messa in atto nell’Occidente moderno.
Sì, perché essendo impossibile ignorare una tragedia di simili proporzioni, se ne fa una parodia a suon di cifre: decessi, tamponi, ricoveri, indici di contagio e tutta la connessa chiacchiera attorno a vaccini, misure di prevenzione e controllo, orario del “coprifuoco” e diritto all’aperitivo. Parodia inconsapevole, beninteso, proprio perciò immagine attendibile di una desolante incapacità di pensare le “cose ultime” in un frangente in cui esse si manifestano “in presenza”, non più come problema ulteriore e di chissà quale consistenza, cruccio o, magari, trastullo di filosofi.
Già, la filosofia… La grande filosofia pensa da sempre “in faccia” alla morte perché è impossibile pensare dimenticando o rimuovendo il nostro essere mortali: è la morte la base del nostro pensare. Se non fossimo consapevoli del nostro essere “Di passaggio” – altra meravigliosa canzone di Battiato introdotta da un frammento di Eraclito letto in greco – non avremmo nulla a cui pensare perché pensare è riflettere sulla nostra mortalità, sul nostro limite costitutivo. Limite che se da un lato sbarra la vita individuale, dall’altro la stimola a trascendersi, facendo del nostro passaggio terreno un progetto libero dalle pulsioni di conservazione e potere che agitano la vita dell’io massificato e non pensante. Dei tanti insegnamenti ricevuti da un grande filosofo, Carlo Sini, due in particolare mi hanno accompagnato in quest’anno e mezzo di pandemia. Il primo: il sapere di morire è condiviso da tutte le culture e religioni, da che mondo è mondo. È il sapere fondamentale in ogni epoca e a ogni latitudine. Ci fu un istante, nella notte dei tempi, in cui un essere non ancora umano vide un suo simile giacere inerte sul terreno, sordo a ogni richiamo, indifferente a ogni sollecitazione: fu in quell’istante che, preso da stupore e spavento, l’essere conobbe la vita per differenza dalla morte e divenne così un essere umano. La vita non è l’opposto della morte, né la morte la negazione della vita: se non ci fosse morte non ci sarebbe vita, perché il chiarore dell’esistenza non sarebbe percepibile senza lo sfondo oscuro della morte. Secondo insegnamento di Sini: la filosofia non è un “sapere” ma un’etica, un trarre conseguenze dal nostro essere impermanenti, di passaggio. Filosofia è rispondere alla più cruciale delle domande: come impiegare il tempo che ci resta facendo qualcosa di buono e di utile non solo per noi stessi ma anche per i nostri con-sorti, esseri a cui ci accomuna la medesima sorte?
Ma cosa diventa dunque la vita individuale e collettiva se viene amputata dalla coscienza della sua finitezza, limite che ne allarga l’orizzonte e ne rivela la grandezza? Cosa succede se la filosofia, originaria, inesauribile riflessione sul nostro destino, viene insegnata in scuole e università come un sapere senza più legami con le “cose ultime”, sapere erudito e residuale per anime belle o contorte e comunque prive di senso pratico?
La risposta sta nella reazione alla pandemia: la vita collettiva diventa un sopravvivere senza capo né coda, un annaspare nell’eclissarsi delle abitudini, un “horror vacui” da riempire con parole e chiacchiere, un agognare il ritorno a una normalità che, passata l’iniziale ebbrezza, si rivelerà credo – e spero – meno entusiasmante di quello che ci si aspettava, perché gli equilibri psichici non passano indenni da pressioni prolungate e quello che prima saziava verrà percepito come insoddisfacente, come accadde ai pochi reduci della guerra di trincea, che tornati alla vita civile si ritrovarono disorientati e inconfessabilmente nostalgici di quella vita certo spaventosa ma viva al massimo grado, come può esserlo una vita a stretto contatto con la morte.
«La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani» scrisse profetico, a metà dell’800, Sǿren Kierkegaard. È probabile – auspicabile – che, passata la pandemia, siano tanti a sentire il grottesco, il tragico senza grandezza della rotta a cui s’erano abituati, scandita dal menù del giorno dopo. Ma come fare per consolidare un inedito bisogno di senso, un’inedita fame di regioni inesplorate, oltre le pulsioni di conservazione, affermazione e appagamento dell’io?
Occorre educarsi e educare a un’altra vita sulla base di due evidenze smascherate dal virus. La prima: siamo tutti connessi. Non in senso “telematico”, beninteso, ma in quanto inclusi nella Rete della vita. La vita è un evento relazionale e reticolare i cui punti sono ciascuno frutto d’incontri e incroci di altri punti. Non esiste il punto assoluto, il “punto in sé”, autonomo dall’altro da sé. Ogni punto ha l’altro in sé. Se l’Occidente s’incamminasse per questa via potrebbe liberarsi dall’idolatria dell’identità, la sua più grande superstizione, avviando una rivoluzione al tempo stesso culturale, sociale, politica, economica.
Seconda evidenza: siamo tutti fragili di una fragilità non contingente ma strutturale, la fragilità del nostro essere mortali. Per uscire migliorati dalla pandemia dovremmo imparare a vivere ad altezza di morte anche quando la morte non costituirà più una minaccia. Altezza di morte perché la morte ci dà la misura del nostro essere umani, del nostro poter essere comunità. Una civiltà che non riconosce la morte finisce per infliggerla: si uccide l’altro – o lo si lascia morire, nudo e angosciato su barconi a cui si vieta l’attracco – perché così ci si sente onnipotenti, quasi immortali. Mors tua, vita mea. La pandemia ci ha gridato, per un anno e mezzo, Vita tua, vita mea. O sapremo per tesoro di questo grido o finiremo travolti dal «fango delle cifre» che, cantava Franco Battiato, tutto porta via con sé.
Per gentile concessione del sito Sintesi Dialettica


La contaminazione tra il piano giuridico e quello politico rischia di affievolire le speranze di pace

Un'inchiesta del New York Times e del Fuller Project rivela come in Maharashtra le due aziende siano legate, attraverso l’industria dello zucchero, anche ai matrimoni infantili e...