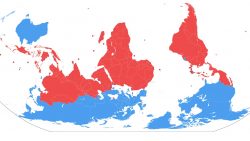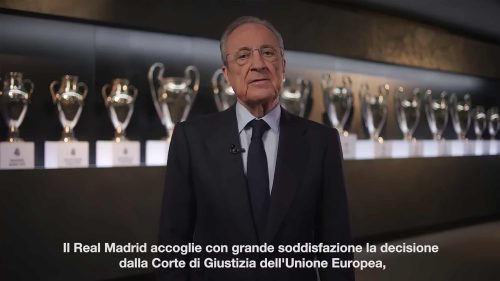Ci sono dunque parole non dette dalla sinistra (
Lelio Demichelis) e occorre dire qualcosa di sinistra, ma anche farlo (
Virginio Pedroni). Sono due contributi, apparsi in Naufraghi/e, seri, densi, di accurata e precisa analisi, storica e critica, che dovrebbero giovare a chi, dentro la sinistra, vuol ancora pensare e progettare e non solo elencare, contare, muovere e spostare sedie.
Appare chiaro che la sinistra non è neppure più uno “spettro (che) s’aggira per l’Europa” (il famoso inizio del Manifesto del 1848), anche se forse fa sempre paura poiché, inspiegabilmente, continua quella che si definiva allora la “santa battuta di caccia contro questo spettro”. E quindi la sinistra non è neppure “un grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis”, come Sartre, intellettuale critico di sinistra, la definiva più di cinquant’anni fa (espressione ripresa poi come titolo di una sua opera critica, nel 2007, dal filosofo, ritenuto di sinistra, Bernard-Henry Lévy). Così oggi c’è chi conclude semplicemente che la sinistra è ormai solo un fantasma.
Il sistema “droitisé”
A giudicare dal numero di saggi apparsi non c’è probabilmente Paese, come la Francia, che negli ultimi tempi si sia tanto interessato allo stato di salute della sinistra. E lo si può anche capire: là è in buona parte spuntata, maturata, nutrita. “La sinistra sta per essere cancellata?”, si chiede il politologo Rémi Lefebvre in un suo saggio (“Faut-il désespérer de la gauche?”, Textuel, marzo 2022); uno dei motivi è che non è più capace, nell’era mediatica, a “pesare sull’ordine del giorno” e “la parola di sinistra si fa rara”. Oppure ogni parola è subito annientata dall’opposizione con l’accusa di vetero ideologismo (la giustizia, la solidarietà),di isterismo, terrorismo e proibizionismo (l’ecologia, l’antirazzismo), di odio o invidia per i ricchi o disfattismo per l’economia (la fiscalità punitiva, la politica sociale irresponsabile, l’interventismo di Stato, la pretesa ridistribuzione della ricchezza, utopistica, incoerente e autolesionista).
Il sistema politico si è invece “droitisé”, si è voltato a destra, se per destra si intende il pensiero che vuole concedere “un privilegio all’esistente e tende a inclinarsi di fronte alla forza delle cose, alla potenza del fatto compiuto”. Ed è elettoralmente pagante per chi lo cavalca.
Sinistra in decomposizione
“La sinistra è in uno stato di decomposizione avanzato e deve staccarsi dai suoi atavismi e dalle sue identità partigiane annidatesi nel XX secolo”, sostiene il sociologo Laurent Jeanpierre (coautore, con Haud Guéguen di “La Perspective du possible”, La Decouverte, gennaio 2022). Quindi sarebbe tutto l’armamentario ideologico da rivedere o abbandonare, tutte le incrostazioni lasciate da epiche lotte che bisogna smettere di mitizzare.
“Viviamo innegabilmente un capovolgimento altrettanto grande di quello della rivoluzione industriale, cominciata alla fine del XVIII secolo”, spiega dunque la storica Marion Fontaine, professoressa alla mitica Sciences Po. C’è stato un mutamento radicale nel modo di lavorare e di vivere “qui touche la gauche de plein fouet”, che ha colpito in pieno volto la sinistra. Sottinteso, quindi, che ne è rimasta stordita e non ha saputo reagire. Tanto che hanno fatto subito eco a questa tesi i celeberrimi “Cahiers Jaurès” (Quaderni intestati e ispirati al grande politico del socialismo riformista dell’inizio Novecento, fondatore del glorioso giornale L’Humanité, grande oppositore della guerra nel 1914, ucciso da un fanatico con un colpo di pistola). “Così la sinistra oscilla tra abbandono e vittimismo (victimisation, per la precisione), glorificazione e nostalgia”.
Crolla la classe operaia, salgono i “diplomés”
Come mai questo stacco delle classi popolari? Si era posto l’interrogativo già vent’anni fa un gruppo di riflessione “Terra Nova” pubblicando una “nota di riflessione elettorale” di un’ottantina di pagine, intitolata “Gauche: quelle majorité électorale pour 2012” divenuto celebre, citatissimo, ma anche “largement décriée”. Forse perché vi si sosteneva che “la coalition historique de la gauche, centrée sur la classe ouvrière, s’efface”. Dunque, se crolla o è perlomeno molto instabile lo storico e costituente pilastro della classe operaia, per tutta la sinistra è il terremoto fatale.
In quel rapporto (che si può ancora trovare su Internet) si rileva però anche un conflitto di valori che oppone il liberalismo culturale dei cittadini diplomati (gli “urbains”) e il conservatorismo sociale degli operai, dei lavoratori, tutti “declassati”.
Emerge allora la critica, frequente anche dalle nostre parti, di una sinistra nutrita (e sostenuta) più da intellettuali che dalla classe operaia. La conclusione che si trae è però emblematica e intrigante: “La nuova sinistra ha il volto del Paese di domani: più giovane, più femminile, più diverso, più diplomato”. Al rovescio, quindi, di quell’elettorato che considera che “la France est de moins en moins la France”, un elettorato inquieto sull’avvenire, più pessimista, più chiuso, più difensivo”.
La strategia elettorale della sinistra dovrebbe quindi fondarsi su una nuova coalizione elettorale:” les diplômés, les jeunes, les minorités, les femmes”.
Una classe senza partito e la moltiplicazione delle schede
Nelle critiche, da sinistra, c’è chi ha visto in tutto questo una sorta di “racisme social” che impregna disgraziatamente i discorsi di sinistra. Chi, invece, il riflesso di una innegabile realtà: i partiti di sinistra sono diventati i “partis des diplômés” (lo sostiene persino l’universalmente noto e celebrato economista Thomas Piketty, autore del “Le Capital au XXI siècle” e di “Capital et ideologie”), mentre la “destra” continua a rappresentare beata le élite mercantili, commerciali, affaristiche, finanziarie. Il denaro, insomma, e l’identità o la spina dorsale del Paese.
C’è chi aggiunge, poi (ma lo fa anche il rapporto di Terra Nova) che “la nostalgie ne fait pas une politique. Il ne suffit de déclarer sa fidélité au monde populaire pour le rencontrer”. Chi chiama quindi in causa due noti studiosi inglesi (Evans e Tilley) e un loro testo (« The New Politics of Class: The political Exclusion of the British Working Class », Oxford Uni Press 2017) per rilevare che… “ci sono nuove categorie popolari che si ritrovano in una classe senza partito”.
E dove sono finite o finiranno? Forse è anche per questo, paradossalmente, che si moltiplicano classi, partiti, schede, sottoschede (vedi Ticino), ognuno alla ricerca… di se stesso. Ma capita come per l’inflazione: si finisce con la svalutazione o la stanchezza della politica. E poi con la derisione e l’astensionismo.
Quella sinistra che non è che non dica, ma… dice sempre troppo in là
Da questo percorso accelerato sull’analisi dello spettro di sinistra in un Paese come la Francia si possono trovare indicazioni interessanti ed anche utili e molti luoghi diventati ormai comuni anche da noi. Si dà appunto per certo, ad esempio, che la sinistra non sa più dire, non sa più parlare, si è staccata dalla realtà, non mette più le mani nella melma quotidiana, arzigogola intellettualmente, gioca solo ai bussolotti elettorali.
A suggerire tuttavia che tutto questo non è proprio vero è la stessa destra. Infatti, perché continua ad avere il dente avvelenato contro la sinistra, perché se ne sente sempre disturbata e si prefigge di annientarla, perché ogni proposta che viene da sinistra (sotto forma di iniziative parlamentari o popolari o anche di referendum) è sempre annichilita con l’immancabile pretesto governativo o parlamentare …che “va troppo in là”(perché non tiene conto della realtà, solitamente finanziaria o economica), perché quando da sinistra si vogliono ad esempio salari più umanamente degni (minimo salariale), imposte più eque (ognuno secondo la sua disponibilità e bando alla storiella imperante per i ricchi o i globalisti che la ricchezza, meno tassata, scorre verso il basso giovando a tutti), premi delle casse malati proporzionali al reddito, pigioni perlomeno più accertate e trasparenti, impegni più definiti e obblighi più precisi per la salvaguardia dell’ambiente, della natura, del territorio, di parchi naturali alpini, la sinistra esce il più delle volte con il collo rotto?
Se dici e fai qualcosa di sinistra sei fottuto
C’è un tipo di analisi che non si osa mai affrontare (ci ha provato in parte il politologo Lefebvre, citato all’inizio). Per dirla, in breve: la sinistra, più di ogni altra formazione politica, è interrogata sulla sua coerenza; essere di sinistra è assai impegnativo, scarnifica alle volte la priorità al proprio interesse (in un’economia e in una società dove l’individualismo, l’egoismo, sono motori di tutto) per far posto all’interesse e al bene comune; essere di sinistra, poi, senza una carica di sana utopia, come funzione stimolatrice dell’azione politica o come efficace critica alle istituzioni vigenti, porta facilmente all’arrendevolezza di fronte all’esistente o al cedimento di fronte all’accusa (da destra ma anche paradossalmente da sinistra) di ideologismo, intellettualismo, distruzione dell’insostituibile economia dei mercato, a danno di tutti (ed è così che si cede alla facile tentazione inoculata dalla destra).
Ci vuole molto meno coerenza per le altre formazioni politiche (ce ne voleva molta per i democristiani, ancorati al cristianesimo, divina utopia dell’eguaglianza e della giustizia per tutti, che con inconsapevole coerenza hanno mollato anche nella loro definizione). Perché conviene l’esistente, mentre quanto ci si chiede dalla natura e dall’evoluzione delle cose o dalle crisi di civiltà e climatiche in atto per farvi fronte e cambiare, comporta ciò che la maggior parte dei cittadini non vuol sentirsi dire, non vuol credervi. Non vuole tanto meno assumersi partecipazione ai costi (abituato com’è all’economia della gratuità), rinunce e condivisioni di responsabilità, mutamenti di stile di vita e necessari condizionamenti alla propria libertà (che finiranno comunque per essere imposti dalla realtà che sta dannatamente mutando, così come le realtà esterne hanno già imposto la frantumazione di qualche mito svizzero, dal segreto bancario alla neutralità, al caso unico).
E così si può capire, facilmente, senza troppi ripetitivi sondaggi, chi saranno i vincitori nelle prossime elezioni federali.
Nell’immagine: una performance del «Blue man group» a Berlino, tra le statue di Marx ed Engels