Cento anni dopo…
La sua domanda è diventata la mia domanda
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

La sua domanda è diventata la mia domanda
• – Riccardo Bagnato

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Secondo il filosofo Étienne Balibar, per evitare una “ricostituzione dei blocchi” va aiutata la resistenza del popolo ucraino (anche consegnando armi) e quella del popolo russo dissidente
• – Redazione

Il contributo di un artista che da anni dipinge il mondo come oggi ci pare evidente che sia
• – Redazione

Russia e Ucraina sono grandi esportatori di acciaio: e in Ticino, importante piazza delle materie prime, hanno una delle loro piattaforme preferite; le sanzioni e la crisi del settore
• – Federico Franchini

L’Europa non invii armi agli ucraini, per evitare lutti e sofferenze maggiori alla popolazione, e per sottrarsi alle politiche imperiali di Russia e Nato
• – Redazione

Difesa nazionale, la Svizzera da sola non potrebbe resistere per più di due settimane a un attacco militare da est: e non lo dice uno qualsiasi
• – Fabio Dozio

Niente festa dell’8 marzo, e carcere per diverse protagoniste della lotta per la democrazia e la libertà
• – Gianni Beretta
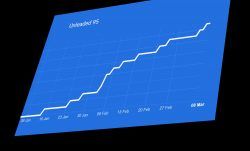
La guerra e l'ultima sanzione USA contro la Russia provocano l'aumento del costo del petrolio, volato a 120 dollari al barile; ma è scorretto l'immediato e forte aumento del prezzo della benzina: un esempio di inflazione + speculazione
• – Aldo Sofia

Si avverte sullo sfondo un tintinnio di carri armati che rivolgono il loro volto minaccioso al Cremlino? Chi sa parli.
• – Redazione
In questi giorni lo sto leggendo e rileggendo.
“La guerra… Son otto mesi, poco più poco meno, ch’io mi domando sotto quale pretesto mi son potuta concedere questa licenza di metter da parte tutte le altre cose e di pensare solo a quella.” Comincia così. Con una domanda che è diventata la mia domanda. Come se lo scoppio di un conflitto debba inevitabilmente segnare un prima e un dopo. Una cesura invalicabile fra la vita che non riesce a credere a ciò che sta accadendo e si ostina a marciare nel pantano delle abitudini, e la vita stracolma, stravolta, sommersa dall’orrore totalizzante di una guerra. Proprio come mi raccontò una cara amica incontrata a Sarajevo tanti anni fa: “il giorno prima avevamo dei vicini serbi a cena, io giocavo coi loro figli, e qualche tempo dopo il padre di quella famiglia ha raggiunto mia madre rinchiusa dietro un recinto, non per aiutarla o chiederle come stesse, ma per domandarle dove fosse finito suo marito”. Un prima e un dopo insomma. Un confine invisibile oltre il quale nulla sarà come prima. O di qua o di là: una logica binaria che nasconde il baratro, dentro cui tutto ciò che sembrava impensabile diventa la norma.
“Ora è certo che non può esser permesso a nessuno di prender congedo dal suo proprio angolo nel mondo di tutti i giorni; deporre sull’orlo della strada il suo bagaglio, lavoro e abitudini, sogni e amori e vizi, via tutt’insieme, come una cosa improvvisamente vuotata di sostanza e di vincoli; scrollarci sopra la polvere del passaggio, voltando come verso un destino rivelato e decisivo un’anima leggera, affrancata da tutte le responsabilità precedenti; fare tutti questi preparativi, con aggiunta di raccoglimento e di ansia e di attesa, prender l’atteggiamento della partenza; e alla fine, non muoversi; non far nulla; stare alla finestra a guardare. Che cosa?” E si risponde.
“Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato, sofferto, resistito per una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più puri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa.
E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un’opera, a un’eredità. Il lavoro che uno ha compiuto resta quello che era. Mancheremmo al rispetto che è dovuto all’uomo o alla sua opera, se portassimo nel valutarla qualche criterio estraneo, qualche voto di simpatia, o piuttosto di pietà. Che è un’offesa: verso chi ha lavorato seriamente: verso chi è morto per fare il suo dovere.” Lui, che in una piccola città di provincia come Cesena torna per riprendersi da un banale incidente, da cui però deve ripartire all’improvviso; che nelle sue “Ultime lettere dal campo” promette a Giovanni Papini di voler terminare breve l’articolo, ma che non è ancora finito; in cui cerca di rassicurare l’amico e direttore de “La Voce” Giuseppe De Robertis che glielo spedirà appena possibile; che sta scrivendo di getto quando può, a volte rimaneggiandolo, altre volte lamentandosi di non avere l’agio di poterlo curare come desidera: “Ricevo solo adesso. Tutto oggi servizio come giorni scorsi. Materialmente impossibile sbrigar niente prima domani sera. Chiedo permesso per domani. Aspetti…” (telegramma del 7 aprile 1915). In questa situazione scrive: “Che cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa?” E osserva: “È vero che questa volta un’ondata profonda pare che abbia sollevato irresistibilmente gli strati più antichi della umanità che s’accampa nelle regioni d’Europa: non è un’avventura o un turbamento locale, ma un movimento di popoli interi strappati dalle loro radici. C’era stata nei primi giorni un’impressione indicibile; come se fosse tornato il tempo delle grandi alluvioni, per cui una razza può prendere il posto di un’altra; l’Europa non aveva più veduto questo da quasi duemila anni: erano i barbari d’allora, le masse della gente nuova, che tornavano a muoversi dai luoghi in cui s’eran trovate ferme alla fine, quando la marea si ritirò; e in tutto l’intervallo movimenti e sconvolgimenti parziali non le avevano più spostate in modo durevole.” Un sentimento che Serra sa di dover mettere sotto la lente di ingrandimento della storia per poter fare i conti con sé stesso: “Crediamo pure, per un momento, che gli oppressi saranno vendicati e gli oppressori saranno abbassati; l’esito finale sarà tutta la giustizia e tutto il maggior bene possibile su questa terra. Ma non c’è bene che paghi la lagrima pianta invano, il lamento del ferito che è rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuta notizia, il sangue e lo strazio umano che non ha servito a niente. Il bene degli altri, di quelli che restano, non compensa il male, abbandonato senza rimedio nell’eternità.” “E poi, di qual bene si tratta? Anche gli esuli che aspettano la fine come il compimento della profezia e l’avvento del cielo sulla terra, sanno che il sogno è vano.” “Forse il beneficio della guerra, come di tutte le cose, è in sé stessa: un sacrificio che si fa, un dovere che si adempie. Si impara a soffrire, a resistere, a contentarsi di poco, a vivere più degnamente, con più seria fraternità, con più religiosa semplicità, individui e nazioni: finché non disimparino…” Impossibile insomma non leggere queste parole senza pensare a quanto sta accadendo ai confini dell’Unione europea. Mentre lo faccio, un flusso continuo di notizie dall’Ucraina rimbalzano ovunque ridisegnando ogni ora una tragedia forse evitabile o per lo meno rimandabile. Tanto che le conclusioni a cui giunge lo stesso Serra sembrano stare lì a farmi da specchio. Cento anni dopo.
“Invecchieremo falliti. Saremo la gente che ha fallito il suo destino. Nessuno ce lo dirà, e noi lo sapremo; ci parrà d’averlo scordato, e lo sentiremo sempre; non si scorda il destino.” E fra le tante notizie che galleggiano ogni giorno sulla nostra distrazione, due in particolare mi hanno colpito. Non quelle degli ospedali bombardati o dei bambini uccisi. Queste fanno tragicamente parte della guerra e per quanto strazianti non possono essere capite, ma vissute. Sarebbe persino ingiusto trattarle come pesi e contrappesi di un ragionamento. No, mi ha colpito, da un lato, la breve dichiarazione del ministro degli Affari esteri cinese secondo cui “le mosse della Nato guidata dagli Stati Uniti hanno spinto la tensione Russia-Ucraina al punto di rottura”. Una lettura partigiana di un problema ben più complesso a cui in questi stessi giorni fanno eco in tanti con improbabile equidistanza, ma soprattutto: un’inquietante sterzata sulla curva diplomatica adottata fin qui da Pechino. E dall’altra, mi ha sorpreso il rifiuto di due storici amici di Washington, l’Arabia Saudita e gli Emirati Uniti che si sono rifiutati di aumentare la fornitura di petrolio.
Mi sono chiesto allora: stiamo forse sottostimando l’odio seminato dall’Occidente per decenni? Forme diverse di antioccidentalismo si stanno forse saldando intorno a noi per farci pagare il conto? O… queste domande sono il frutto di una più banale ma non meno importante paranoia post coloniale? E noi, uomini e donne occidentali, cosa stiamo facendo? Cosa vogliamo? Posto che nulla sarà come prima e che lo statu quo non sarà possibile? “E sarà inutile dare agli altri la colpa. A quelli che fanno la politica o che la vendono; all’egoismo stolto che fa il computo dei vantaggi, e cerca nel giornale quanti sono stati i morti; ai socialisti ed a Giolitti, ai diplomatici o ai contadini. La colpa è nostra, che viviamo con loro. Esser pronti, ognuno per suo conto, non significa niente; essere indignati, disgustati, avviliti è solo una debolezza. La realtà è quella che vale. Anche la disgrazia è un peccato; e il più grave di tutti, forse.” Non mancheranno poi altre voci, mi dico, altri dissidi, altri paesi o governanti che punteranno il dito o rifiuteranno l’aiuto al momento opportuno. L’equilibrio è più precario che mai. Ed è forse inopportuno parlarne per alcuni, ma è al contrario io penso sia urgente invocare ora più che mai un esame di coscienza.
Perché, se è vero che il nostro stile di vita non era negoziabile, come ebbe a dire il presidente degli Stati Uniti, George Bush; se la Guerra Fredda fu vinta dall’Occidente come recitano i libri di storia più recenti; se insomma il nostro modello è il migliore possibile, il più libero, tanto che molti paesi come l’Ucraina stessa ambiscono di raggiungerlo, tutto ciò ha avuto e ha un prezzo di cui non si è fatto ancora un computo morale e forse mai lo si farà. La guerra – direbbe forse Renato Serra – è un evento come tanti altri, non aiuterà a riparare i danni commessi. Non c’è atto di contrizione o sanzione, non c’è accusa o diplomazia, aggressione o trattato che ripaghino gli errori e ora come ora: dar loro un nome o identificarne i responsabili, come vorrebbe il pensiero ingenuo di certi pacifisti o il raziocinio ottuso di certi analisti, alimenterebbe soltanto la propaganda da qualsiasi parte essa provenga.
Un esame di coscienza è cosa ben più seria.
“Fra mille milioni di vite, c’era un minuto per noi; e non l’avremo vissuto. Saremo stati sull’orlo, sul margine estremo; il vento ci investiva e ci sollevava i capelli sulla fronte; nei piedi immobili tremava e saliva la vertigine dello slancio. E siamo rimasti fermi. Invecchieremo ricordandoci di questo. Noi, quelli della mia generazione; che arriviamo adesso al limite, o l’abbiamo passato da poco; gente sciupata e superba. Chi dice che abbiamo spesa male la nostra vita, senza costruire e senza conquistare? Eravamo ricchi di tutto quello che abbiamo buttato; non avevamo perduto neppure un attimo dei giorni che ci son passati come l’acqua fra le dita. Perché eravamo destinati a questo punto, in cui tutti i peccati e le debolezze e le inutilità potevano trovare il loro impiego. Questo è il nostro assoluto. È così semplice!”.
Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato, “La Voce”, numero 10, 30 aprile 1915

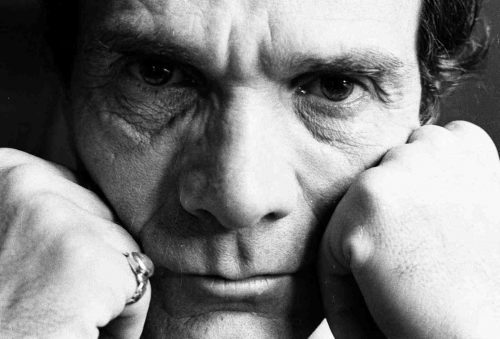
A un secolo dalla nascita di Pier Paolo Pasolini ricordiamo il grande intellettuale con un contributo di Massimo Danzi, professore all’Università di Ginevra, dedicato al rapporto...

Una cupa e cinerea parabola in una notte buia e tempestosa