Dialogare con gli autogestiti?
La prospettiva radicale dell'autogestione vuole difendere gli spazi che sfuggono alla legge del denaro
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
La prospettiva radicale dell'autogestione vuole difendere gli spazi che sfuggono alla legge del denaro
• – Martino Rossi

Qualche riflessione in uno scambio di opinioni fra due amici che amano confrontarsi sulle idee
• – Maurizio Corti e Enrico Lombardi

Il Covid e il rapporto fra malattia ed economia: secondo l’economista Mariana Mazzucato, i politici sono troppo al servizio di Big Pharma e meno delle popolazioni
• – Redazione

E… quel famoso “il futuro di Lugano è nel Kazakistan”
• – Silvano Toppi

Lo scoppio della pandemia, con l’immediata chiusura della Cina e la ricerca affannosa di nuove fonti di approvvigionamento di materiale protettivo sanitario, aveva sin da...
• – Christian Marazzi

La brutta storia dello scandalo Ringier e di un giornalista senza tanti scrupoli
• – Daniele Piazza

Coppa d'Africa iniziata ieri: il calcio può svolgere un ruolo contro la violenza, più che corsi di tattica servono luoghi dove incontrarsi e capirsi
• – Redazione
L’esperienza dell’autogestione luganese è chiamata a definire il proprio futuro non solo alla luce delle risposte repressive che riceve dal Municipio
• – Redazione

Parte stasera su RSI LA1 la quarta stagione della più acclamata fiction svizzera
• – Enrico Lombardi

Perché la richiesta di aiuto militare del regime dittatoriale di Astana non dispiace affatto al leader russo
• – Aldo Sofia
La prospettiva radicale dell'autogestione vuole difendere gli spazi che sfuggono alla legge del denaro
È poi fuorviante il paragone fra la mitica Rote Fabrik di Zurigo e il fu Centro sociale autogestito dell’ex Macello. La Rote Fabrik – pur nata da una dura lotta – è oggi gestita da un’associazione con un’assemblea che si riunisce una volta all’anno, elegge un comitato che designa un gruppo operativo per la promozione di eventi, stipendia 17 collaboratori, incassa 2,5 milioni di franchi di sussidi dalla Città e accetta regole concordate. Nulla a che vedere con il funzionamento del CSOA e il suo conflitto permanente con le istituzioni.
Ho riletto da poco un celebre opuscolo del 1966 che può aiutare a capire lo spirito degli autogestiti o, perlomeno, del loro “zoccolo duro” (ammesso che ve ne sia uno “molle”). Distribuito in centinaia di migliaia di copie in Francia, quel pamphlet di una radicalità assoluta ha contribuito non poco alla grande deflagrazione del maggio 68. Autore: l’“Internazionale Situazionista”, movimento d’avanguardia artistica e politica d’ispirazione marxista-libertaria nato nel 1957 e sciolto nel 1972. Titolo: “Della miseria dell’ambiente studentesco”. La sua prima frase dà il tono: “Possiamo affermare senza grande rischio d’errore che lo studente in Francia è l’essere più universalmente disprezzato dopo il poliziotto e il prete”.
Gli autori condividono quel disprezzo per lo Stato (i poliziotti), per la Chiesa (i preti) e per gli studenti che si illudono di guadagnarsi con gli studi un ruolo di qualche rilievo nella società. Ma ne hanno per tutti: intellettuali (Sartre…), cineasti (Godard…), media (Le Monde…), partiti e sindacati, Stalin e Mao, movimenti radicali dell’epoca, dai Blousons noirs ai Provos agli anarchici, umanisti, pacifisti, sette religiose e, va da sé, capitalisti e borghesi.
Incitano gli studenti, i giovani e i lavoratori a liberarsi dalla condizione alienata di merce fra le merci cui il capitalismo e la società dello spettacolo ha ridotto tutti. La premessa è riconoscersi come “proletari”, dove “è proletario chi non ha nessun potere sull’utilizzo della sua vita e lo sa”. Incitano il movimento di ribellione a organizzarsi, consapevole che “La forma unica del suo potere, l’autogestione generalizzata, non può essere condivisa con nessun’altra forza”. A darsi un programma radicale: “Trasformare il mondo e cambiare la vita”. Non “l’autogestione del mondo esistente, ma la sua trasformazione qualitativa ininterrotta: il superamento concreto della merce” e, quindi, “la soppressione del lavoro e la sua sostituzione con un nuovo tipo di attività libera, abolizione quindi di una delle fratture fondamentali della società moderna, quella tra lavoro sempre più reificato e ‘tempo libero’ passivamente consumato”. A scegliere un metodo: “Le rivoluzioni proletarie saranno delle feste o non saranno”. A darsi uno scopo ultimo: “Il gioco è la razionalità ultima di questa festa, vivere senza tempi morti e godere senza ostacoli sono le sole regole che potrà riconoscere”.
“Vaste programme” direbbe De Gaulle. Non so se i nostri “molinari” conoscano quel pamphlet e se la loro radicalità sia diversa perché “alla svizzera”. Ma lo spirito sembra analogo: nessuna trattativa, nessuna regola, nessun dialogo; gli spazi dell’autogestione non si ricevono in concessione, si conquistano. Lenin lo chiamava “estremismo, malattia infantile del comunismo” e lo combatteva. Ma la pura repressione non è nel Dna di una società democratica. In una riedizione del 1995 del pamphlet si legge che esso appartiene alla storia della sovversione, a un’epoca ora terminata. Eppure il movimento dei “molinari” per l’autogestione non è solo un anacronismo. È anche una luce accesa nella palude grigia di un mondo “reificato” (dove ogni rapporto umano tende a essere uno scambio di cose, tutto si vende e tutto si compera) ed è un bene che rimanga accesa.
Poi, lo “Stato di diritto” dovrà svolgere il suo ruolo, purché imparziale: per esempio, distinguendo la demolizione notturna di un edificio da un graffito sulle vetrine di una banca…


Spunti di riflessione in margine alla serata di Naufraghi/e dedicata all’autogestione
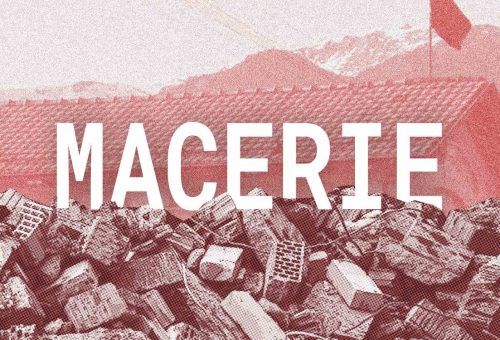
Ascolta il podcast sulla storia dell'autogestione