Diecimila miliardi anti-Covid
Incontro con Laurence Boone, la donna a capo dell’ufficio economico dell’OCSE: crescita, ma restano molte insidie
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Incontro con Laurence Boone, la donna a capo dell’ufficio economico dell’OCSE: crescita, ma restano molte insidie
• – Redazione
Il rafforzamento continuo della nostra moneta è un rischio o ci mette al riparo dalla galoppante inflazione a livello internazionale?
• – Aldo Sofia

Un libro importante ed un film di cui tutti parlano per pensare al futuro del Pianeta
• – Enrico Lombardi
Di Andrea Sala, Maurizio Cerri, Mauro Piazza, Fiorenzo Ardia Siamo quattro cittadini del Luganese, abbiamo superato da poco i sessant’anni. Siamo preoccupati per quanto sta...
• – Redazione

La condanna della dittatura dei Talebani non esclude la critica all’abbandono del popolo afghano anche alla fame e alla povertà: la politicizzazione dell’aiuto umanitario è intollerabile
• – Aldo Sofia

Responsabilità morale e calcoli politici. Perché aiutare gli afghani nella grave emergenza umanitaria e alimentare
• – Aldo Sofia

Intervista a Mahbouba Seraj, attivista afghana per i diritti delle donne
• – Filippo Rossi

Dopo la rioccupazione dell’ex-Macello e lo sgombero a sorpresa si torna ai comunicati dai toni piccati di chi, naturalmente, è senza colpa
• – Enrico Lombardi
Per I Verdi di Lugano capire le ragioni degli autonomi è la condizione necessaria per iniziare un dialogo
• – Redazione
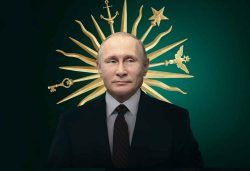
Così la Russia è diventata una dittatura senza bisogno di aggettivi
• – Redazione

Incontro con Laurence Boone, la donna a capo dell’ufficio economico dell’OCSE: crescita, ma restano molte insidie
Dopo due anni di pandemia, l’economia sembra poter ritrovare i livelli pre-crisi: per l’ Organizzazione per la collaborazione e lo sviluppo economico (OCSE) si può allora affermare che vada tutto bene?
Grazie alla campagna vaccinale, ma anche alle politiche monetarie e fiscali, l’economia mondiale ha attutito l’enorme choc provocato da Covid 19. Le imprese sono tornate a produrre e hanno mantenuto il personale. Il tasso di crescita mondiale ha ritrovato nel 2021 un livello di circa il 3,1%, all’incirca quello di fine 2019. Ma non tutto è al meglio. Sono presenti squilibri e rischi di sbandamento. La campagna vaccinale non ha potuto raggiungere tutti, e questo aumenta l’incertezza sanitaria. Alcuni paesi chiudono le frontiere o rendono più severe le regole in fatto di mobilità, e così si creano imbottigliamenti e lunghe attese nei porti e alle dogane. I consumatori chiedono beni, piuttosto che servizi. Infine, alcune nazioni registrano tassi di inflazione che cominciano a diventare allarmanti.
Si riesce a calcolare quanto sia costata finora la pandemia?
Naturalmente il primo ‘costo’ è quello umano, ed è immenso. Poi viene l’aspetto finanziario. Le politiche di sostegno [da parte degli Stati, ndt] sono costate circa 10 mila miliardi di dollari, e l’indebitamento pubblico è aumentato del 15% del Prodotto interno lordo mondiale. Era importante intervenire per preservare imprese e impieghi, e consentire all’economia di uscire da questo ‘choc’ nelle migliori condizioni possibili. Ma non è finita: numerosi settori sono ancora i n sofferenza, in particolare il turismo, oppure l’organizzazione di eventi che registra una concentrazione di persone poco qualificate e contratti precari. L’impatto non finanziario, che in questa fase non si può misurare, riguarda più settori, facciamo anche solo il caso dell’educazione. In Colombia, da due anni i bambini non vanno a scuola, ed è un fatto inquietante per il futuro. Non è stata ancora quantificata la spesa sanitaria globale. Medici, infermieri e altro personale operante in questo settore hanno lavorato milioni di ore supplementari per salvare numerose vite, e questo non ha prezzo. Ciò detto, le crisi provocano anche dei cambiamenti. Per esempio, c’è stata una accelerazione dell’uso del numerico e del nostro modo di lavorare. E’ necessario che la campagna vaccinale continui e si estenda, l’incertezza è grande; ma supponendo che la situazione sanitaria possa migliorare, gli attori pubblici potranno intraprendere una normalizzazione della politica monetaria e fiscale. In questo modo riusciranno a riorientare gli investimenti pubblici nell’ambito dell’educazione, della sanità e della transizione energetica. Diciamo che per il 2022 l’OCSE è prudentemente ottimista.
La FED, la Banca centrale americana, prevede di alzare i tassi di interesse. Si può affermare che è così cominciata la lotta all’inflazione?
Non tutte le nazioni hanno gli stessi tassi inflazionistici. I prezzi crescono più negli Stati Uniti (+5,4% nel 2021) che in Europa, e anche in Europa gli aumenti sono più importanti nel Regno Unito che nell’Unione Europea. C’è però un comune denominatore: le tensioni nelle catene di approvvigionamento, che spingono i prezzi al rialzo. Comunque ci sono paesi in cui l’inflazione cresce velocemente, per esempio là dove c’è un eccesso di domanda e si registra una tensione nel mondo del lavoro che produce salari più alti. Non credo che la Banca centrale europea seguirà la strada tracciata dalla FED, le situazioni americana ed europea sono molto diverse.
Lei ha parlato di disoccupazione in possibile crescita, eppure si registra anche una penuria di manodopera
Si, certi settori, in particolare la salute e la produzione manufatturiera, mancano di braccia, mentre l’industria del turismo soffre la disoccupazione. Bisogna aiutare le persone che hanno visto il loro lavoro compromesso dalla pandemia, aiutarli a trasferirsi in settori che assumono ancora. Anche l’immigrazione controllata può rappresentare una risposta alla penuria di specialisti.
A quali categoria dobbiamo essere particolarmente attenti?
La perturbazione o la rottura della catena di approvvigionamento e distribuzione, provocate principalmente dalla situazione sanitaria e dai suoi effetti-stock colpisce le attività economiche. Dobbiamo continuare a monitorare attentamente la situazione sanitaria, in particolare a causa delle nuove varianti del Coronavirus, che possono a loro volta irretire la crescita. Se apparisse una variante ancora più inquietante di quelle in circolazione, ciò potrebbe compromettere la fiducia di certe imprese, far scendere la domanda e ulteriormente spingere i prezzi al rialzo.
La tassa unica sulle imprese ‘numeriche’, sulla quale l’OCSE lavora da anni, dovrebbe far crescere le entrate pubbliche. Per arrivarci, quali sono le prossime scadenze?
Lo scorso ottobre, 134 nazioni, che rappresentano insieme il 90% del PIL mondiale, hanno concluso un accordo senza precedenti per adattare il sistema fiscale internazionale alla realtà. Ora occorre tradurla in leggi nazionali. Il primo passo prospetta un’allocazione dei benefici delle multinazionali nei paesi in cui queste operano, e si calcolano diritti per un totale di 125 miliardi di dollari all’anno. L’altro passo consiste in un tasso minimo globale di imposizione sui benefici a partire da 750 milioni di dollari per le multinazionali, e questo dovrebbe aggiungere altri 150 miliardi per le casse degli Stati. Gli effetti cumulativi della tassa numerica saranno dunque significativi. Il primo passo dovrebbe essere concretizzato alla metà del 2022, con una messa in applicazione prevista per l’anno successivo. Per l’altra fase pensiamo che comincerà ad essere messa in pratica già nei prossimi mesi. O, quantomeno, è ciò che l’OCSE spera.
La pandemia ha fatto dubitare del sistema della mondializzazione. Qual è la vostra opinione?
Questo problema ritorna come… un serpente di mare. Il movimento delle merci, dei capitali e delle persone evolve di continuo. Capisco che si ci si ponga la domanda che mi rivolge, anche a causa della chiusura delle frontiere, e della rottura delle catene di approvvigionamento. Ma quando si guarda agli scambi degli ultimi due anni, si può notare che essi in realtà sono aumentati. Ciò che va fatto, è assicurarsi che le catene di produzione esistenti attraverso continenti, paesi e regioni possano reggere gli effetti dell’urto pandemico. Per raggiungere questo obiettivo, occorre diversificare le fonti di approvvigionamento, ed assicurarsi di avere le necessarie capacità di produzione per certi beni strategici o essenziali.
Come giudica le tensioni fra Cina e Stati Uniti? In che modo possono impattare negativamente sull’economia mondiale?
La Cina è diventata la prima esportatrice mondiale e la seconda in fatto di importazioni. Dunque, il resto della comunità internazionale sarebbe danneggiata in caso di nuove tensioni commerciali. Bisogna anche rimanere vigili sul fronte degli investimenti. Di recente, abbiamo visto imprese cinesi costrette a lasciare Wall Street. L’altra grande fonte di tensione riguarda le tecnologie e gli standard di controllo, visto che ognuno vuole imporre i propri.
Come giudica lo stato dell’economia svizzera?
Mostra molta resilienza, dunque capacità di superare eventi traumatici. Nonostante una contrazione del Pil del 2,5% nel 2020, la Svizzera ha fatto molto meglio di altri paesi. Soprattutto ha ritrovato la crescita nella seconda parte del 2021. L’economia elvetica rimane competitiva a livello internazionale, e si basa su strutture solide. Le sue politiche restrittive nei confronti del Covid sono state meno severe di quelle praticate da altri paesi, e Berna ha adottato rapidamente misure di sostegno sia alle imprese sia ai lavoratori. Noi prevediamo un tasso di crescita del 3,5% per il 2022. Un risultato molto positivo.

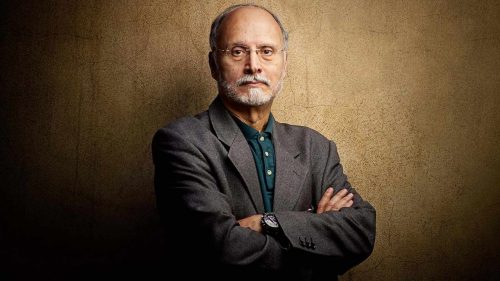
Intervista al noto politologo francese Gilbert Achcar sulle condizioni necessarie per arrivare ad un vero cessate il fuoco in Ucraina

Utili crollati, eppure Sberbank resiste e negli ultimi mesi aumenta le entrate sul mercato interno: segno che le sanzioni internazionali non bastano a polverizzare l’economia...