Giustiniano e la piscina privata
Ovvero, quando un bene comune viene privatizzato e diventa un affare
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Ovvero, quando un bene comune viene privatizzato e diventa un affare
• – Silvano Toppi

I vertici dell’esercito svizzero chiedono miliardi per nuove armi, mentre sulla consigliera federale Amherd si addensano le ombre per l’affare RUAG e per i problemi del contratto d’acquisto degli F-35
• – Fabio Dozio
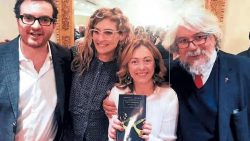
Torna a galla un saggio misconosciuto pubblicato dalla premier italiana nel 2019 che attacca gli africani e denuncia il «razzismo all’incontrario»
• – Redazione

Le strategie per contrastare la crisi climatica e spingere per la transizione ecologica passano da un mercato capace di puntare su settori puliti e da uno Stato pronto a catalizzare l’innovazione per tutti
• – Redazione

La grande crisi dell’immobiliare cinese investe un settore che rappresenta addirittura il 30 per cento del Pil nazionale; i timori occidentali di un contagio finanziario
• – Aldo Sofia

Cinquantacinque anni fa l’intervento dell’Urss soffocava l’esperimento del “socialismo dal volto umano”; una testimonianza particolare - Di Vera Snabl
• – Redazione

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

La navicella si è schiantata sulla superfice lunare per un errore di calcolo; un fallimento che pone fine al tentativo di un ritorno della Russia nella ricerca spaziale avanzata
• – Yurii Colombo

Svolta storica nel dopo voto spagnolo: autorizzato l’uso delle lingue regionali in parlamento
• – Ruben Rossello

La storica Tipografia Elvetica di Capolago risorge per la terza volta grazie a una coraggiosa iniziativa privata e rivive in un romanzo storico appena pubblicato
• – Michele Ferrario

Ovvero, quando un bene comune viene privatizzato e diventa un affare

Le piscine private sono semplicemente una forma di privatizzazione di un bene comune che diventa, sempre più, aberrante, ingiusta, insostenibile. Questa dovrebbe essere la sostanza del discorso. Riprendo, in buona parte, un articolo che, partendo da altri dati di fatto e da altre considerazioni, ho scritto per la rivista dell’Acsi (La Borsa della Spesa) e che apparirà sul numero di agosto.
Dovrei cominciare con una frase in latino: « Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens… ». Traduco : « E per diritto naturale sono beni comuni di tutti: l’aria e l’acqua fluente… ». Si trova nelle « Institutiones » (Istituzioni) dell’imperatore Giustiniano (anno 533 d.C.), riprese dal diritto romano, fondamento dei nostri codici civili e della nostra civiltà. E si insisterà: l’acqua è cosa comune, essenziale e come tale sottoposta a giurisdizione umana, non appropriabile, extra-commercium (fuori dal commercio, nel senso che non può essere un bene speculativo). Perché risalgo così addietro ? Per ricordare che è un principio (e un comandamento) sacrosanto, scolpito nella pietra, come per le tavole di Mosè. Pensarla diversamente è dunque un delitto.
Ci sono voluti quasi 1500 anni prima che l’attuazione di quel principio, l’accesso all’acqua (approvvigionamento sufficiente, fisicamente accessibile, a un costo sostenibile) fosse riconosciuto come un diritto fondamentale dell’uomo da parte delle Nazioni Unite. Sono solo una dozzina gli Stati che l’hanno riportato nella loro Costituzione. Tra i paesi ricchi unicamente il Belgio l’ha previsto.
Nella Costituzione svizzera c’è un lungo articolo sulle acque (art. 76) : vi si parla dell’utilizzazione parsimoniosa, della protezione e difesa dagli effetti dannosi; il resto degli altri cinque capoversi ha natura prevalentemente economica (sfruttamento idrico, proprietà, canoni d’acqua ecc.).
Perché ricordo tutto questo? Per tre ragioni. Per rilevare che l’accesso all’acqua è un diritto di ogni uomo ma non è sempre esercitabile e impone dunque doveri che vanno al di là del «particolare» geografico o finanziario; che l’acqua è un bene comune che si fa però sempre più raro, ha un costo, pone problemi d’investimento o di spesa pubblica, induce quindi a tentazioni e a soluzioni di scarico e di «liberazione» da parte dell’ente pubblico o stuzzica appetiti commerciali di gruppi e multinazionali; che conseguentemente una delle minacce incombenti o in parte già in atto, anche alle nostre latitudini, facilitata da ideologie economiche imperanti, sta nell’appropriazione sistematica di questo bene comune e nella sua privatizzazione. Proponendo anche «escamotages» particolari da società private (com’è capitato a Ginevra) che, con l’abbonamento mensile ad aggeggi particolari, forniscono e garantiscono… la purezza dell’acqua pubblica del rubinetto.
Quest’ultima è la ragione che più deve allarmarci e deve mobilitarci: nel terzo millennio le frontiere del profitto si sono infatti spostate in maniera sfrontata e antiumana sui beni comuni naturali e sui beni pubblici. Uno dei pretesti per questo spostamento «contro-natura» è l’immancabile aspetto finanziario. Ci si dice, anche da parte dei governanti: sostenere che l’acqua è un diritto non deve farci dimenticare ch’essa è soprattutto un costo: bisogna captarla, trattarla, renderla sicura, incanalarla, realizzare dei sistemi di evacuazione e di epurazione. La continuità e la qualità del servizio impongono comunque la copertura dei costi da parte degli operatori. Questa copertura avviene o attraverso l’imposta, le tariffe eque e l’investimento e la spesa pubblici oppure attraverso il gioco del mercato e (come è emerso soprattutto dopo gli anni 80) attraverso la privatizzazione. La quale permette di trovare i fondi necessari, di ottenere una gestione che si pretende migliore di quella pubblica, senza sprechi, e la sottrazione di pesanti oneri a uno Stato o a un Comune già oberati di debiti. Non si dice però mai che ai costi dei privati si aggiungono anche la necessità di profitto e di dividendi.
Il discorso va però esteso. Nel passaggio dalla saggezza giuridica di Giustiniano nell’Alto Medioevo alla Modernità, i beni comuni sono stati circuiti e spesso fagocitati dal capitale e la natura è via via scomparsa dall’orizzonte delle scelte politiche. La sottovalutazione della natura ha avuto effetti devastanti che sono sotto gli occhi di tutti. La crisi attuale, che è appunto anche una crisi di natura, dovrebbe essere l’occasione per capovolgere le cose e rilanciare quella cultura che ha fondato la nostra civiltà.
Essa richiede, in maniera molto pratica, il sostegno di tutti quei movimenti ambientali e sociali che operano in difesa delle risorse naturali e della giustizia sociale e ambientale e la loro considerazione come istanze che esprimono le esigenze del territorio e dei suoi abitanti.
Solo così si riesce a mettere in discussione quei pilastri su cui si regge l’economia attuale, come l’oblio della natura, la competitività, la produttività, la mercificazione di tutto e l’ottenimento immediato del massimo profitto come regole uniche. O l’accaparrarsi di un bene comune come proprietà esclusiva e individuale perché si hanno le condizioni e i soldi e le facilità discriminanti di mercato e persino di leggi per poterlo fare. In sintesi, l’ingiustizia sociale fattasi anche… ambientale.
Nell’immagine: persone attingono acqua ad un pozzo, miniatura da una versione del XIV secolo del Codice Giustiniano

Malgrado indizi più o meno eclatanti sui suoi rapporti con la Svizzera, l’inchiesta elvetica contro il boss di “Cosa Nostra” si è conclusa con un nulla di fatto.

Ignazio La russa (con l’aiuto di elementi dell’opposizione) eletto presidente del Senato senza il sostegno dell’incavolatissimo Berlusconi, che in aula lo manda letteralmente a......