La cintura di fuoco del Sahel. Caos e guerre nel “grande gioco” africano
Il recente golpe militare in Niger sostenuto dal Cremlino potrebbe gravemente cambiare gli equilibri geopolitici in Africa
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Il recente golpe militare in Niger sostenuto dal Cremlino potrebbe gravemente cambiare gli equilibri geopolitici in Africa
• – Redazione

Se la misura verrà approvata dal Congresso, Taiwan potrà ottenere per la prima volta armi attraverso un sistema finanziato dai contribuenti statunitensi
• – Redazione

La Festa nazionale trasformata in un’occasione d’oro per lanciare la campagna elettorale della destra
• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Deve rispondere anche di cospirazione per aver incitato l’assalto a Capitol Hill; presto potrebbe arrivare pure quella di aver tentato di falsare a suo vantaggio l’esito del voto nello Stato-chiave della Georgia; ma anche una condanna non gli impedirebbe di partecipare alle prossime presidenziali
• – Aldo Sofia

Il settore militare incide in modo devastante sull’ambiente, sia per quanto concerne l’inquinamento diretto sia per le emissioni in atmosfera, ma anche nei protocolli internazionali se ne parla poco
• – Redazione
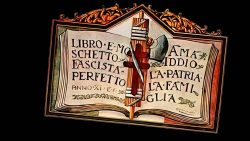
Il mantra populista e la Costituzione federale svizzera del 1848
• – Alberto Cotti

Sulla stampa la campagna UDC contro la cricca rossoverde
• – Franco Cavani

Il moderno Stato federale è nato da una guerra civile 175 anni fa. Ancora oggi deve il suo successo alla volontà di dar voce a sempre più fasce di popolazione. E presto anche agli stranieri?
• – Redazione

Assolti i tre militanti del clima denunciati dal consigliere nazionale UDC Addor e perseguiti oltre misura dalla Procura federale
• – Federico Franchini

Il recente golpe militare in Niger sostenuto dal Cremlino potrebbe gravemente cambiare gli equilibri geopolitici in Africa
Una cintura di instabilità che dall’Oceano Atlantico arriva fino al Mar Rosso e che unisce Mali, Niger, Repubblica centrafricana, Burkina Faso, Sudan e in parte il Ciad. Il Sahel, mai come ora, appare un’enorme fascia di caos. I governi cadono sotto i colpi delle forze militari e paramilitari, mentre all’interno di molti di questi Stati si agitano organizzazioni terroristiche, milizie locali e reti criminali che sfruttano una condizione di endemica debolezza delle autorità locali, in particolare dei governi centrali.
L’instabilità del Sahel, oltre a rappresentare una fucina di crisi che flagellano le popolazioni locali, è inoltre un tema che mette sotto pressione l’intero ordine internazionale. La regione appare come il palcoscenico di un nuovo “grande gioco” in cui convergono gli interessi di molte potenze esterne, dalle più grandi a quelle di livello inferiore. E come afferma una vecchia ma consolidata regola del “gioco”, il vuoto lasciato da una delle potenze viene immediatamente riempito da un’altra: declinazione geopolitica dell’aristotelico “natura abhorret a vacuo”, la natura rifugge il vuoto.
Il golpe in Niger, ultimo di una lunga serie di colpi di mano militari che hanno sconvolto la già fragile condizione del Sahel, fa comprendere in modo plastico questa possibile sostituzione di potenze. Il governo di Bazoum, infatti, era considerato (e lo è ancora in attesa di comprendere i risvolti definitivi del putsch) l’ultimo bastione filo-occidentale nel cuore dell’Africa.
Militari francesi, statunitensi, francesi, italiani e di altri contingenti europei rappresentavano il legame tra Niamey e l’Occidente, con la base di Agadez a fare da hub strategico. Con il golpe, sono invece spuntate le bandiere russe, e l’assalto all’ambasciata transalpina è stata la fotografia più rilevante di questo “regime change” che ha investito anche l’opinione pubblica nigerina. Anche se Mosca non sembra volere dare riconoscimento ai golpisti, sostenendo il governo legittimo.
La Comunità dell’Africa occidentale ha minacciato l’uso della forza per ripristinare l’ordine costituito. E mentre Parigi inizia l’evacuazione dei civili, seguita dagli altri governi occidentali, il Regno Unito annuncia di sostenere Ecowas nelle sue eventuali azioni in Niger. A conferma che Londra non dimentica quanto accade poco lontano dalla sua tradizionale area di influenza africana.
Non è stato il primo esempio di questa dinamica. Quanto accaduto in questi giorni nella capitale del Niger si era già visto in Repubblica centrafricana, Burkina Faso e Mali, a dimostrazione del rifiuto delle società locali della presenza francese (o di altre potenze occidentali) e dell’approvazione di nuove alleanze con Mosca e a latere di Pechino.
Nel primo Paese, la Repubblica centrafricana, si può parlare di un “caos calmo” controllato dalla compagnia di mercenari russa Wagner. I contractor di Evgenij Prigozhin sono rimasti nello Stato africano anche dopo la rivolta che ha sancito la fine delle azioni della Wagner in Ucraina e nella Federazione russa. E la dimostrazione del legame tra lo “chef di Putin” e il governo centrafricano è arrivato anche dall’intervento di centinaia di mercenari per “controllare la regolarità del referendum” per cui è stato richiesto il lavoro di Prigozhin.
In Burkina Faso è accaduto qualcosa di simile: i francesi hanno ammainato le bandiere nel Paese nel corso di quest’anno a seguito di un crescente sentimento di rivalsa del governo locale contro Parigi. Anche qui, durante i vari golpe, le bandiere della Federazione Russa hanno iniziato a tinteggiare le strade della capitale, Ouagadougou. E l’Eliseo ha dovuto infine prendere atto della mancanza di volontà del governo locale di mantenere la presenza francese nel Paese. Un copione molto simile a quello recitato in Mali, dove le forze russe hanno soppiantato quelle francesi in uno dei grandi territori dell’ex impero coloniale parigino. Mappa di Alberto Bellotto
Il Sudan, ultimo dei Paesi della fascia del caos prima del Niger, continua a vivere in una complessa e tragica guerra civile che da mesi non trova sbocchi. I paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno bombardato nei giorni scorsi una base militare a Khartoum. E dal 15 aprile, giorno dell’inizio degli scontri per il controllo del Paese, i morti registrati sono stati 3.900 morti, con più di tre milioni di rifugiati interni o costretti ad abbandonare il Sudan. Anche qui, come in altri Stati, è arrivata inoltre da anni la rete della Wagner: avamposto russo in un Paese dove Mosca aveva costruito solidi legami certificati dai negoziati per la base logistica di Port Sudan.
Si cadrebbe in errore però se si volesse tutto ridurre a una semplice sfida tra Russia e Occidente. In Sahel, infatti, se è vero che Mosca sfrutta o incentiva il caos e la caduta dei governi legati alle vecchie potenze coloniali europee, esistono infatti altri attori esterni su cui vale la pena riflettere. Uno è la Turchia, che in questi anni ha avviato un graduale processo di penetrazione radicamento grazie a una doppia diplomazia culturale ed economica. Il commercio tra Ankara e i Paesi della regione è aumentato sensibilmente negli ultimi anni, e Recep Tayyip Erdogan ha costruito legami con molti governi (a partire dallo stesso Sudan e in Ciad) attraverso diversi livelli di cooperazione, da quello culturale e religioso a quello economico e militare. I Paesi arabi da anni osservano quanto accade nella regione e cercano di introdursi in Sahel, partendo non solo dal vicino Sudan, al di là del Mar Rosso, ma anche dall’altra porta, quella dell’Africa occidentale. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, come spiega Aspenia, hanno spostato anche nella regione il loro confronto internazionale, scatenando una (non minima) “race to Africa”.
Naturalmente, tutto questo non va escluso dall’altra grande partita, quella della Cina. Non è certo un mistero che Pechino, nel corso di questi decenni, abbia sensibilmente aumentato la propria influenza in Africa. E il Sahel non fa certo eccezione. La necessità di investimenti e di soldi, unita alla ben poca attenzione di Pechino verso le politiche regimi locali, ha fatto crescere in maniera esponenziale l’importanza della Repubblica popolare nell’area. E questo va di pari passo anche con l’inserimento dei russi nella partita africana, in cui possono essere tanto competitor quanto partner. In particolare sotto il profilo militare. Gli Stati Uniti ne sono consapevoli e lanciano allarmi da molti anni. Ma la presenza Usa e occidentale nella regione rischia di essere messa definitivamente a rischio. Se cade il Niger, cade anche la più importante base statunitense nella regione.
Nell’immagine: un aereo militare americano sulla pista della base USA di Agadez (Niger)


Grande manifestazione a Lützerath, in Germania: 30 mila manifestanti sgomberati con la forza dalla polizia. La resistenza ambientalista: “I Verdi ci hanno traditi”

L’invasione dell’Ucraina ha creato il caos nei Paesi dell’ex blocco sovietico. Proteste in Georgia, tensioni in Moldavia, l’ansia dei Baltici e le derive ungheresi. Per evitare...