Le sinistre occidentali devono smettere di parlare al posto degli ucraini
Quando i veri o presunti soccorritori decidono quali sono i bisogni di chi dev’essere soccorso
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Quando i veri o presunti soccorritori decidono quali sono i bisogni di chi dev’essere soccorso
• – Redazione

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

La voglia di musica dal vivo in un’estate che ripropone occasioni più o meno imperdibili ad ogni angolo di strada del Cantone e oltre
• – Gianluca Verga

Emmanuel Macron e Vladimir Putin al telefono quattro giorni prima della guerra
• – Redazione

Quando i sacri confini difesi dal nazionalismo diventano più importanti e cancellano la battaglia per la giustizia sociale
• – Paolo Favilli

Migliaia di persone provenienti dalla Siria e da diversi Paesi africani sono recluse in centri militarizzati, in condizioni inaccettabili
• – Redazione

Finché la legge in Svizzera prevede pene minime per reati bancari, difficile ottenere davvero maggiore trasparenza
• – Federico Franchini
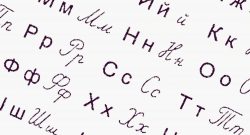
Lingua e identità etnica in Ucraina
• – Redazione

Nel centenario della nascita della grande astrofisica Margherita Hack, il ricordo di una conversazione, fra scienza e fede
• – Paolo Tognina

Intervista ad un’esperta, Patrizia Marti, docente all’Università di Siena
• – Redazione

Quando i veri o presunti soccorritori decidono quali sono i bisogni di chi dev’essere soccorso
Pubblichiamo qui una versione ridotta di un lungo contributo che suggerisce numerose riflessioni e di cui raccomandiamo volentieri la lettura integrale.
Lo scorso maggio, un gruppo di accademici ucraini ha pubblicato sul blog dell’Università di Berkeley una “Lettera aperta a Noam Chomsky (e altri intellettuali che la pensano in modo simile) sulla guerra russo-ucraina”. La lettera invita l’intellettuale e linguista americano a considerare alcuni schemi interpretativi che ricorrono nei suoi interventi sull’invasione dell’Ucraina, giudicati fallaci dai firmatari della lettera.
Siamo un gruppo di economisti accademici ucraini rimasti addolorati da una serie di sue recenti interviste e commenti sulla guerra russa contro l’Ucraina. Crediamo che la sua pubblica voce su questo argomento sia controproducente per porre fine all’ingiustificata invasione russa dell’Ucraina e a tutte le morti e le sofferenze che ha portato nel nostro paese.
In particolare, a Chomsky sono imputate (e contro-argomentate) queste posizioni: 1) negazione della sovranità ucraina su tutto il territorio nazionale; 2) trattare l’Ucraina come una pedina americana in una partita a scacchi geopolitica; 3) suggerire che la Russia è stata provocata dalla Nato; 4) affermare che gli Stati Uniti non sono poi così migliori della Russia 5) occultare i veri obiettivi di Putin nella decisione di invadere l’Ucraina; 6) Sostenere che la Russia è interessata a una soluzione diplomatica; 7) Sostenere che cedere alle richieste russe è il modo per evitare la guerra nucleare.
All’inizio dell’invasione, su OpenDemocracy, lo storico e attivista ucraino Taras Bilous, tra i redattori del sito Commons, ha pubblicato invece la “Lettera da Kyiv alla sinistra occidentale” (tradotta in italiano “Menelique”). L’intervento di Bilous è molto critico nei riguardi della sinistra “campista”, ossia a quella sinistra che, in nome dell’antimperialismo, finisce per sostenere regimi autoritari, minimizzandone le responsabilità perché, in fin dei conti, la loro presenza contrasta il “nemico in casa” (e quindi la NATO, gli Stati Uniti e così via).
Bilous, nelle sue critiche, cita inoltre l’attivista britannico-siriana Leila Al-Shami, che nel 2018 parlava di “antimperialismo degli idioti” per quella parte di sinistra occidentale arrivata a sostenere il dittatore Assad in nome dell’antiamericanismo. All’inizio di maggio, invece, la femminista Ucraina Tamara Zlobina ha criticato su Facebook vari appelli femministi comparsi in Europa, tra cui quello italiano di Non Una di Meno. Scrive Zlobina: Tutti questi appelli suonavano come “Siamo contro la guerra! La guerra è un male. È un gioco da uomini! Vogliamo la pace! Siamo contrari a fornire armi all’Ucraina, perché le armi non farebbero altro che alimentare ancora di più il conflitto. Fermate la guerra con urgenza”.
Nessuna delle “sorelle” ha pensato di consultarsi con le femministe ucraine quando ha scritto queste dichiarazioni (e quando le ucraine le hanno accidentalmente lette prima della pubblicazione e le hanno criticate, le loro voci sono state semplicemente ignorate).
Sembra di assistere a uno schema ricorrente, dove intellettuali e/o attivisti devono chiedere ad altri intellettuali e/o attivisti non solo di evitare di parlare a nome loro, ma di non canonizzare tragici errori interpretativi intanto che lo fanno. Se da noi questa dinamica può sembrare una novità, la lingua inglese ci dice che le cose stanno diversamente, usando l’espressione “westsplaining”.
Termine pressoché intraducibile, westsplaining indica l’accondiscendenza e il senso di superiorità con cui un gruppo sociale (in questo caso “gli occidentali”) pretende di spiegare o commentare questioni che riguardano un secondo gruppo (in questo caso i paesi orientali che hanno avuto regimi comunisti), invalidandone la soggettività e l’esperienza. Linguisticamente, la parole nasce per derivazione da altre simili forme di controllo sociale attraverso i comportamenti, come il mansplaining o il whitesplaining. Benché “occidentale” od “orientali” come categorie siano discutibili o possano suonare troppo vaghe, i nostri palinsesti televisivi offrono carrellate di esempi di giornalisti, intellettuali o artisti che dal febbraio 2022 hanno scoperto di essere esperti di Ucraina e geopolitica.
Lungo la direttrice interpretativa del westsplaining è possibile capire come mai, per esempio in Italia, un considerevole numero di persone scambia l’invasione da parte di un regime autoritario come una guerra partigiana di liberazione dai nazisti. Ed è un problema che merita di essere affrontato, quanto meno per permetterne il più possibile l’individuazione, poiché specie a sinistra rischia di creare spaccature politiche e condannando all’impotenza ogni vocazione internazionalista. In nome del “realismo” occidentale, politici o intellettuali di sinistra, come faceva notare il già citato Taras Bilous, finiscono persino per trovarsi d’accordo con esponenti di punta dell’estrema destra americana – come Tucker Carlson.
Per vedere meglio questo fenomeno e le sue conseguenze pratiche, tra l’aprile e il maggio scorso abbiamo parlato con alcuni attivisti e studiosi provenienti dall’Europa Orientale. A muoverci durante la fase di ricerca e le interviste non è stato tanto il desiderio di raggiungere una verità inconfutabile – quella la lasciamo volentieri ai tanti retori che affollano l’opinione pubblica del nostro paese. Abbiamo cercato invece di spostare il più possibile lo sguardo e il focus del discorso, attingendo a quella risorsa che ogni “saputellismo” stronca sul nascere, e che è invece fondamentale nella comunicazione: l’ascolto. Siamo consapevoli che quanto segue potrà dare fastidio o suonare persino offensivo, ma del resto ascoltare è un’azione che richiede un impegno attivo. (…) Taras Fedirko vive nel Regno Unito, dove è ricercatore presso l’Università di St. Andrews e si occupa di antropologia politica ed economica – in particolare del rapporto tra oligarchie e media nell’Ucraina, suo paese d’origine. Classe ‘90, appartiene a una generazione che nello studiare le dinamiche di potere nel proprio paese ha maturato una coscienza politica. Ha svolto il PhD nel Regno Unito proprio quando è scoppiata la rivoluzione del 2014, che l’ha costretto quindi a seguire gli eventi a distanza per via della coscrizione. Da immigrato, inoltre, ha subito tutta quella retorica xenofoba che ha caratterizzato il Regno Unito negli anni culminati con la Brexit. Perciò, benché sia cresciuto in una famiglia fortemente di destra (“mio padre ha fatto parte di un gruppo di militanti anti-Perestroika”, spiega), politicamente si riconosce nella sinistra.
“C’è questa presunzione secondo cui le lotte politiche che sono importanti per la sinistra occidentale sono necessariamente importanti per la gente in Ucraina” spiega Taras. “I nemici politici della sinistra in Occidente devono essere i nemici della gente in Ucraina o altrove nel mondo. Con questo voglio dire che, negli ultimi 20, forse 30 anni, la sinistra occidentale ha fatto della NATO e dell’imperialismo statunitense il nemico principale a causa della sua espansione, e non per quello che ha fatto al resto del mondo”.
Molti aspetti lo hanno colpito o persino fatto arrabbiare negli ultimi mesi, circa il dibattito sull’invasione dell’Ucraina. Da abbonato dell’edizione americana di Jacobin, si è ritrovato deluso dalla prospettiva adottata, “dal modo in cui parlano della fornitura di armi dei pericoli che ne derivano, il modo in cui parlano della destra ucraina senza esaminare effettivamente l’estrema destra russa, o come usano l’imperialismo russo contro l’Ucraina”.
Il senso di invalidazione non è soltanto ideologico per Taras. Attraverso i media, le narrazioni che vengono imposte, arriva anche al personale, nel quotidiano. La madre di Taras, infatti, vive da tempo in Italia, dove ha ottenuto la cittadinanza, e come secondo lavoro fa la massaggiatrice. “I clienti ora le dicono: ‘Oh, sei ucraina? Come mai siete così testardi?’ come a chiederle ‘Come mai non vi arrendete?’ Sono le stesse persone che 10 anni fa le dicevano quanto la vita in Unione Sovietica fosse meravigliosa, anche se lei faceva notare che, se fosse stato così, non sarebbe venuta in Italia”.
Dato il suo ambito di ricerca, Taras ha studiato l’evoluzione delle oligarchie nel paese, che ben prima della rivoluzione del 2014 hanno usato i media come pedina di scambio con la politica, usando il potere di agenda setting per favorire gli altri ambiti di affari in cui sono coinvolti (energia, acciaio e grande industria in generale). Dopo la rivoluzione di Euromaidan questo tipo di gioco di influenze è diventato in un certo senso più aperto e trasparente, e quindi più cinico. In questo panorama si situano poi con difficoltà i media indipendenti, che sono più aperti e ricalcano il modello occidentale di libera informazione. Naturalmente tra gli effetti della guerra c’è quello di aver sconvolto questo scenario: “Zelensky è passato dall’essere un presidente debole a uno molto forte, essendo il presidente di un paese in guerra”, spiega Taras. “È discutibile fino a che punto il governo stia cercando di volgere a proprio favore questa situazione, o se non si tratti invece di una naturale conseguenza della guerra”.
Il quadro è estremamente complesso, e se pensiamo per un attimo a come l’Ucraina è discussa e rappresentata ci si rende conto che alla fine molto si riduce al ruotare attorno alla “denazificazione” della propaganda russa, fino ai casi estremi in cui il governo attuale viene descritto come illegittimo. Non abbiamo una visione chiara delle contraddizioni che può avere un paese che dal 2014 si trova ad avere un esercito nemico in casa propria. “Questo è uno dei mie problemi con il westsplaining. Manca di empatia. Chi non lo capisce dovrebbe provare sulla propria pelle cosa significa vivere in un paese in guerra ed essere attaccato da missili, perché, sai, non è essere politicizzati da ciò, è semplicemente inimmaginabile”.
Quanto all’estrema destra, e alla sovraesposizione data al battaglione Azov, Taras fa alcuni conti. “Il battaglione Azov conta circa 2000 unità. I partiti di estrema destra alle ultime elezioni si sono uniti in un blocco solo, sai quanto hanno preso? Circa il 2%. Mettilo a confronto con la situazione politica in Francia, o in Polonia, o in Germania, con le infiltrazioni in questi paesi dell’estrema destra nelle forze militari”. Il problema, insomma, non è tanto politico quanto retorico, perché il “nazista” è un tipo di nemico che funziona, incarna il male assoluto. Mentre per una parte della sinistra occidentale vedere un soldato russo con falce e martello, così come l’iconografia alla Babushka, assume un valore eroico con cui identificarsi emotivamente, prescindendo dagli elementi storici più problematici.
Sul Foglio, a metà giugno la corrispondente di guerra Cecilia Sala faceva notare come sul Donbas sia iniziata a calare la “nebbia di guerra”, quella vaghezza di informazioni che prima o poi avvolge le zone di conflitto. Questo cambiamento, secondo Sala, è dovuto a due ragioni: La prima è che a Severodonetsk si combatte strada per strada ed è in corso una carneficina di soldati da entrambe le parti (Zelensky ha detto che sarà ricordata come una delle battaglie più brutali nelle storia militare recente): i soldati sul campo non hanno tempo di raccontare online cosa succede e non hanno più il morale adatto per farlo. Per i giornalisti entrare in città è troppo pericoloso, e non ci sono le foto scattate con lo smartphone dai civili (a Mariupol ce n’erano ancora almeno centomila, a Severodonetsk poche migliaia, forse alcune centinaia).
La seconda ragione è che la guerra è cambiata e gli ucraini non hanno motivo di condividere con il resto del mondo tutte le informazioni dal campo. Non è strano: la fog of war sarebbe la prassi in ogni guerra, ma questa volta l’abitudine a conoscere gli eventi minuto per minuto aveva creato un’illusione e un’aspettativa. La curva dell’attenzione dell’opinione pubblica internazionale si è abbassata per stanchezza, ma incide anche che le notizie e le immagini che ci arrivano siano meno: il flusso si è interrotto e la situazione sul campo è meno chiara.
Alla difficoltà di documentare, si somma dunque il fatto che, lontano dai massacri, non abbiamo poi tutta questa voglia di assistere da spettatori all’orrore. C’è una curva di interesse e senso di responsabilità oltre la quale molti iniziano a sentire la guerra come una tortura cognitiva. Smettere di informarsi, distrarsi, diventa un meccanismo difensivo. Ovviamente chi vive in quelle zone, chi ne è fuggito o chi ha legami diretti non può concedersi quello che, a tutti gli effetti, è un privilegio. Non può permettersi l’oblio, e anzi deve fare i conti con l’essere un superstite, la consapevolezza che non c’è davvero nessun merito nel sopravvivere, nessuna virtù morale, solo l’assoluta tirannia del caos.
Se comprendiamo ciò, comprendiamo anche perché la prospettiva Occidentale, il “saputellismo”, è un meccanismo di potere e controllo sociale. Quando si vorrà smettere di prestare attenzione a conflitti di cui siamo stati in parte responsabili (chi parla oggi contro l’invio di armi dimentica di solito quante ne abbiamo vendute ai russi, in barba agli embarghi europei), le stesse voci che ora affollano talk-show, radio, colonne dei quotidiani di carta o digitali, profili social, teatri e così via, faranno qualcosa di molto semplice. Parleranno d’altro, e non certo per censura calata dall’alto. Questo è avvenuto ad avviene verso paesi come Siria, Afghanistan e Yemen. Se c’è un limite che possiamo concedere al realismo, a ogni realismo, è proprio questo: di avvalorare un campo di osservazione funzionale alle forze egemoni. (…) Per tutti questi motivi, amplificare e moltiplicare le voci dell’Ucraina dovrebbe essere prioritario, in particolare per qualunque formazione o associazione di sinistra – intesa qui nel suo più ampio spettro possibile. Anche solo come esercizio di autoformazione. Così come occorre una effettiva solidarietà, la quale non può realizzarsi se è il solo soccorritore a decidere di cosa abbia bisogno il soccorso, quali siano le sue esigenze. Sul lungo periodo, considerando dimensioni e popolazione dell’Ucraina, se dovessero prevalere il calcolo e il silenzio, milioni e milioni di sopravvissuti diventeranno una testimonianza vivente in tutto il mondo dell’arrogante cecità dell’Occidente. A quel punto, potete starne certi, la loro voce ci diventerà insopportabile. E se i saputelli decideranno di parlarne ancora, probabilmente sarà per dire “insomma, se questi ucraini si fossero arresi subito, invece di ostinarsi a combattere…”

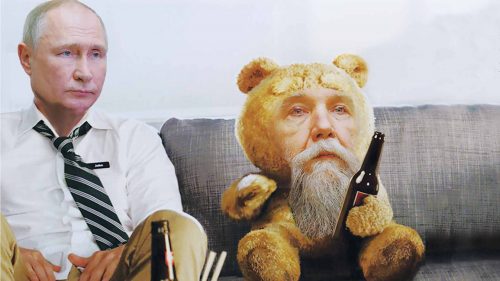
Il padre della giornalista uccisa non è «l'ideologo di Putin», ma con le sue teorie di estrema destra si è costruito fama e seguito in Occidente

L’ennesima tragedia di morti sul lavoro è frutto di una politica imprenditoriale fatta di appalti, subappalti e di condizioni salariali inaccettabili