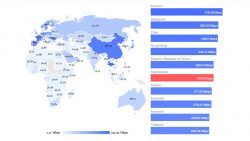Di Loredana Lipperini, L’Espresso
Serena Joy è l’antagonista di June ne “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood. Donna una, donna l’altra. La differenza fra le due è che Joy è la teorica di Gilead e della sottomissione – anzi, dell’annichilimento – femminile, nonché moglie di uno dei peggiori tiranni della teocrazia. Insomma, Joy detiene il potere e ne è contemporaneamente vittima. June prova a ribaltarlo.
Basterebbe leggere narrativa, a volte, per capire che l’idea del «purché sia una donna» è malata e pericolosa. Una delle peggiori delusioni ricevute nella mia storia di lettrice venne dal celebratissimo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, dove si proponeva una serie di modelli femminili forti affinché le bambine in questione crescessero con il proposito di diventare altrettanto «straordinarie». Ma fra quei modelli c’era Margaret Thatcher. La premier della Poll Tax: se ricordate, era un’imposta che entrò in vigore nel 1988 e riguardava ogni adulto maggiorenne, senza distinzione di reddito. Venne accolta malissimo: la protesta cominciò in Scozia e, il 31 marzo 1990, 50 mila persone invasero il centro di Glasgow. Fu un’azione pacifica cui si accompagnò il rifiuto di pagare la tassa. Il blocco di quartieri e case impedì agli esattori di accedere alle abitazioni.
Non andò così a Londra, dove 200 mila persone occuparono Trafalgar Square: la protesta non fu pacifica, né pacifica fu la reazione. I feriti furono più di cento da ambo le parti e 340 furono i manifestanti arrestati. Ma la tassa non veniva pagata. Il rifiuto fu gigantesco. Al punto che Thatcher, infine, diede le dimissioni e il suo successore, John Major, la abolì nel 1991.
Prima però, nel 1987, Thatcher pronunciò la frase che divenne, nei fatti, il manifesto del liberismo: «Non esiste la società. Esistono solo gli individui e le famiglie» (nell’integrale, le sue affermazioni sono ancora più dure: «La società non esiste. Esistono gli individui, gli uomini e le donne; ed esistono le famiglie. E il governo non può fare niente se non attraverso le persone. E le persone devono guardare per prime a se stesse. È nostro dovere badare prima a noi stessi e poi badare anche ai nostri vicini. Le persone pensano troppo ai diritti senza ricordarsi dei doveri, perché non esiste un diritto se prima qualcuno non ha rispettato un dovere»).
Prima ancora (gli archivi sono sempre utili), lo storico Rosario Romeo titolò “Cristo si è fermato a Londra” un articolo dove metteva in evidenza la protervia di una delle donne più spietate della storia recente. Dovrebbe bastare Thatcher per fare giustizia del «purché sia una donna», frase che puntualmente riemerge ogni volta che una di noi raggiunge una posizione apicale, avvenimento talmente poco usuale da diventare, fatalmente, notizia, si tratti di Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Ursula von der Leyen o di Christine Lagarde, di Giorgia Meloni o di Marina Berlusconi.
Accadde, per esempio, ai tempi del governo Renzi, quando dai giornali si ammiccava chiedendo «non siete contente? Su sedici ministri, otto sono donne»: come se si dovesse giocoforza apprezzare il lavoro di chicchessia solo in quanto appartenente allo stesso genere e prescindendo dalle idee e dall’operato. Nel caso, si trattava di mettere da parte, come avviene anche oggi, la questione dei diritti in nome delle risposte urgenti da dare al Paese in sofferenza, senza considerare che, come scrisse Stefano Rodotà, è impossibile un progetto politico a lungo termine che non ne tenga conto. E proprio dei diritti si occupano i movimenti delle donne, che con le donne di potere difficilmente hanno a che fare.
A meno, in effetti, di non essere una piccola ma visibile parte di quei movimenti utile al potere stesso. Proprio alla fine della lunga (e mai davvero tramontata) stagione del berlusconismo era iniziata, infatti, la brandizzazione della «questione femminile», con la frase «siamo dalla parte delle donne» trasformata in spilletta (rosa) che ogni forza politica si appuntava sul bavero della giacca. Salvo poi registrare quasi senza soluzione di continuità passi indietro su decine di punti, dal lavoro alla maternità, dal welfare ai diritti che sembravano acquisiti (aborto, contraccezione) e a quelli mai ottenuti (educazione sessuale e di genere), dal finanziamento ai centri antiviolenza alla messa in ombra dei riconoscimenti base alle persone Lgbt. Eccetera e ancora eccetera.
In altre parole, ci sarebbe quella faccenda semplicissima che dice che non basta essere donne, ma che ci vogliono i temi su cui aggregarsi, e che i femminismi, tirati giù dall’armadio quando servono a dire che, ehi, qui si fa del vero girl power, d’abitudine combattono le disuguaglianze tutte e sono politici, sempre. «Timeo Danaos et dona ferentes». Occorrerebbe temere tutti coloro che sotto il cappello «sono donne, dunque sono nel giusto» lavorano per ridarsi una credibilità, incluse le protagoniste che dicono alle consorelle che tali non sono «nulla ci è precluso», convinte che tutte le donne desiderino il potere e, nel caso, vogliano usarlo come fanno loro, invece di ribaltare quelle logiche.
Ma qui occorrerebbe frugare nelle biblioteche e recuperare un libro del 2009, “La donna a una dimensione” della filosofa inglese Nina Power. In parole molto povere, Power parlava di come la narrazione popolare avesse trasformato il femminismo in tendenza alla moda, che «crede di dover lusingare il capitale per poter vendere con maggiore efficacia il proprio prodotto»: sempre in parole povere, quel tipo di femminismo, quello del «purché sia donna», era entrato a far parte dei meccanismi di controllo sociali, «rappresentando un ostacolo a una vera critica del lavoro, del sesso e della politica. Quello che ha le apparenze dell’emancipazione, nasconde un’ulteriore stretta della catena», con la stessa «blandizie» di cui parlava Michel Foucault. Potere, tacchi a spillo, privilegi, ricchezza, vite performanti, avventure notturne, tailleur firmati, divertimento forzato, ansia da prestazione. “Sex and the City”, certo: un mondo dove le donne sarebbero potenti come gli uomini perché in grado di licenziare un subordinato con lo stesso cinismo, di usare una carta Amex nera e di consumare sesso in una maniera considerata maschile. Non si parlava di scelte individuali, o indotte da una determinata condizione sociale (essere molto ricche a Manhattan): ma di identificazione in un genere sessuale. Una donna che agisce come un uomo.
Non c’è da stupirsi se la rappresentanza, allora, aveva le sembianze di Sarah Palin, Condoleezza Rice e, sempre lei, Christine Lagarde. Non esattamente l’incarnazione di una politica diversa. Bisognerebbe, scriveva allora Nina Power, smettere di desiderare «un’esca democratica», la donna-emblema nei luoghi di potere, ma agire sul piano della rappresentazione prima ancora che della rappresentanza. Rovesciare il tavolo, come diceva Ursula Le Guin, invece di twittare gioiose perché, guarda, al potere c’è una donna (poi ci sarebbe la faccenda dei poteri buoni che non esistono, come cantava Fabrizio De André: ma arriviamoci per gradi).
Nell’immagine: Margaret Thatcher