Ci sono quelli che “prima di sentenziare si dovrebbe conoscere meglio la Storia”. E poi quelli che “tanto dalla Storia non impariamo mai nulla e ripetiamo sempre gli stessi errori”. Modi di dire, che nella loro generica, svagata avvedutezza, portano a chiudere rapidamente qualsiasi approfondimento. A maggior ragione in quest’epoca che pare incapace di rapportarsi sia con il passato, sia con il futuro. Un’epoca fatta di istanti, di un presente che governa assoluto la navigazione di un mondo in tempesta, senza alcuna prospettiva concreta che non sia quella del soddisfacimento dei bisogni del momento. E magari, se proprio si volesse esagerare, propone tutt’al più soluzioni fantasiose di opportunità virtuali, perché il domani è conquista, è “sfida”, poco importa di chi e verso chi.
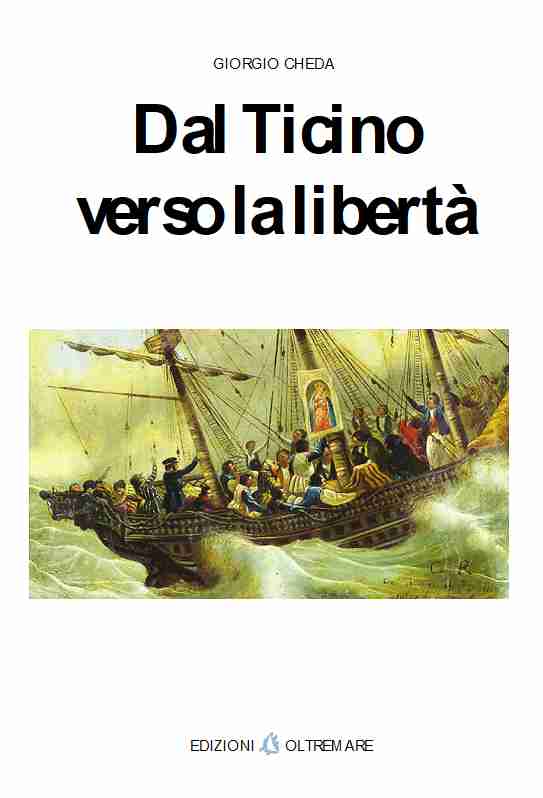 Ma a risvegliarci da queste considerazioni, forse amare, forse pure troppo pessimistiche, giunge un nuovo contributo editoriale di Giorgio Cheda, il nostro massimo storico dell’emigrazione ticinese ( e non solo di quella), che ha da poco pubblicato un volumetto intitolato “Dal Ticino verso la libertà” (Edizioni Oltremare). Nato come nuova introduzione alla riedizione dei celebri due volumi consacrati all’emigrazione ticinese in Australia (usciti nel 1976 e poi nell’81 presso Armando Dadò), questo testo di Cheda, classe 1938, inesausto compulsatore di carte e documenti del Sette-Ottocento, è diventato qualcosa d’altro, o di più: un personale rendiconto delle proprie ricerche passate al vaglio di una costante esigenza di metterle in rapporto dialettico, anche acceso, anche polemico, con la nostra realtà odierna.
Ma a risvegliarci da queste considerazioni, forse amare, forse pure troppo pessimistiche, giunge un nuovo contributo editoriale di Giorgio Cheda, il nostro massimo storico dell’emigrazione ticinese ( e non solo di quella), che ha da poco pubblicato un volumetto intitolato “Dal Ticino verso la libertà” (Edizioni Oltremare). Nato come nuova introduzione alla riedizione dei celebri due volumi consacrati all’emigrazione ticinese in Australia (usciti nel 1976 e poi nell’81 presso Armando Dadò), questo testo di Cheda, classe 1938, inesausto compulsatore di carte e documenti del Sette-Ottocento, è diventato qualcosa d’altro, o di più: un personale rendiconto delle proprie ricerche passate al vaglio di una costante esigenza di metterle in rapporto dialettico, anche acceso, anche polemico, con la nostra realtà odierna.
Come già possiamo ritrovare in non poche pagine di due volumi precedenti (“Nel Brasilio con Francesco” (2018) e “Nel baule del papà Americo” (2020), sempre stampati da Oltremare), anche qui Cheda non resiste all’intima (e preziosa, accidenti!) esigenza di tornare alla Storia per farla parlare, per intrecciarsi con l’attualità locale o globale non importa, fa lo stesso, per “risvegliarci”, appunto, come direbbe anche Edgar Morin in un libro che si è qui ricordato recentemente, per indurci a leggere la realtà alla luce degli eventi passati che l’hanno prodotta e ancora la trasformano.
Perché la realtà è qualcosa che cambia, si modifica, e forse mai drammaticamente come oggi, in quest’era dell’antropocene, diventa qualcosa di incandescente che riaccende esperienze che parevano sepolte (pensiamo alle recentissime vicende politiche italiane) o dà letteralmente fuoco all’Europa in un conflitto assurdo e barbaro, o ancora, incendia il pianeta, giunto al suo grado massimo di tossicità. In questa realtà, ognuno cerca di districarsi alla bell’e meglio, fra elusione, delusione ed oblìo, arrivando addirittura a negare la propria storia, che nel caso nostro (come in quello dell’Italia che distingue artatamente fra naufraghi e migranti) è un passato fatto di povertà ed emigrazione, che, per restare a noi, ha portato ad un consistente abbandono delle valli per cercare una “libertà” che significasse anzitutto la garanzia di una vita degna di tal nome.
Possiamo dunque oggi starcene tranquillamente a sentenziare che per noi la soluzione migliore dovrebbe essere quella di chiudere le frontiere? Possiamo dimenticare in cosa consista davvero l’identità del nostro Paese se non prendiamo atto, una volta per tutte, che da secoli è fatta dalla commistione e dall’intreccio di culture e di popoli diversi, e che così continuerà ad essere, a maggior ragione oggi, nella drammatica situazione “globale”, che ci fa tutti uguali di fronte alle necessità sociali e ambientali?
Sono solo alcuni spunti che ci vengono dal ricco volume di Giorgio Cheda, dalle sue numerose riflessioni legate, appunto, alla messa in rapporto fra ricerca sul passato e situazione presente.
Val la pena, in chiusura, e doverosamente, di lasciare la parola allo stesso Cheda, in questo estratto dal libro.
“Dagli agricoltori del Neolitico che – sbarcati in Gran Bretagna – hanno costruito il monumento di Stonehenge orientato al solstizio d’inverno, fino ai giovani orientali informatici della Silicon Valley e alla diaspora attiva nelle città cinesi, l’innovazione e lo sviluppo sono stati in gran parte promossi dai movimenti migratori. Colpito, a suo tempo, dall’affermazione di Fernand Braudel che la montagna è sempre stata una fabbrica di uomini ad uso altrui mi sono sforzato di abbozzare un fragile schizzo di una microstoria aperta a tutte le discipline, confrontando la staticità dei rurali con il dinamismo delle società in cui hanno operato. L’analisi dei cambiamenti collegati ai movimenti di uomini, idee, prodotti, capitali e pandemie aiuta a non lasciarsi condizionare da quei personaggi carismatici che enfatizzano particolarità locali o confessionali. Uno degli obiettivi della ricerca è proprio quello di confrontare le diverse esperienze comunitarie evitando di ingessare identità regionalistiche che cambiano proprio in seguito alle migrazioni.
Per razionalizzare l’emozione patriottica e scongiurare una suicida chiusura nazionalistica, bisogna anzitutto separare i fatti dai miti (Grütli, Guglielmo Tell, Generale Guisan…), inventati con il pretesto di rafforzare l’unità nazionale. Poi impegnarsi a conoscere le peripezie degli altri, a cominciare da quegli immigrati che, pur sacrificandosi sul cantiere di Mattmark per il nostro benessere, venivano ancora tacciati di cincali da troppi seguaci del razzista James Schwarzenbach.
Integrare cioè l’Inno alla gioia all’insipido Quando bionda aurora che ha già sostituito il precedente bellicoso snudiam l’acciar. Pure l’Europa è il nostro Paese: lo chiedono a gran voce i giovani studenti che beneficiano di Erasmus. L’amore per la patria diventa allora una creativa forma di ospitalità intellettuale e umana che concorre a sciogliere l’antitesi esclusione – integrazione.”
(Da Giorgio Cheda, Dal Ticino verso la libertà, Edizioni Oltremare, pp.36-37)









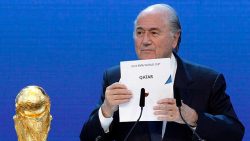
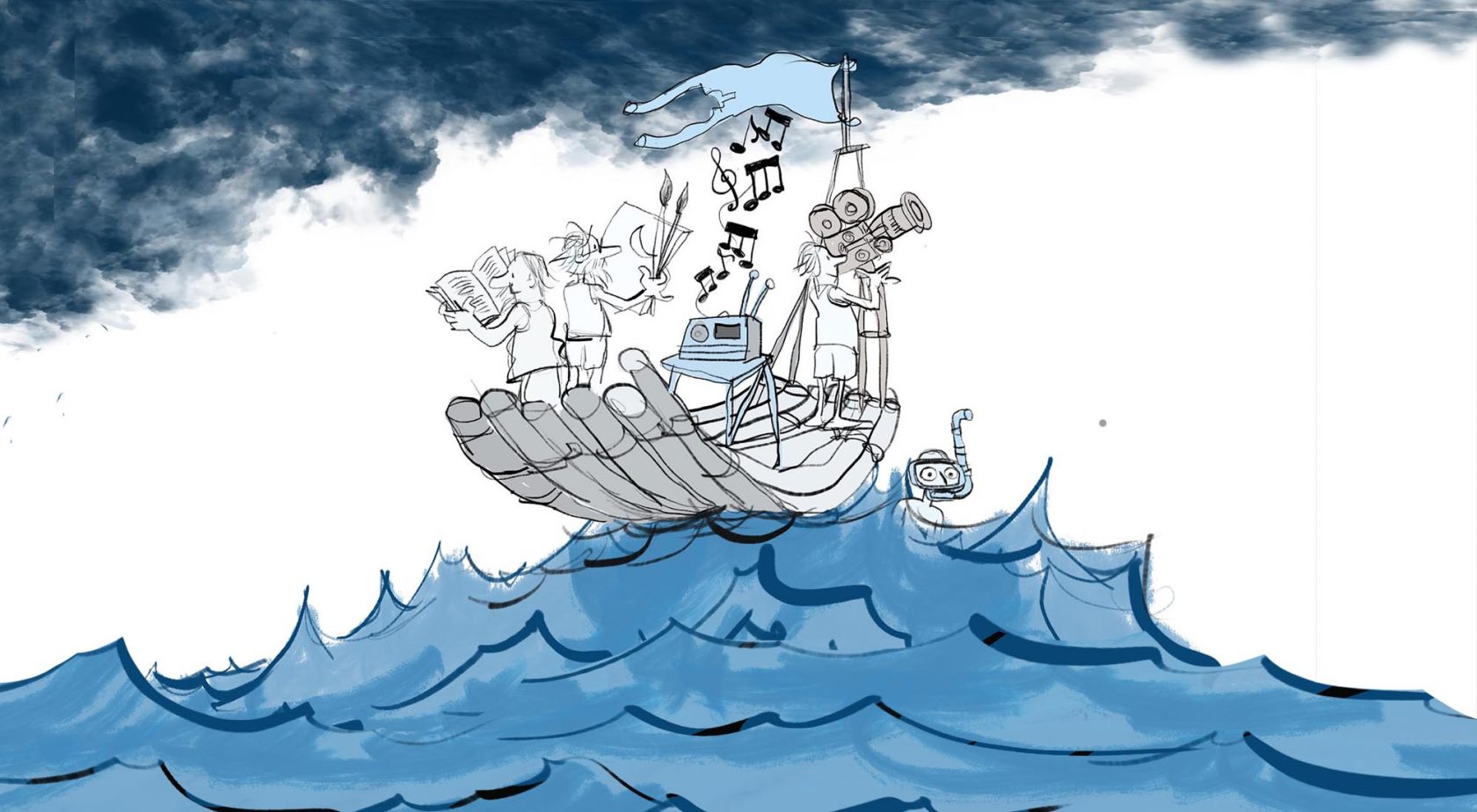
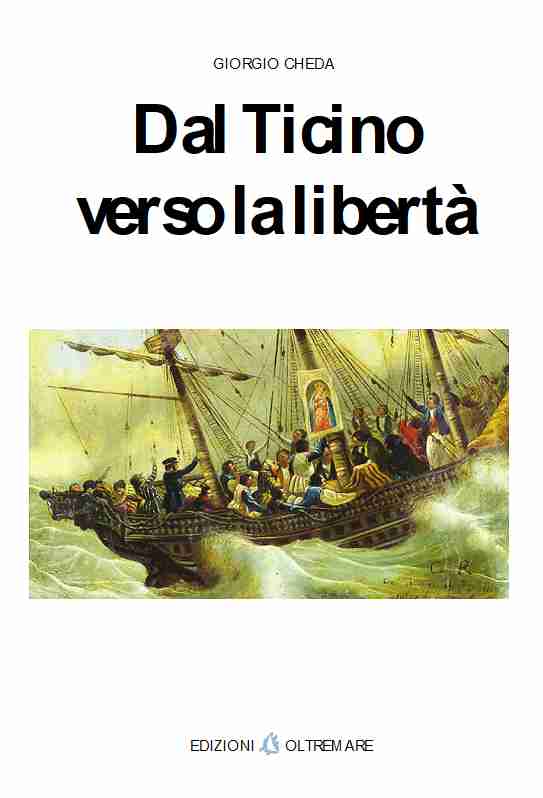 Ma a risvegliarci da queste considerazioni, forse amare, forse pure troppo pessimistiche, giunge un nuovo contributo editoriale di Giorgio Cheda, il nostro massimo storico dell’emigrazione ticinese ( e non solo di quella), che ha da poco pubblicato un volumetto intitolato “Dal Ticino verso la libertà” (Edizioni Oltremare). Nato come nuova introduzione alla riedizione dei celebri due volumi consacrati all’emigrazione ticinese in Australia (usciti nel 1976 e poi nell’81 presso Armando Dadò), questo testo di Cheda, classe 1938, inesausto compulsatore di carte e documenti del Sette-Ottocento, è diventato qualcosa d’altro, o di più: un personale rendiconto delle proprie ricerche passate al vaglio di una costante esigenza di metterle in rapporto dialettico, anche acceso, anche polemico, con la nostra realtà odierna.
Ma a risvegliarci da queste considerazioni, forse amare, forse pure troppo pessimistiche, giunge un nuovo contributo editoriale di Giorgio Cheda, il nostro massimo storico dell’emigrazione ticinese ( e non solo di quella), che ha da poco pubblicato un volumetto intitolato “Dal Ticino verso la libertà” (Edizioni Oltremare). Nato come nuova introduzione alla riedizione dei celebri due volumi consacrati all’emigrazione ticinese in Australia (usciti nel 1976 e poi nell’81 presso Armando Dadò), questo testo di Cheda, classe 1938, inesausto compulsatore di carte e documenti del Sette-Ottocento, è diventato qualcosa d’altro, o di più: un personale rendiconto delle proprie ricerche passate al vaglio di una costante esigenza di metterle in rapporto dialettico, anche acceso, anche polemico, con la nostra realtà odierna.

