Il gioco sporco di Orban ed Erdogan
Era il mantra dopo l'attacco russo all'Ucraina: l'Occidente è unito. Ma ora l'allargamento della NATO è in fase di stallo e due paesi stanno frenando l'embargo petrolifero
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Era il mantra dopo l'attacco russo all'Ucraina: l'Occidente è unito. Ma ora l'allargamento della NATO è in fase di stallo e due paesi stanno frenando l'embargo petrolifero
• – Redazione

Aspettando la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, le speranze e le preoccupazioni per quanto saprà fare Lugano per rendere l’evento davvero un’occasione di svolta. Anche per la città
• – Pietro Montorfani

La forza dell’acqua presenta ancora molte opportunità da cogliere per un futuro energetico rinnovabile e libero da petrolio, gas e uranio - Cristina Gardenghi, Gran Consigliera “i Verdi”
• – Redazione

Un importante (e lungo) testo che propone una lettura articolata dei maggiori temi su cui incessantemente ci si è interrogati in questi mesi di guerra
• – Redazione

Antiamericanismo… americano, il peggio non è mai impossibile; Trump ritornerà e forse è il caso che l’Europa si prepari
• – Silvano Toppi

Quando il deputato Paolo Pamini chiedeva l’introduzione delle armi nelle scuole
• – Redazione
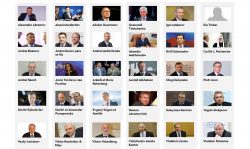
Inchiesta del sito investigativo “Public Eye” sulla presenza e gli averi di una trentina di oligarchi russi in Svizzera
• – Redazione

Nel mondo della libertà di contrapporsi, demolire o costruire rotture
• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Chi si preoccupa della crisi climatica deve imparare a farsi capire
• – Redazione

Era il mantra dopo l'attacco russo all'Ucraina: l'Occidente è unito. Ma ora l'allargamento della NATO è in fase di stallo e due paesi stanno frenando l'embargo petrolifero
Era il mantra dopo l’attacco russo all’Ucraina: l’Occidente è unito. Ma ora l’allargamento della NATO è in fase di stallo e per il momento non esiste un vero e proprio embargo petrolifero da parte dell’UE. Due Stati in particolare stanno frenando.
La tanto decantata unità dell’Occidente sembra sgretolarsi. Ci sono voluti molti sforzi perché gli Stati membri si accordassero martedì su un embargo petrolifero che, su insistenza dell’Ungheria, è così pieno di buchi da non meritare, in verità, il nome di embargo.
In seno alla Nato serpeggia il malumore. In tempi brevi, Finlandia e Svezia dovrebbero aderire all’Alleanza Atlantica, ma anche in questo caso un Paese sta frenando. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan minaccia il veto se non ottiene ciò che vuole.
Era il mantra dei ranghi dell’UE e della NATO all’inizio dell’attacco russo all’Ucraina: l’Occidente è strettamente unito, la Russia può solo perdere. Ma le parole diventeranno anche realtà?
Infatti, non sono solo l’Ungheria e la Turchia ad essere sotto i riflettori; anche la Germania, ad esempio, viene criticata in modo massiccio dagli alleati per aver detto una cosa e averne fatta un’altra riguardo alle forniture di armi. Ma nel caso dell’Ungheria e della Turchia, le spaccature sono particolarmente evidenti, anche perché entrambi gli Stati hanno preso sempre più le distanze dall’UE, molto prima dell’attacco russo.
Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha recentemente accusato entrambi gli Stati di fare il gioco del presidente russo Vladimir Putin. “Stanno aiutando molto Putin, attraverso i finanziamenti e riducendo la possibilità di rendere più sicura la regione baltica”, ha detto, aggiungendo: “Questo solleva ancora una volta la questione se il principio del consenso unanime funzioni ancora nella NATO e nell’Unione Europea”.
Infatti, è proprio questo principio a rendere possibile il blocco delle decisioni da parte di un singolo Stato, e sia la Turchia che l’Ungheria sanno come usarlo.
Lotta all’embargo petrolifero
L’annuncio di Annalena Baerbock è stato ottimistico. Entro pochi giorni, l’UE si accorderà su un embargo petrolifero, ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca. È successo a metà maggio. Qualche giorno dopo, Robert Habeck ha usato più o meno le stesse parole. Dall’Ungheria, invece, sono arrivati toni molto diversi. Quasi contemporaneamente ad Habeck, il Primo Ministro Viktor Orbán ha sottolineato di ritenere improbabile un accordo.
La grande prova di forza si è avuta lunedì, in occasione di un vertice dell’UE a Bruxelles. Gli Stati dell’UE hanno negoziato ad oltranza per raggiungere un accordo, fino a tarda notte. Poco dopo la mezzanotte, è stato raggiunto un compromesso: inizialmente, solo le consegne di petrolio via mare sarebbero state interrotte, ma il petrolio avrebbe potuto continuare a fluire attraverso gli oleodotti. Si dice che sarà per un periodo di tempo limitato, ma c’è già una certa resistenza.
Di questa soluzione l’Ungheria è il principale beneficiario: il Paese riceve due terzi del suo petrolio dalla Russia, principalmente attraverso l’oleodotto “Druzhba”. L’UE si aspetta comunque che l’embargo parziale abbia successo, anche perché Polonia e Germania non vogliono acquistare altro petrolio nonostante abbiano l’accesso all’oleodotto.
L’Ungheria non è l’unico Paese che da tempo rifiuta l’embargo. La Germania, ad esempio, ha bloccato l’embargo per settimane per trovare delle alternative. Poi, circa un mese fa, il ministro dell’Economia Robert Habeck ha annunciato che presto sarebbe stato possibile un embargo sul petrolio. Anche Austria, Slovacchia, Spagna, Italia e Grecia avevano sollevato preoccupazioni.
Richieste che l’UE non può accettare
A maggio, tuttavia, la discussione si è accelerata, l’Ungheria ha continuato a bloccare ogni mossa – e ha messo sotto pressione l’UE con una retorica aggressiva e richieste elevate. La proposta di Bruxelles equivale a una bomba nucleare lanciata sull’economia ungherese, ha dichiarato Orbán all’inizio di maggio. Il suo ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha poi chiesto all’UE 15 miliardi di euro in caso di embargo petrolifero per modernizzare l’infrastruttura energetica ungherese.
Non si tratta solo di una somma enorme, ma quasi una sorta di provocazione che, per ragioni politiche, l’UE non può accettare, anche perché la Comunità Europea sta già tenendo in sospeso i pagamenti all’Ungheria per il rilancio economico post-pandemia finché il Paese non presenterà maggiori garanzie che il denaro sarà effettivamente utilizzato correttamente e non andrà disperso. Le preoccupazioni non sono infondate: Il Paese è tra i più corrotti dell’UE. In risposta, il ministro degli Esteri lituano Landsbergis ha accusato Orbán di ostruzionismo, affermando, a margine di una riunione con i suoi colleghi dell’UE: “L’intera Unione è tenuta in ostaggio da uno Stato membro”.
L’Ungheria come sequestratore di ostaggi? Landsbergis ha colpito nel segno, soprattutto con gli altri Stati dell’Europa orientale del cosiddetto Gruppo di Visegrád. Questa alleanza, nemmeno troppo formale, di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, dopo l’attacco russo all’Ucraina, tuttavia, ha accusato al proprio interno parecchi attriti. Mentre la Polonia vede la Russia soprattutto come una minaccia per l’Europa, l’Ungheria si sforza di avere relazioni sempre più strette e vuole distinguersi come testa di ponte, arrivando persino a mettersi di traverso sulle sanzioni al Patriarca Kirill.
Pur condannando la guerra, Orbán ha sostenuto i passi compiuti dalla NATO e dall’UE, soprattutto all’inizio. A livello di comunicazione interna, ha detto più volte di voler tenere il Paese fuori dalla guerra, che gli interessi dell’Ungheria dovevano venire prima di tutto. Allo stesso tempo, i media filogovernativi non hanno lesinato nel diffondere programmi almeno in parte favorevoli al Cremlino. Difficile comprendere l’atteggiamento di Orbán, ha commentato a marzo il presidente polacco Andrzej Duda, annunciando: “Questa politica costerà molto, molto cara all’Ungheria”.
“Non possiamo permettere che il popolo ungherese paghi il prezzo della guerra”.
Il fatto che Orbán si opponga con tanta veemenza alle importazioni di energia ha anche ragioni di politica interna. Il Paese non solo dipende dalle forniture di petrolio e gas della Russia e ha poche alternative. Mantenere bassi i prezzi al consumo è stata anche una delle promesse più importanti della campagna elettorale di Orbán prima della sua rielezione a marzo.
Il governo ungherese offre ai suoi cittadini prezzi energetici tra i più bassi dell’UE. Inoltre, il Paese fa affidamento sugli investimenti russi, ad esempio nel mega-progetto di Paks II.
La centrale nucleare sul Danubio è attualmente in fase di ampliamento con l’aiuto dell’Agenzia russa per l’energia atomica Rosatom, e sono in costruzione due nuovi reattori. Non solo la tecnologia e il carburante provengono dalla Russia, ma anche gran parte dei finanziamenti.
Rinunciare a questo non è un’opzione per il governo. Poco dopo lo scoppio della guerra, il governo russo ha chiarito che non intendeva interrompere questo collegamento con la Russia. “Non possiamo permettere che il popolo ungherese paghi il prezzo della guerra che infuria oltre il confine”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Szijjarto.
Nell’UE e tra gli Stati membri c’è comprensione per il fatto che l’Ungheria non si libererà del petrolio russo così rapidamente – come altri Stati. Anche la Slovacchia, ad esempio, beneficerà per il momento dell’esenzione per i gasdotti. Tuttavia, c’è rabbia per la mancanza di volontà di compromesso da parte ungherese. Orbán “non dovrebbe essere autorizzato a prendere per il naso l’UE”, ha dichiarato il Presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber alle emittenti RTL e ntv.
Lotta per l’adesione alla Nato
All’interno della NATO, Orbán si trattiene da questi giochi, ma c’è qualcuno che da tempo interpreta il ruolo del frenatore con un fervore forse ancora maggiore: il leader turco Recep Tayyip Erdoğan.
Erdoğan sta attualmente bloccando l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, che il resto dell’Alleanza vorrebbe accogliere a velocità record per le evidenti ripercussioni che assume nei confronti della guerra di Putin. Alla Nato, ancora una volta, il risultato è di 29 contro 1.
Erdoğan sostiene che la sua preoccupazione è che i due Stati dell’Europa settentrionale stiano agendo come “foresterie” per la milizia curda PKK – cosa che non può accettare. Il PKK è considerato un’organizzazione terroristica non solo in Turchia, ma anche nell’UE, perché attacca anche obiettivi civili. La Svezia ha chiesto alla Turchia di cessare gli attacchi alle aree curde e ha proposto un embargo su alcune armi e tecnologie.
Ma Erdoğan vuole di più: vuole che anche le milizie curde siriane come l’YPG siano bollate come gruppi terroristici: ma per l’Occidente si tratta di importanti alleati nella lotta contro l’ancora esistente “Stato Islamico”.
In effetti, è difficile non notare la strategia di Erdoğan: estorcere concessioni agli Stati occidentali e guadagnare punti come duro negoziatore in patria – dopo tutto, le elezioni si terranno di nuovo nel 2023 e la sua autorità è stata scossa dalla crisi economica. In questo senso, ha già ottenuto un successo: una delegazione dei Paesi aderenti del Nord Europa deve recarsi ad Ankara per cercare un accordo.
Erdoğan blocca ancora e ancora
I diplomatici occidentali ipotizzano che Erdoğan non solo chieda di prendere le distanze dai gruppi curdi, ma voglia anche essere riammesso nel programma di acquisizione dei modernissimi caccia F-35 dagli Stati Uniti. La Turchia era stata estromessa dopo che Erdoğan aveva acquistato sistemi missilistici in Russia, nonostante le veementi critiche degli alleati. Il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn ha recentemente definito l’attuale comportamento di Erdoğan “mentalità da bazar”.
Ma Erdoğan ha ancora un notevole margine d’azione, perché sa quanto il suo Paese sia importante per la Nato. Già nel 1952, il Paese ha rappresentato il baluardo contro l’Unione Sovietica, e ancora oggi la sua posizione sul Mediterraneo e sul Mar Nero rappresenta una grande risorsa strategica per la Nato. All’inizio della guerra in Ucraina, Erdoğan ha fatto chiudere gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli alle navi da guerra russe.
Proprio per questo importante ruolo strategico della Turchia, tra i diplomatici occidentali c’è grande indignazione per il nuovo atteggiamento di blocco di Erdoğan, ma la preoccupazione di trovare un accordo affinché l’allargamento a nord possa comunque essere completato rapidamente non è probabilmente molto minore. Il metodo di Erdoğan potrebbe ancora una volta portare al successo, almeno nel breve periodo.


L'attrice sfatò molti luoghi comuni. Uno su tutti: una bionda sexy non può fare ridere

Uno spettacolo “sconcertante, poco edificante e triste”, seguito da milioni di persone via social, induce a porsi delle serie domande sul nostro rapporto con la realtà di vite e...