In basso a destra
Un progetto della Fondazione Federica Spitzer sulla diaspora balcanica nel Canton Ticino
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Un progetto della Fondazione Federica Spitzer sulla diaspora balcanica nel Canton Ticino
• – Pietro Montorfani

Un medium in costante trasformazione tecnica e tecnologica, e costantemente chiamato ad interrogarsi sul proprio ruolo formativo, culturale, identitario
• – Nelly Valsangiacomo

La storia del noto personaggio televisivo raccontata dalla figlia in un libro appena pubblicato
• – Werner Weick

Dei partiti storici e dei nuovi partitini ad personam che si incontrano per conoscersi - Di Aurelio Sargenti
• – Aurelio Sargenti

Emilio Balli rivive al Museo di Vallemaggia in una mostra molto suggestiva ed emozionante
• – Michele Ferrario

Un importante studio sul cambiamento climatico ci avverte: sta per accadere qualcosa di sconvolgente
• – Redazione

La condanna della multinazionale svizzera riaccende il dibattito sugli strumenti di lotta alla corruzione d’impresa
• – Federico Franchini

Un luogo dove si eserciti la cooperazione, la comunicazione, la creatività, l’autonomia dell’allievo con maestri normali, né eroi né missionari
• – Adolfo Tomasini

L’agguato, gli spari, la morte dell’amico e collega nel racconto di Corrado Zunino, inviato di “Repubblica”, anch’egli ferito
• – Redazione

Un mondo in cui banca vuol dire finanza e la finanza si muove secondo principi che non hanno nulla di etico
• – Silvano Toppi
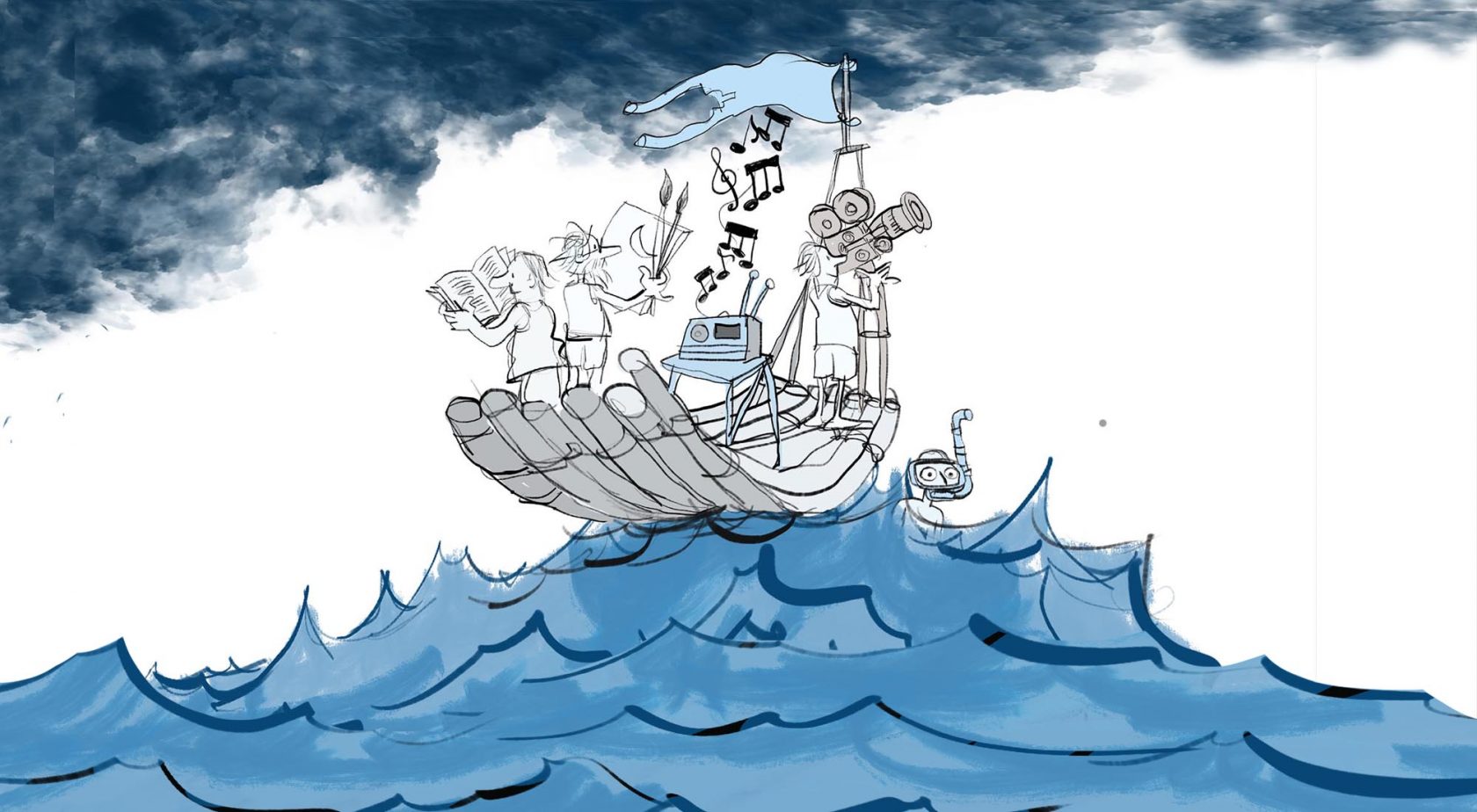
Un progetto della Fondazione Federica Spitzer sulla diaspora balcanica nel Canton Ticino
 Si inaugurerà mercoledì 3 maggio a Locarno il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Federica Spitzer, che dopo la creazione del Giardino dei Giusti al Parco Ciani di Lugano e le ricerche di “Lugano città aperta” si concentra sui rapporti tra i Balcani e la Svizzera italiana. Al centro di uno studio di Pietro Montorfani, di cui riproduciamo in anteprima le pagine iniziali, gli stretti legami tra le popolazioni della ex Jugoslavia e la realtà ticinese, esempi virtuosi di accoglienza e integrazione riuscita, come è sempre stato nella migliore tradizione elvetica. Maggiori informazioni sulla serata locarnese e sulle attività della Fondazione Spitzer sono accessibili a questo link. [red]
Si inaugurerà mercoledì 3 maggio a Locarno il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Federica Spitzer, che dopo la creazione del Giardino dei Giusti al Parco Ciani di Lugano e le ricerche di “Lugano città aperta” si concentra sui rapporti tra i Balcani e la Svizzera italiana. Al centro di uno studio di Pietro Montorfani, di cui riproduciamo in anteprima le pagine iniziali, gli stretti legami tra le popolazioni della ex Jugoslavia e la realtà ticinese, esempi virtuosi di accoglienza e integrazione riuscita, come è sempre stato nella migliore tradizione elvetica. Maggiori informazioni sulla serata locarnese e sulle attività della Fondazione Spitzer sono accessibili a questo link. [red]
Quando chiesero a J.R.R Tolkien dove si trovasse Mordor, la terra dell’Oscuro Signore nella geografia fantastica del Signore degli Anelli (1955), rispose senza esitazione «da qualche parte nei Balcani». In basso a destra, se si osserva la piantina del continente europeo, così come in alto a sinistra si trovava, al contrario, la verde e pacifica Contea degli amati hobbit, in una zona assai prossima alla sua Inghilterra. Non deve sorprendere, in un uomo che aveva combattuto la prima guerra mondiale e ne era tornato sconvolto nel fisico e nell’animo, che il luogo in cui tutto converge, dove sorge il Monte Fato e dove si decidono i destini di un’intera epoca storica (la Terza Era del suo immaginario universo), potesse situarsi per lui nella penisola balcanica, nella zona di frizione – sovrapponendo la piantina reale a quella fittizia – di tre ex imperi: quello austro-ungarico, quello russo e quello turco-ottomano. I drammi del Novecento si erano aperti il 28 giugno 1914, con l’attentato di Sarajevo e l’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo da parte del terrorista serbo Gavrilo Princip, e a Sarajevo si sarebbero chiusi ottant’anni più tardi, con un terribile colpo di coda che avrebbe riportato in auge i mai sopiti nazionalismi del secolo precedente.
Questo piccolo libro, nella speranza che non risulti troppo ambizioso, ha lo scopo di dare voce alla diaspora balcanica nella Svizzera italiana degli anni Novanta: di permettere cioè ai lettori svizzeri di oggi di capire chi erano e chi sono quelle persone che hanno iniziato ad affollare in massa i loro confini chiedendo di essere accolti e aiutati. Per lungo tempo, ancora ben dentro gli anni del conflitto (1989-99), la stampa ticinese ha continuato a utilizzare il nome generico di jugoslavi, mentre chi fuggiva dalla guerra si sentiva oramai quasi soltanto croato, serbo, bosniaco, macedone, kosovaro, montenegrino. Lo sfaldarsi di una nazione da più parti ritenuta “sbagliata” ha avuto ripercussioni, infatti, sull’intero continente europeo e la questione, per gli storici come per chi osservi la cronaca di questi giorni tormentati, è lungi dal ritenersi conclusa. Se è stato possibile, per la maggior parte dei rifugiati di origine balcanica rimasti in Ticino, ricostruirsi con il tempo una vita di pace e serenità, si deve al loro impegno non meno che alla disponibilità e all’accoglienza del Paese ospite.

Memoriale del massacro di Srebrenica (Potočari) in ricordo delle oltre 8000 vittime musulmane
«Unità e fratellanza» («Bratstvo i Jedinstvo»): non c’è nulla di più lontano dall’attuale conformazione geopolitica dei Balcani dello slogan coniato da Josif Brodz “Tito” (1892-1980), il presidente che per quarant’anni era riuscito a tenere assieme i molti popoli e le molte culture della Repubblica federale. Allineato su posizioni filo-sovietiche fino al giugno del 1948, quando si staccò dall’URSS con una violenta epurazione dei principali stalinisti jugoslavi, inaugurò in seguito un comunismo sui generis basato su elementi di comprovata efficacia (il partito unico, il controllo dell’opinione pubblica, un’economia pianificata) e su alcune varianti più morbide rispetto alla realtà politica dell’Unione Sovietica, soprattutto nei confronti degli aspetti culturali delle varie etnie che componevano la Jugoslavia. La vita spirituale, per citare un esempio significativo, non era proibita ma semplicemente confinata nella sfera individuale. Nella sua visione, più pragmatica che ideologica, la fede non poteva e non doveva diventare un problema. Con il senno di poi è facile dire che la versione titina del comunismo era poco più di un coperchio appoggiato sopra una pentola in perenne ebollizione. Da un lato si concedevano alcune autonomie (ad esempio alla regione del Kosovo rispetto alla Serbia) e dall’altro si favoriva l’identificazione con un’idea comune di nazione basata sul marxismo, la resistenza, i partigiani della seconda guerra mondiale e il contenimento dei movimenti estremisti degli ustascia croati e dei cetnici serbi. «Unità e fratellanza», quindi, anche a costo di imporle con la forza e con la repressione dei non allineati.
Grazie a questa narrazione il mondo, se non gli stessi jugoslavi, per quarant’anni si è dimenticato che i Balcani non erano soltanto una regione tra le tante del continente europeo, ma il luogo in cui le placche storiche del cattolicesimo, dell’ortodossia e dell’islam si erano sfregate per secoli in un continuo mescidarsi di popoli e di culture. Non già però come fronti contrapposti disegnati con squadra e compasso – l’Europa non nasce come gli Stati Uniti o l’Africa coloniale – bensì a macchie di leopardo, soprattutto in Croazia e Bosnia, quasi fossero il deposito di materiali lasciati indietro da lenti ma continui movimenti tellurici. Alle sensibilità etniche, religiose e culturali si sommavano, nella Jugoslavia di Tito, le resistenze alla politica del partito unico e più in generale all’ideologia comunista, ragione per la quale è sempre esistita una diaspora verso le altre nazioni europee o gli Stati Uniti. Si pensi alla famiglia del poeta Charles Simić (1938-2023), nato a Belgrado con il nome di Dušan e divenuto poi una delle voci più significative della letteratura americana del Novecento. In Svizzera l’esempio più noto è forse quello dell’editore e scrittore serbo Vladimir Dimitrijević, fondatore nel 1966 a Losanna della casa editrice “L’Àge d’homme”, che in trent’anni avrebbe pubblicato molti classici, antichi e moderni, della letteratura slava, contribuendo a diffondere in Occidente capolavori messi all’indice in Unione Sovietica come Vita e destino di Vasilij Grossman. Al mito jugoslavo non riescono comunque a rinunciare molti dei rifugiati giunti in Ticino tra gli anni Sessanta e i primi Novanta, tra l’epoca degli stagionali e le prime fughe dai teatri di guerra: «Sono svizzero, e sono jugoslavo» è la risposta che si sente spesso alla domanda «Chi sei tu oggi?». Alcuni, di etnie ed estrazioni sociali molto diverse, aprono sul tavolo una piantina della Jugoslavia coperta di brand – centinaia di marche che l’economia pianificata aveva distribuito in ogni angolo del Paese, ora in gran parte scomparse – un’immagine che ben condensa questa realtà ibrida tra comunismo e “capitalismo” all’occidentale, una Patria che non esiste più se non nella memoria di chi continua a ricordarla con malinconia.
Nonostante il quadro idilliaco offerto dalla propaganda del partito, sin da prima della morte di Tito, avvenuta nel maggio del 1980, le difficoltà economiche in Jugoslavia non mancavano, soprattutto in alcune regioni del centro e del sud (Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Serbia meridionale). A partire dalla fine degli anni Sessanta molti lavoratori jugoslavi hanno sfruttato così lo statuto di stagionali per venire in Svizzera: erano medici, infermieri, fisioterapisti, ma anche manovali attivi nell’edilizia, camerieri e ristoratori. Anno dopo anno, si sono affiancati all’immigrazione italiana, spagnola e portoghese che contraddistingueva all’epoca il mondo del lavoro elvetico, specie nella Svizzera tedesca e francese, anche se non mancavano esempi consistenti pure a sud delle Alpi. È in questo contesto, grazie a datori di lavoro importanti come la Monteforno di Bodio, l’ospedale di Faido o il nuovo cantiere autostradale del San Gottardo, che la presenza jugoslava è cresciuta e si è consolidata, non a caso, soprattutto in Leventina. Lì è nato, attorno all’albergo e alla mensa della famiglia Barudoni, il primo club jugoslavo del Ticino, intitolato all’eroe partigiano Ivo Lola Ribar (1913-43), braccio destro di Tito ucciso durante la seconda guerra. A partire da quella prima forma associativa è nata in seguito una squadra di calcio con un nome (FK Drina) che era un omaggio alla tradizione multietnica dei Balcani: resa celebre dal romanzo del Premio Nobel Ivo Andric, la Drina è il fiume che separa e unisce la Serbia e la Bosnia, teatro di scontri e veicolo di scambi proficui sull’arco di tanti secoli.
La comunità jugoslava del Canton Ticino, che era solita organizzare negli anni Ottanta feste annuali al Padiglione Conza di Lugano con molte centinaia di persone, non sopravvisse intatta purtroppo ai conflitti degli anni Novanta, che riaccesero in modo violento le tensioni etniche. La frammentazione in varie associazioni, club e squadre sportive divise per etnia è una caratteristica infatti della presenza balcanica in Ticino a partire dal 1991, un quadro che si è vieppiù complicato e che soltanto in tempi recenti ha cominciato piano piano a ricomporsi grazie a collaborazioni tra gruppi e iniziative comuni. Il modello svizzero di convivenza, pur con qualche inciampo e inevitabile fatica, sembra avere avuto la meglio sulle divisioni ereditate dai Paesi d’origine.
Il susseguirsi delle guerre che hanno infiammato la regione per un decennio, dapprima tra Croazia e Serbia (1991-95), poi in Bosnia (1992-95) e infine in Kosovo (1998-99), ha avuto quale esito in Ticino altrettante ondate migratorie unite a piccole o grandi crisi umanitarie, a cui le istituzioni e la società ticinese hanno risposto, in genere, in modo adeguato. Non sono mancati momenti di tensione, come il rifiuto delle autorità federali di accogliere a Chiasso i rifugiati bosniaci privi di visto nel dicembre del 1992, o il loro rimpatrio in massa nell’agosto del 1997, o ancora l’invito del Comune di Ascona a non assumere più croati negli alberghi; ma nel complesso, come è sempre stato nel suo DNA, il Ticino ha saputo rispondere “presente” grazie allo sforzo congiunto dell’amministrazione cantonale e della Protezione civile, di Comuni, Parrocchie, Scuole, Sindacati, Associazioni e istituzioni umanitarie come Caritas o SOS Ticino, senza dimenticare i numerosi privati (compresi quelli della diaspora) che non se la sono sentita di restare con le mani in mano di fronte al grido disperato che giungeva continuamente dai Balcani. La durata decennale delle crisi ha messo a dura prova l’entusiasmo della popolazione, che si è concentrato soprattutto nel momento iniziale (1991-92) e in quello finale (1998-99), ma che nonostante tutto ha saputo lasciare segni concreti, sia in Svizzera che nei paesi di provenienza dei rifugiati: donazioni ticinesi hanno contribuito, tra i tanti esempi virtuosi, a inviare decine di convogli umanitari in Croazia, Bosnia e Kosovo, ad aprire due case di accoglienza per donne vittime di stupro etnico nella regione di Zagabria e a ripopolare la distrutta biblioteca di Dubrovnik. Un abbraccio fraterno che, nel continuo risorgere di incomprensioni e razzismi, rimane un punto fermo nella nostra storia recente.

Come per ogni conflitto, le principali vittime degli scontri, purtroppo, sono sempre i civili (nella foto la cittadina serba di Aleksinac, bombardata per errore dalla Nato il 5 aprile 1999)
Immagini contenute nel volume citato


Cinquant’anni fa la musica dell’Africa subsahariana fa la sua trionfale entrata in scena nelle classifiche, nelle sale e nelle discoteche di tutto il mondo

Con l’addio alle competizioni di Roger Federer si chiude la carriera di uno dei più straordinari protagonisti dello sport mondiale, raccontato anche da grandi scrittori – Con un...