La sconfitta dell’educazione
Centro chiuso per minorenni: significato e rischi di una soluzione anacronistica
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Centro chiuso per minorenni: significato e rischi di una soluzione anacronistica
• – Fulvio Poletti

È quello di Facebook, che in un giorno ha perso in Borsa il 22%: cause dello scivolone e interrogativi. È iniziato il declino del colosso digitale?
• – Aldo Sofia

E pazienza se dopo l’oro in discesa, nel supergigante non c’era più…
• – Libano Zanolari
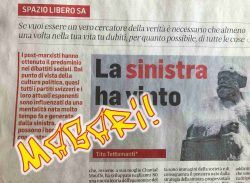
Su una pagina a pagamento la stupefacente tesi dell'Avv. Tettamanti, ma il trucco si vede: dal vanto del cigno al lamento del coyote
• – Silvano Toppi
Votazione del 13 febbraio: il vero pericolo non è affatto l’interferenza dello Stato, bensì la scomparsa delle piccole testate
• – Redazione
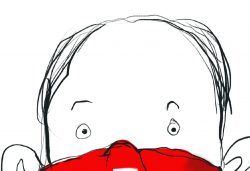
Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

È quello degli Stati Uniti contro Cuba, oggi alle prese con la protesta, ma che è riuscita a salvaguardare la sua indipendenza e i progressi sociali
• – Gianni Beretta

Dai boicottaggi di Marco Chiesa in Ticino alle intimidazioni nella Svizzera tedesca ed ai preparativi di un’iniziativa per dimezzare il canone radiotelevisivo
• – Daniele Piazza
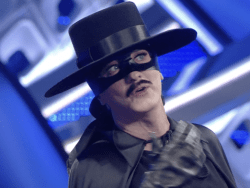
Il costume italiano messo a nudo da chi sa vestire i panni giusti: elogio di Drusilla Foer
• – Enrico Lombardi

Israele lo vuole, e Berna chiude gli uffici per l’aiuto ai palestinesi nella parte araba di Gerusalemme
• – Aldo Sofia

Centro chiuso per minorenni: significato e rischi di una soluzione anacronistica
La storia dell’educazione e della pedagogia, in particolare negli ultimi due secoli e mezzo, si è caratterizzata – attraverso le esperienze, le iniziative e le riflessioni più significative che ha visto la Svizzera protagonista, sin dall’inizio, con personaggi del calibro di Jean-Jacques Rousseau e di Johann Heinrich Pestalozzi – per la costante tensione nel realizzare il ‘Principio di educabilità’.
Filo conduttore di tutto il portato culturale ed esperienziale di questa nobile tradizione della nostra civiltà, tale principio consiste nell’affermare l’inderogabile convincimento e volontà di riportare sul terreno dell’educazione qualsiasi traiettoria esistenziale, anche la più deviante, disastrata e scassata.
Philippe Meirieu, noto pedagogista francese, sintetizza magistralmente il concetto alla base dei vari tentativi psico-socio-educativi: “l’educabilità è innanzitutto il principio ‘logico’ di qualsiasi attività educativa: se non si parte dal postulato che le persone che si vogliono educare sono educabili, è meglio cambiare mestiere. Si tratta di un principio euristico essenziale: soltanto il postulato dell’educabilità dell’altro impedisce all’educatore di attribuire i suoi insuccessi a delle cause sulle quali egli non ha potere e di impegnarsi a fondo nella ricerca di nuove mediazioni. È senza dubbio per questo motivo che le più importanti ‘invenzioni didattiche’ sono state effettuate da coloro che si sono assunti l’educazione delle persone ritenute sino allora ineducabili”.
Proprio alla luce degli innumerevoli sforzi prodotti, costellati da successi ma anche da fallimenti – che comunque non hanno fatto derogare dal principio guida testé evocato –, appare anacronistico ricorrere oggi a “soluzioni” del tipo del CECM, dentro o mediante il quale si cerca di coniugare un po’ avventatamente un mandato contenitivo-repressivo, con un’anima redentiva-riabilitativa. La scommessa, un po’ pretenziosa o presuntuosa, è che il passaggio di tre mesi dentro le mura “rassicuranti” (per tutti noi, vale a dire “per chi sta fuori”) del Centro in questione possa condurre alla normalizzazione del soggetto deviante e riportarlo sulla retta via, pronto a rientrare in società o in qualche altro istituto meno “contenitivo”.
Non è difficile ipotizzare, anzi, prevedere come allorché la struttura fosse approntata essa verrebbe occupata il più possibile, non fosse che per giustificarne l’esistenza e i costi di gestione: in letteratura simile prospettiva viene denominata “sindrome di appropriazione”, secondo la quale un’istituzione (o il sistema al quale essa è agganciata) tende naturalmente alla propria sopravvivenza o autoriproduzione, non di rado inducendo il bisogno, l’esigenza o l’urgenza.
Certo, secondo il rilevamento dei dati raccolti dallo studio, prettamente quantitativo, licenziato da un gruppo di lavoro della SUPSI nel 2017, su un totale di 505 “casi trattati dalle ARP [Autorità regionali di protezione] e dalla Magistratura dei minorenni nel 2015, una cinquantina (53) risulta annoverabile sotto l’etichetta “casi di crisi” per cui si giustificherebbe il ricorso al CECM, secondo tre categorie classificatorie: “urgenza”, “gravità”, “rifiuto”. Sempre dai dati raccolti dallo studio emerge che “nell’86,8% dei casi i giovani si trovano confrontati con un contesto famigliare assente o problematico”, mentre sul fronte della formazione e del lavoro il quadro che emerge fa stato di un “85% dei casi che vive una situazione di disadattamento, di insuccesso o di abbandono”. Pertanto, nelle conclusioni si giunge a sostenere che “due delle dimensioni cardine per lo sviluppo dell’identità personale e dell’integrazione nella società, quali lo sono la Famiglia e la Formazione/Lavoro, risultano essere assenti, problematiche, fonte di frustrazioni e insuccesso”.
Se questo risulta il contesto di riferimento, mi chiedo se il collocamento in un centro chiuso per tre mesi possa riconfigurare un paesaggio psico-sociale così compromesso e dare la forza e lo slancio per proiettarsi in una progettualità esistenziale palingenetica di riscatto personale e di integrazione socio-formativa/professionale.
Vi è piuttosto il rischio che la rabbia, la riottosità e la frustrazione, invece di attenuarsi e incanalarsi in una direzione pro-positiva, si traduca in un incremento di rancore e rifiuto delle regole del gioco, a seguito anche della rappresentazione stigmatizzante di aver frequentato un luogo segregativo e connotato socialmente da una valenza non di certo valorizzante. L’etichettatura nell’esser passati attraverso un istituto denominato in quel modo, andrebbe ad accumularsi a tutta una serie di altri fallimenti o collocamenti, incrementando il proprio “dossier” di soggetto orientato al tralignamento, se non addirittura alla devianza e alla delinquenza.
È mai possibile che per ragazzi di 12-18 anni, la soluzione più idonea che si ritiene di mettere in atto, nel 2022 e alle nostre latitudini, sia una traiettoria del genere? Sarebbe stato altresì interessante e utile per comprendere il fenomeno che si intende arginare, prestare ascolto alla viva voce dei diretti interessati, per coglierne le posizioni, i vissuti e i retroterra. Essi, invece, sono stati descritti, interpretati e spiegati da altri (dagli specialisti) e soprattutto appaiono, nei documenti ufficiali o formali sottoposti ai decisori, in forma di numeri o di “casi”.
Per rassicurare gli animi, d’altra parte, si avanza l’argomentazione che il CECM sarà attivato solo in casi estremi, ma quando si parla di “ultima ratio” – a parte la deriva della propensione alla “sindrome d’appropriazione” citata sopra – dovremmo porci l’interrogativo: ma siamo poi sicuri che tutto il sistema di prevenzione e di azione/intervento relativo all’infanzia e all’adolescenza funzioni al meglio nella nostra realtà cantonale? Il tanto decantato “lavoro di rete” consente veramente una presa in carico adeguata delle difficoltà nella crescita e nel rapporto con il mondo dei nostri ragazzi di 12-18 anni? Oppure non manifesta tuttora qualche falla e maglia rotta, tanto da non rendere così fluida ed efficiente l’attivazione di risposte adeguate a situazioni sicuramente assai ardue cui far fronte? Non sono d’altronde così ingenuo da credere che non vi siano dei casi veramente difficili da affrontare e da gestire, per i quali mi chiedo però, tenuto conto dell’esiguità dei numeri e del margine migliorativo che sempre sussiste nel funzionamento delle strutture esistenti, se invece di creare un complesso istituzionalmente così consolidato come quello in oggetto, non sia più idoneo avvalersi di strutture in Svizzera interna o in Italia, come si sta già facendo con successo. Invece di investire 6,4 milioni di franchi (metà a carico del Cantone) per l’edificazione di un Centro chiuso, si potrebbero utilizzare questi soldi per finanziare progetti e iniziative volti a consolidare il sistema di prevenzione (per esempio il SAE-Servizio di sostegno e accompagnamento educativo) e al potenziamento dei CEM-Centri educativi per minorenni (iniettandovi nuove risorse, come meriterebbero, così d’avere un maggior margine di manovra ed occuparsi, fra l’altro, delle conseguenze “pesanti” di due anni passati in emergenza, con i loro strascichi per le frange più fragili della popolazione) e di tutte le altre misure accompagnatorie che in questi anni hanno dato buoni frutti nell’affrontare le emergenze e il disagio giovanili, compreso quello di ordine psichiatrico.
Un esempio virtuoso è costituito dal Progetto Tipì – Promozione di una cultura condivisa dell’infanzia, teso a valorizzare le risorse, le capacità e le competenze delle famiglie nell’accudimento dei figli, con una sinergica collaborazione e co-responsabilità educative instaurata fra culture familiari e culture istituzionali (mediante il coinvolgimento di tutti i principali partner del territorio), in maniera da creare condizioni favorevoli alla crescita e al dispiegamento massimo delle potenzialità dei cittadini di domani. Credo che questo sia il miglior approccio e la più idonea metodologia da adottare per cercare di rispondere al meglio ai fenomeni socio-educativi più impellenti.
Mi conforta il pensiero che quasi 500 persone, in gran parte operatori sociali, dunque degli addetti ai lavori che conoscono bene il settore in causa, abbiano firmato una petizione contraria al CECM: leggo questo dato come segno di disponibilità e volontà ad impegnarsi nell’escogitare altre soluzioni e a trovare strade operative ben diverse per affrontare i problemi dei nostri giovani. Di quanti spazi e occasioni dispongono per stare insieme, per aggregarsi attorno a una progettualità che consenta di esprimere la loro vitalità ed espandere la propria personalità? Certo, la sicurezza in un successo per ogni “caso” o soggetto non c’è mai, ed è proprio questa la grande sfida: la drammaticità e insieme lo straordinario fascino dell’impresa educativa.
Ma occorre perlomeno impostare bene le premesse per la sua ideazione e realizzazione, perché francamente non credo si vada molto lontano con un corollario linguistico-concettuale del tipo: Centro [educativo?!] chiuso, contenzione (con tanto di corredo di cinghie ai letti per l’applicazione di questa pratica, anche se poi, ultimamente, ci si è accordati nello stralciarla almeno nominalmente dal rapporto conclusivo della Commissione parlamentare incaricata di esaminare il Messaggio relativo al CECM), misure restrittive della libertà dei minorenni, misure disciplinari, pene di privazione della libertà di breve durata … che ricalca una certa terminologia in voga qualche anno fa nel settore scolastico allorché ci si riferiva a sedicenti “ragazzi ingestibili”: un vero e proprio ossimoro educativamente parlando, proprio per il principio di educabilità cui si è fatto accenno all’inizio di questo scritto.
Questa armamentario terminologico-concettuale informa inevitabilmente l’intero assetto architettonico (murario e logistico) ed “ideologico” alla base dell’idea progettuale in discussione e vi permane anche allorché si procede a smussarne i toni semantici e linguistici, addolcendo o togliendo talune nomenclature.
I giovani “in crisi” o “in opposizione” non hanno bisogno di strutture in cemento armato come risposta al loro disagio o disadattamento, e nemmeno di interventi muscolosi ‘manu militari’ a suon di ruspe. In effetti, i “rifiuti” e gli “scarti” possono dare origine a risultati assai promettenti se ascoltati, percepiti inclusivamente e minimamente valorizzati: “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” (De André).
Oggi, le nuove generazioni meritano qualcosa di più, soprattutto in momenti sicuramente non facili come questi, dove esse hanno sofferto più di altre categorie, dando peraltro prova – in gran parte più degli adulti – di notevole senso di responsabilità.
Come sosteneva uno dei giuristi più acuti del secolo scorso, il tedesco Carl Schmitt, non è durante i tempi usuali/normali, bensì nei periodi di crisi eccezionali che si manifesta la vera stoffa, la qualità, “il profilo più acuto” della classe politica, chiamata a dar prova di lungimiranza progettuale e originalità creativa nel trovare risposte coraggiose e soluzioni nuove.
Politica e pedagogia possono ritrovarsi soprattutto sul terreno dell’utopia, vale a dire nell’alleanza facente leva sulla speranza, come suggerisce il pedagogista Jean Houssaye, pronunciatosi in un recente convegno tenuto a Roma:
“È l’utopia che genera, nutre e fa sbocciare le dottrine pedagogiche. (…) Qui la politica e la pedagogia si ritrovano insieme: come pensare e fare senza proporre alternative? Come limitarsi ad accettare solo ciò che è? Come non insorgere quando si è responsabili? Come non rassegnarsi a rassegnarsi? Come non accontentarsi dell’efficacia relativa di ciò che è? Ritrovando e portando con sé la speranza, perché la speranza significa che dietro ogni realtà ci sono altre possibilità che possono essere liberate dalla prigione dell’esistente. Non è forse questo il senso sia dell’atto politico che dell’atto pedagogico? Non è forse questo il senso della possibilità e dell’urgenza di ciò che li lega? Che fare, in questo caso? Quali punti di riferimento possiamo darci?”
Fulvio Poletti è pedagogista


In un susseguirsi di comunicati e di prese di posizione, tiene banco, nella cronaca politica, il misterioso “caso” dell’incidente automobilistico che ha avuto per protagonista...

Le tattiche per neutralizzare le iniziative scomode sono sempre le stesse. Funzioneranno anche questa volta?