La scuola, le riforme e la trappola dell’’individualismo
Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”
• – Saverio Snider
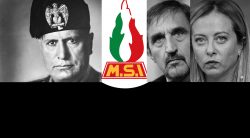
Di certo non “dialoga” con la letteratura scientifica che conferma il ruolo dello Stato nei processi e nei progressi economici del modello capitalista
• – Paolo Favilli

Gli interessi strategici statunitensi non mettono certo l’Europa al primo posto. E l’Europa, di fronte alla guerra, si ritrova sempre più divisa
• – Redazione

Quella mancante, quella pelosa, quella balorda
• – Silvano Toppi

Giustizia sociale e giustizia ambientale devono misurarsi anche e forse soprattutto con un riorientamento delle priorità socioeconomiche
• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

In una serata televisiva dedicata ai 90 anni della Radio si è visto e sentito un po’ di tutto, senza capire bene cosa e perché
• – Enrico Lombardi

Quando andare a votare è e rimane il male minore, ma occorre anche considerare che la politica la si può fare andando oltre i partiti
• – Andrea Ghiringhelli
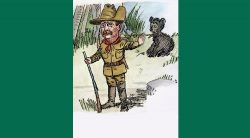
Il problema è che hanno ragione tutti e due. E proprio per questo la faccenda è complicata
• – Redazione

Il caso Credit Suisse, Too big per non dover rispondere della incredibile malagestione manageriale
• – Redazione

Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”
In quest’ottica, il garbuglio delle idee si trasforma in groviglio dei modelli di riforme o controriforme, e l’elenco e la valutazione delle soluzioni proposte si sfilacciano in maniera persino sconcertante, allontanando i contendenti invece di avvicinarli nella ricerca di qualche intelligente punto di incontro e condivisione. Intanto – come ha giustamente sottolineato Adolfo Tomasini in un suo bell’ articolo pubblicato in questa sede – la scuola appare oggi sempre di più come il “cimitero dell’entusiasmo e della passione”, anche perché lo scopo di chi la frequenta, cioè i nostri ragazzi, non è ormai più quello di imparare, bensì quello di ottenere tecnicamente la promozione, per la buona pace dei pressanti e ansiosi genitori. Di fronte a questa realtà disquisire attorno alle varianti dell’inclusività (parità delle opportunità o equità dei risultati?) appare cosa dottamente interessante, ma certo non scioglie determinati nodi concreti cui siamo confrontati.
E al riguardo penso innanzitutto (con riferimento particolare agli ultimi tristi dodici anni di conduzione bertoliana del Dipartimento preposto) all’affermarsi verticistico nell’apparato della burocrazia di una pedagogia – come ci ha insegnato lo storico Adriano Prosperi – “che ha distaccato una presunta scienza del saper insegnare dalla conoscenza di ciò che si insegna”. E si sa che invece – come ricordava un altro grande studioso, Delio Cantimori – “il pane del sapere può essere spezzato e distribuito solo da chi sa impastarlo”.
Poi penso ai rapporti sempre più tesi fra due cosiddette “componenti della scuola”: genitori e insegnanti. Chi ha abbastanza anni sulle spalle per conoscere un po’ la storia tribolata di tale dialogo nel nostro Paese, non può che guardare con apprensione alla sua evoluzione e allo stato attuale delle cose. Il fatto è che sono mutate molto nel frattempo le attese, le sensibilità, le velleità. Una volta (sino almeno a quarant’anni fa) le famiglie affidavano i loro figli alla scuola senza metterci il becco più di tanto, perché c’era una sostanziale condivisione dei valori e della bontà e dell’utilità delle conoscenze che venivano trasmessi nelle aule.
C’era insomma, in termini non diversi, una forte fiducia corale nell’istituzione e in chi la rappresentava in trincea, nel segno pure della consapevolezza della necessità d’avere un senso d’appartenenza a una comunità. Il progressivo ma tenace dilagare negli ultimi decenni del pensiero liberista (che è una vera filosofia generale di vita, non riconducibile – come purtroppo si tende a credere – alle sole sfere della politica e dell’economia) e che è costruita sulla predominanza dell’individualismo, ci ha portati al patatrac: ognuno per sé e ognuno contro tutti. Un ripiegamento (negli anni Ottanta si chiamava “riflusso”) sul privatissimo orticello delle proprie illusioni di superiorità (scambiata per libertà). Va da sé che la scuola e chi vi opera, così come è stata creata e man mano costruita, non poteva che diventare un nemico, non un alleato: un ostacolo al necessario primato del singolo.
Ricette non ne ho per risolvere la situazione, se non quella di riuscire a cambiare semplicemente la testa dell’ormai maggioranza delle persone; impresa che, pensando alla scuola, non riuscì, ai suoi tempi, nemmeno a quella eccezionale ed esemplare personalità che fu don Milani.


Criticato da molti per la sua posizione lontana dai centri, il Tribunale penale federale di Bellinzona compie 20 anni

Politica e politici bicefali, fra strabismo e schizofrenia