Sul nazionalismo ucraino: realtà e preconcetti (Prima parte)
Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice
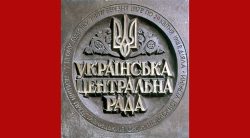
Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
• – Yurii Colombo

Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”
• – Saverio Snider
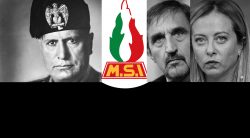
Di certo non “dialoga” con la letteratura scientifica che conferma il ruolo dello Stato nei processi e nei progressi economici del modello capitalista
• – Paolo Favilli

Gli interessi strategici statunitensi non mettono certo l’Europa al primo posto. E l’Europa, di fronte alla guerra, si ritrova sempre più divisa
• – Redazione

Quella mancante, quella pelosa, quella balorda
• – Silvano Toppi

Giustizia sociale e giustizia ambientale devono misurarsi anche e forse soprattutto con un riorientamento delle priorità socioeconomiche
• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

In una serata televisiva dedicata ai 90 anni della Radio si è visto e sentito un po’ di tutto, senza capire bene cosa e perché
• – Enrico Lombardi

Quando andare a votare è e rimane il male minore, ma occorre anche considerare che la politica la si può fare andando oltre i partiti
• – Andrea Ghiringhelli
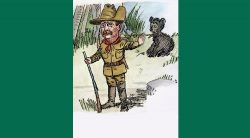
Il problema è che hanno ragione tutti e due. E proprio per questo la faccenda è complicata
• – Redazione

Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
Tuttavia separare le contraddizioni della vicenda degli ultimi anni dal rapporto tra Ucraina, impero zarista e Urss è un’operazione chirurgica per molti versi ambigua. Non è quindi un puro esercizio intellettualistico, a mio avviso, realizzare un piccolo detour di oltre un secolo per comprendere cosa stia succedendo oggi.
Non è un caso che l’ormai celebre discorso di Putin pochi giorni prima della guerra, fu un’arringa che ricostruiva la storia delle relazioni russo-ucraine, tornando indietro perfino di alcuni secoli. Ci limiteremo inevitabilmente qui all’essenziale, proponendo poi una bibliografia per chi volesse approfondire alcuni passaggi.
In primo luogo si è formata l’idea (non solo recentemente) che l’Ucraina sia stata e sia solo una “piccola Russia” o una “Russia del Sud”, il cui afflato indipendentista lungo due secoli sia stato solo il prodotto di pochi intellettuali e interessi regionali.
Naturalmente i legami politici, sociali e culturali tra le due realtà sono stati molti intensi e hanno avuto tendenza a sovrapporsi in alcune fasi storiche; tuttavia non sono mai stati univoci o coincidenti.
A determinare questo approccio alla questione nazionale ucraina non ci pensarono soltanto gli storici dell’autocrazia, ma anche Friedrich Engels e Rosa Luxemburg. Il primo riteneva che tra i popoli dell’est Europa gli unici che potessero pensare di diventare indipendenti fossero l’Ungheria e la Romania. Gli altri erano niente più che “popoli senza storia”, destinati ad essere la quinta colonna della reazione austro-ungarica, o anche zarista.
La storia è stata impietosa con questa impostazione “deterministica”, e il più grande marxista ucraino, Roman Rosdolskij, si incaricò di dimostare quanto anche gli studiosi più acuti a volte possano cadere in fallo. Rosa Luxemburg, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, per eccesso di internazionalismo, cadde nella stessa trappola di Engels, giungendo a sostenere, contro l’opinione di molti altri socialisti polacchi, che addirittura l’indipendenza polacca dallo Zar fosse insensata perchè avrebbe distratto il proletariato dai suoi compiti di emancipazione sociale: la questione nazionale era per lei solo un fastidioso lascito delle rivoluzioni del 1848, da archiviare rapidamente.
Nella sinistra solo l’anarchico Michail Bakunin sostenne la creazione di una “confederazione democratica slava”, intesa in chiave libertaria e antimperiale.
All’inizio del secolo scorso, il nascente movimento operaio sia nella “Russia meridionale” sia nella zona galiziana assunse i temi dell’autedeterminazione ucraina: basti ricordare che Ivan Franko, uno dei più grandi scrittori su scala mondiale dell’inizio del Novecento (candidato al Premio Nobel) promosse per tutta la sua vita una visione che mettesse insieme la liberazione ucraina e un socialismo ingenuo ma vigoroso, segnato da tinte proudhoniane.
La rivoluzione di febbraio del 1917 in Russia non fece che accelerare le tendenze prima autonomiste e poi indipendentiste a Kiyv, con la formazione della “Rada centrale ucraina”, il parlamento ucraino. Quest’ultimo avanzò rivendicazioni sempre più radicali: i principali dirigenti della Rada (parlamento monocamerale ucraino), e in primo luogo il suo presidente Volodomyr Vinničenko, baluginavano un socialismo maggiormente legato alle tradizioni dell’Europa Occidentali che a quelle bolsceviche.
Inoltre durante la guerra civile russa, che insanguinò il paese dal 1918 al 1921, e che si svolse in gran parte in Ucraina, emersero potenti movimenti di guerriglia contadina, che, come nel caso di quello anarchico di Nestor Makhno, assunsero lineamenti libertari e anticentralisti, assieme alla rivendicazione (non statalista) della cultura e delle tradizioni ucraine.
Nell’immagine: Targa commemorativa sull’edificio degli insegnanti (ex Liceo pedagogico) a Kiev, dove dal marzo 1917 all’aprile 1918 si trovava la Central Rada


Un governo con una minoranza che diventa maggioranza non resterà tale a lungo: già partiti gli attacchi e scatenate le ambizioni di possibili prossimi consiglieri federali

Le lingue di fuoco che avanzano velocemente, le distruzioni in uno scenario lunare, anche noi pronti ad evacuare. La testimonianza diretta di una collega della redazione di...