Sul nazionalismo ucraino: realtà e preconcetti (Seconda parte)
Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
Filtra per rubrica
Filtra per autore/trice

Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
• – Yurii Colombo
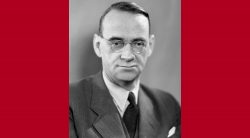
Il parlamento americano assegna il massimo riconoscimento civile al “piccolo console” svizzero che a Budapest salvò migliaia di ebrei, e che la Svizzera contrastò e poi ignorò a lungo
• – Aldo Sofia

Le elezioni di quest’anno ripetono vecchi scenari socialisti, fatti di litigiosità e faticoso pluralismo
• – Fabio Dozio
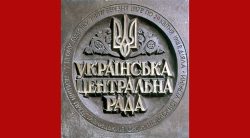
Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
• – Yurii Colombo

Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”
• – Saverio Snider
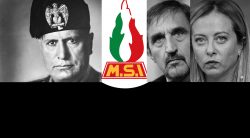
Di certo non “dialoga” con la letteratura scientifica che conferma il ruolo dello Stato nei processi e nei progressi economici del modello capitalista
• – Paolo Favilli

Gli interessi strategici statunitensi non mettono certo l’Europa al primo posto. E l’Europa, di fronte alla guerra, si ritrova sempre più divisa
• – Redazione

Quella mancante, quella pelosa, quella balorda
• – Silvano Toppi

Giustizia sociale e giustizia ambientale devono misurarsi anche e forse soprattutto con un riorientamento delle priorità socioeconomiche
• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf
• – Franco Cavani

Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.
Come ebbe invece a sottolineare Michail Gorbačev, l’Ucraina divenne, per una prima volta nella sua storia, non un semplice territorio conteso ma una vera Repubblica autonoma, seppur legata al potere bolscevico.
Nei primi anni del potere comunista, questo punto di mediazione tra centrarlismo e mediazione, funzionò: “l’ucrainizzazione” voluta dai settori più progressivi del partito determinò l’introduzione della lingua nativa nelle scuole, la pubblicazione di migliaia di libri in ucraino, la promozione della cultura nazionale. Un processo che venne tuttavia bloccato dall’ascesa definitiva dello stalinismo.
A tutto ciò si aggiunse la tragedia di ciò che oggi gli ucraini chiamano “Holomodor”: in seguito alla collettivizzazione forzata delle campagne imposta dal regime sovietico a partire dal 1929 si determinarono carestie, deportazioni e repressioni in Ucraina, che provocarono la morte di milioni di contadini. Il numero delle vittime è ancora oggi oggetto di discussione tra gli storici ma resta appunto nell’ordine dei milioni: 1,5 per le stime più conservative, 7 milioni per il governo ucraino. Va anche ricordato che nel 1939 dopo la spartizione della Polonia, anche la Galizia finì sotto il controllo del totalitarismo russo.
Questa pur rapida ricostruzione di quanto successe in Ucraina nella prima parte del XX secolo offre la possibilità di capire in gran parte l’ascesa del nazionalismo di estrema destra dell’Esercito Nazionale Ucraino, che si macchiò della collaborazione con i nazisti e di stragi di polacchi durante la seconda guerra mondiale.
Quindi la stessa decisione di Kruščev del 1953 di cedere all’Ucraina la penisola di Crimea (diventata a maggioranza etnica russa dopo le deportazioni di massa dei Tatari da parte di Stalin) fu dettata non solo da motivi ideologici ma anche come “riparazione” sovietica alle enormi sofferenze subite da quel popolo.
Nel dopoguerra il peso del centralismo russo, seppur attenuato, continuò ad essere un macigno. Basti segnalare che nel 1980, quando a L’viv si riunirono centinaia di giovani per il decennale della morte di Jimi Hendrix, i funzionari del KGB ignari di quanto avveniva nelle subculture giovanili internazionali, pensarono, non a caso, che si trattasse di manifestazioni nazionaliste separatiste!
Nel referendum del 1991, che sancì l’indipendenza ucraina, anche nelle regioni russofone la maggioranza a favore dell’indipendenza fu schiacciante: a Dneprpetrovsk per esempio fu approvata con con il 90,4% dei voti favorevoli, ma anche a Doneck si superò l’80%, mentre solo in Crimea passò di stretta misura con il 54,1%. Qualche anno dopo, nel memorandum di Budapest del 1994, la Russia si dichiarava disponibile a proteggere l’integrità territoriale dell’Ucraina in cambio della cessione a Mosca di tutto l’armamemento nucleare che Kiyv aveva ereditato dall’URSS.
Dunque le “relazioni pericolose” che condussero alla guerra del 2014 che presenta, in parte, persino caratteristiche di guerra civile, hanno radici antiche e venature razziste. A lungo, e non è un segreto, gli ucraini sono stati stati sbeffeggiati con il nomignolo di “kachly” (letteralmente contadino furfante e rozzo).
Molti, potremmo dire anche troppi, presentarono il colpo di Stato realizzato contro Janukovič nel 2014, successivo al “movimento della piazza Maidan” (che comunque non giustifica l’intervento diretto di un paese terzo in un conflitto interno) e la guerra del Donbas, come una “nuova guerra civile spagnola” in cui i separatisti filorussi sarebbero stati i novelli “antifascisti” contrapposti alle varie milizie ucraine di ispirazione neofascista. Niente di più lontando dalla realtà: si confrontarono allora due tendenze già presenti all’interno del paese dai tempi dell’indipendenza; tendenze che guardavano una a Mosca e l’altra all’Unione Europea.
La storia dell’ex Urss produsse l’assopimento (e in taluni casi anche la repressione) di molte questioni nazionali che attraversavano l’Unione dentro un centralismo “grande russo” tracotante e coloniale.
Quando Stalin invitò al Cremlino i suoi marescialli appena vinta la guerra contro i nazisti brindò al “popolo russo” e non a quello “sovietico”, specificando ai suoi interlocutori che lui si sentiva un “russo con origini georgiane”. Un paradosso solo apparente, che chiariva abbastanza bene quali erano le relazioni tra centro e periferia dell’Impero, giunte tragicamente fino ad oggi, come la guerra russo-ucraina ci mostra ogni giorno.
***
Per approfondire questi temi esistono molte ottime letture. Per un quadro generale della storia ucraina vale la pena di orientarsi con il libro di Serhii Plokhy, “Le porte dell’Europa. Storia dell’Ucraina (Mondadori, 2022). Il mio (Yurii Colombo “Svoboda. L’Ucraina dall’indipendenza ad oggi tra Nato e Russia” (Castelvecchi, 2022) fornisce un quadro della storia più recente dell’Ucraina, schierato ma a detta di molti equilibrato. Roman Rosdolsky, “Engels e la questione dei “popoli senza storia: la questione nazionale nella rivoluzione del 1848-1849 secondo la visione della Neue Rheinische Zeitung” (Graphos, 2005) è uno straordinario studio scritto nell’immediato secondo dopoguerra, ed apre la strada alla compresione della questione Ucraina nella sinistra marxista e non solo. Infine la recente traduzione di un importante pamphlet di Ivan Dzjuba (“La russificazione in Ucraina” (traduzione e cura di Oleg Rumyantsev, Aracne, 2021) è un saggio che si colloca a pieno titolo come pioniere di quella scuola “post-coloniale”, ormai celebre non solo in campo accademico, che permette di avere un quadro di sintesi ma decisivo sui rapporti centro-periferia tra i due paesi slavi coinvolti nell’odierna guerra.
Nell’immagine: bambini vittime dell’Holodomor


Fra globalizzazione, populismi e sovranismi, la democrazia liberale è chiamata a fornire valide alternative alle derive demagogiche di questi anni

Liquidazione di patrimoni ideali e operazioni chirurgiche da bassa macelleria