Nella passata stagione letteraria svizzero-italiana, che ha fornito in verità notevoli prove soprattutto sul versante della “scrittura femminile”, c’è un libro che spicca per qualità ed originalità, oltre che per essere un documento “storico” che racconta molto più di tanti studi e ricerche ( su cui è comunque certamente fondato).
 Si tratta di “Le malorose”, romanzo breve, opera d’esordio di Sara Catella, luganese da anni residente a Berna. Un romanzo che in sostanza è un monologo ( che sembra quasi pronto per essere adattato al teatro) in cui una levatrice bleniese, Caterina Capra, incaricata, nel novembre del 1912, di accudire il prete del villaggio di Cozoneso, vittima di un misterioso svenimento che lo porta all’immobilità e alla perdita della parola, si ritrova, giorno dopo giorno, a raccontare a Don Antonio, della propria attività, quella di far nascere bambini, e della vita delle tante “malorose” costrette ad un’esistenza fatta di sacrifici e di stenti per mettere al mondo creature destinate a soffrire o ad emigrare.
Si tratta di “Le malorose”, romanzo breve, opera d’esordio di Sara Catella, luganese da anni residente a Berna. Un romanzo che in sostanza è un monologo ( che sembra quasi pronto per essere adattato al teatro) in cui una levatrice bleniese, Caterina Capra, incaricata, nel novembre del 1912, di accudire il prete del villaggio di Cozoneso, vittima di un misterioso svenimento che lo porta all’immobilità e alla perdita della parola, si ritrova, giorno dopo giorno, a raccontare a Don Antonio, della propria attività, quella di far nascere bambini, e della vita delle tante “malorose” costrette ad un’esistenza fatta di sacrifici e di stenti per mettere al mondo creature destinate a soffrire o ad emigrare.
Con il passare dei giorni e degli incontri, Caterina sembra riuscire progressivamente a liberare tutta la forza, la determinazione ed anche la consapevolezza che in anni di parti riusciti o finiti male, l’hanno portata a conoscere e vivere il mondo “dal basso”, mentre “in alto” guardava, ogni giorno, il sacerdote, con i suoi dogmi ed i riti che alla donna paiono costantemente sottrarsi alla realtà terrena e terribile del vivere quotidiano, e che in particolare non considerano, per principio e per cultura, l’importanza fondamentale del ruolo delle donne.
Quelle che Sara Catella, nel sottotitolo del volume, chiama “confidenze di una levatrice” sono ben di più: uno spaccato della vita delle nostre valli all’inizio del secolo scorso (e per non pochi decenni ancora) ed una sorta di “manifesto” della condizione femminile, specie a confronto con il ruolo che le viene riservato dalla cultura cattolica del tempo; una narrazione che non può certamente lasciare indifferenti, anche in virtù di una misuratissima ed efficace scelta linguistica e stilistica, che ci fa ascoltare la “voce” di Caterina attraverso un procedimento di mescidanza fra italiano e dialetto assolutamente coerente e sorvegliatissimo, con l’effetto di un ulteriore grado di coinvolgimento.
“Le malorose” è un monologo che diventa “corale”, che descrive una condizione di vita ampiamente condivisa da tante donne ( come quelle ritratte dal fotografo Donetta nell’immagine in copertina) e che sa parlare anche e forse soprattutto oggi, di una realtà femminile che ancora cerca, legittimamente (e non solo verso l’istituzione ecclesiastica) la propria giusta emancipazione, il ruolo paritario che le spetta.
Dal volume proponiamo qui un breve estratto:
Li conosco io quei corpi piccini di bambini che si spengono, come le candele quando soffi. ‘Pena che sono usciti dai ventri caldi, con di manìn pinìn pinìn, che si muovono appena, e i pescin anche. Dopo tre minuti, due ore, o giusto quei venti minuti, non c’hai più niente. Una massa rosa e molle, il peso di un panetto di burro che per pietà giri su in un telo. Poi c’hai la madre a cui badare. Ti trovi nello stesso posto da ore, a volte una stalletta o un cucinino, con l’aria irrespirabile. È un tanfo che non ti molla più, è un misto di terra e sangue. Alla fine, le pezze di lino e cotone sono tutte rosse. Il peggio per me è veramente quell’odore, l’è la pestilenza dei corpi che soffrono… ancora un sussurro, poi un respiro moribondo, lo riconosci sempre quando è l’ultimo.
Poi c’è il dopo, tutto quello che arriva col poi.
I padri, il gusto amaro della loro rabbia, gli uomini che reclamano qualche cosa. Parolacce urlate dalle gole secche e pestilenziali degli uomini che hanno atteso al bistrò… Miseria e desolazione, quante volte devo dire che no, gh’è nagot. Non c’è niente di vivo, e là tutto diventa infernale.
Cribbio don Antonio. Io non mi ricordo di avervi visto da vicino in quei momenti lì. O no? Signor curato rispondete?
Vi ho già raccontato della volta, quando uno di quei fantìn l’ho strappato fuori con queste mie mani qua? Alora l’eva inscì: la partoriente era ancora in pieno travaglio, anche dopo aver bevuto la mama dra ségra, stava così da un giorno e una notte. Ha talmente sofferto, non le è riuscito di spingerlo fuori … e sì che quel beverone alle volte può far miracoli. Ma in questa donna qui, l’infuso di segale l’eva inutil! Sicür che la creatura in panza, l’eva già un angel! Sicür … ma di sentire quella donna urlare dai dolori … basta!Ho messo la mia mano dentro, su nel ventre della povera diavola! E la testa da quel fantèl, che la ma scivola via. Ci riprovo, ancora dentro fin qui, e finalmente riesco ad infilare un dito nella bocca del pinìn. Io lo sapevo che era già morto e quindi l’ho tirato con tutta la forza! Non ne potevo più di sentire quella donna urlare, malorosa verament!
Che sofferenza. Il suo bambino era morto, ma dietro di lui, n’è uscito un altro vivo!
Don Antonio, alora anche i vicini di casa si tenevano lontano per timore di infettarsi, anche voi prevosto non c’eravate. Eravamo sole, io e lei, e tutti temevano il diavolo. Tante sofferenze non hanno una spiegazione. O no? L’unica miserenda era lei, la madre, il suo corpo sfatto. E quel neonato che ho dovuto tirar giù io a forza, che m’è rimasto nelle dita quel rumore che ha fatto la sua bocca quando s’è spaccata in due. Quel crac, che anche adèss mi tremano le dita se ci penso. Don Antonio, al s’è rott in di mè man.
Ma che vita è la nostra?
Poi però il pianto di quel secondo nascituro, così vivace e imprevisto. Par grazia dal ciel, propi quel dì, ul Signur l’eva lì. Era lì con noi, magari giù per terra come me.
Eccola, mi commuove il ricordo di quando ero lì accucciata. Quel tempo che sembra non finire mai, è un momento che noiatre ci ricorderemo per sempre. Quando incrocio il suo sguardo in paese, so che mi è riconoscente, perché io c’ero.
Tutti pensano che le donne che partoriscono sono impure. Se una donna soffre di parto allora gha c’entra ul Diavul! Io le conosco tutte, ad una ad una, sono la Lucia Neri, la Franca Vescovi, quella di Girondell, la pòra Luisina … Erano donne sane e in gamba. Brave cristiane e sono tutte morte partorendo. Fin che voi, curato, non passate a benedirle, restano donne corrotte.
Ma ditemi un po’, i nostri ventri che si gonfiano, è anche colpa di un uomo, o no? Alora, io dico al sindaco, al dutór, e a te prevosto, ma noi, le donne, cosa abbiamo fatto di male? In quei momenti, già difficili, voi osate trattarci come esseri impuri? Ma come si fa? Misericordia.
Da Sara Catella, “Le malorose – Confidenze di una levatrice”, Casagrande, 2022, pp.30-32








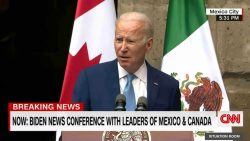

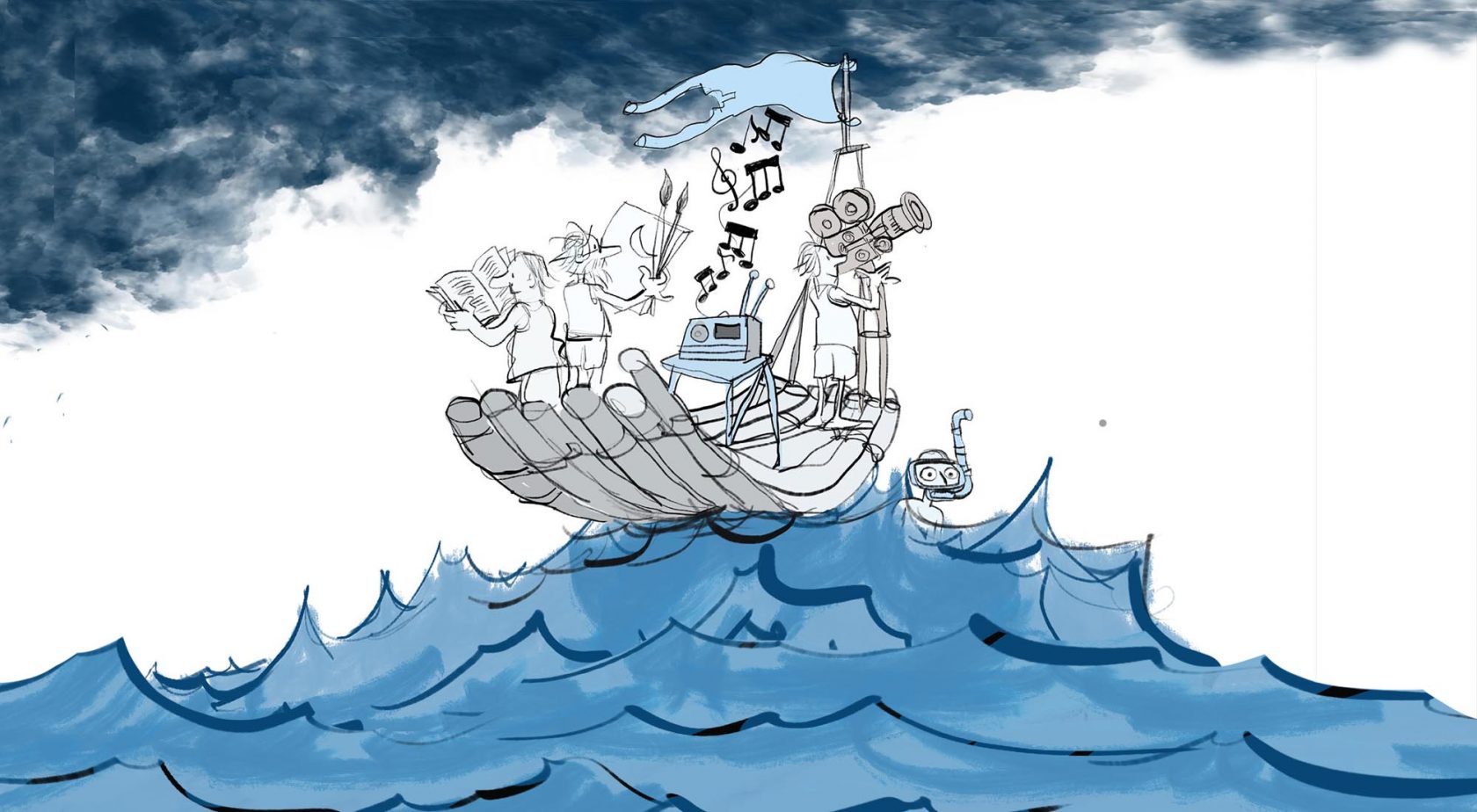
 Si tratta di “Le malorose”, romanzo breve, opera d’esordio di Sara Catella, luganese da anni residente a Berna. Un romanzo che in sostanza è un monologo ( che sembra quasi pronto per essere adattato al teatro) in cui una levatrice bleniese, Caterina Capra, incaricata, nel novembre del 1912, di accudire il prete del villaggio di Cozoneso, vittima di un misterioso svenimento che lo porta all’immobilità e alla perdita della parola, si ritrova, giorno dopo giorno, a raccontare a Don Antonio, della propria attività, quella di far nascere bambini, e della vita delle tante “malorose” costrette ad un’esistenza fatta di sacrifici e di stenti per mettere al mondo creature destinate a soffrire o ad emigrare.
Si tratta di “Le malorose”, romanzo breve, opera d’esordio di Sara Catella, luganese da anni residente a Berna. Un romanzo che in sostanza è un monologo ( che sembra quasi pronto per essere adattato al teatro) in cui una levatrice bleniese, Caterina Capra, incaricata, nel novembre del 1912, di accudire il prete del villaggio di Cozoneso, vittima di un misterioso svenimento che lo porta all’immobilità e alla perdita della parola, si ritrova, giorno dopo giorno, a raccontare a Don Antonio, della propria attività, quella di far nascere bambini, e della vita delle tante “malorose” costrette ad un’esistenza fatta di sacrifici e di stenti per mettere al mondo creature destinate a soffrire o ad emigrare.

